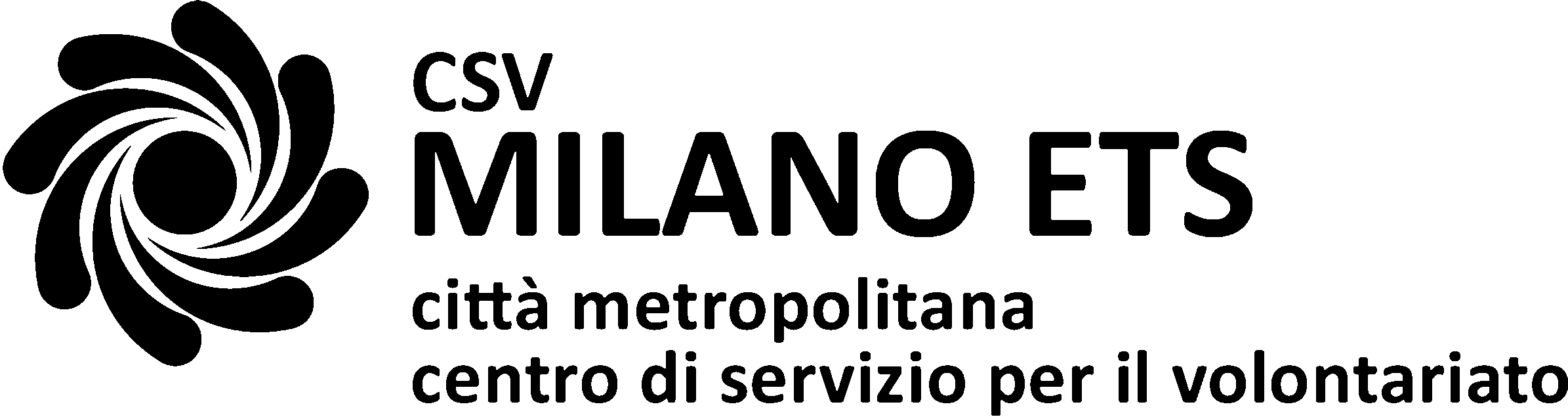Chi sono i giovani d’oggi? Una generazione liquida con un’identità plurima
Yuri Kazepov, professore di politiche sociali a Urbino, spiega che i ragazzi del Terzo millenio sono più flessibili, più dinamici, più aperti a diversità e cambiamenti
di Elisabetta Bianchetti
Milano, settembre 2012 – Professor Yuri Kazepov, da studioso di politiche sociali all’Università di Urbino,nonché tra i fondatori della“rete” interdisciplinare ESPAnet Europa,chi sono i giovani d’oggi? Una generazione che nutre una sfiducia verso la politica, che vive nell’incertezza economica, che fa i conti con la gerontocrazia?
Sicuramente i giovani si caratterizzano per essere sfiduciati, incerti ed entrati in stato di precarietà esistenziale. È una caratteristica della loro età. L’identità si forma attraverso le risposte che riescono a dare all’incertezza. Risposte che si costruiscono sia individualmente sia socialmente. In Italia – più che altrove – quest’incertezza si è estesa a livelli “patologici”. La gerontocrazia li ha relegati in un angolo, in attesa. La costruzione della loro identità affronta un Sicuramente i giovani si caratterizzano per essere sfiduciati, incerti ed entrati in stato di precarietà esistenziale. È una caratteristica della loro età. L’identità si forma attraverso le risposte che riescono a dare all’incertezza. Risposte che si costruiscono sia individualmente sia socialmente. In Italia – più che altrove – quest’incertezza si è estesa a livelli “patologici”. La gerontocrazia li ha relegati in un angolo, in attesa. La costruzione della loro identità affronta un lasciano qualche speranza verso il futuro. Per alcuni, questa fase prolungata di incertezza si traduce in un laboratorio di sperimentazione esistenziale.
Un recente articolo, dal titolo “Non è un’economia per giovani”, pubblicato da “The Guardian”, sostiene che i laureati di oggi saranno più poveri dei loro genitori, un fenomeno unico nella società del dopoguerra. In che senso?
È vero, i giovanni corrono il rischio di essere più poveri dei loro genitori. In Italia questo è dovuto a numerosi fattori, non ultimo un ingresso nel mercato del lavoro protratto nel tempo e caratterizzato da lunghi periodi di precariato. Questo vale sia per i laureati che per chi non ha conseguito titoli accademici. Quello che oggi non sembra un problema imminente – perché la famiglia aiuta a compensare l’estendersi della condizione di incertezza – avrà conseguenze di medio-lungo periodo. Le carriere contributive dei giovani, infatti, incidono sia sull’età in cui si matureranno i contributi per andare in pensione sia sull’ammontare delle pensioni. In sostanza si andrà in pensione molto più tardi e l’ammontare delle pensioni sarà notevolmente più basso di quello dei propri genitori. Se ora una pensione corrisponde a circa il 75-80% dello stipendio dei nostri padri ai giovani di adesso non resterà che – in un’ipotesi ottimistica – il 40-45% circa. Un ammontare che corrisponde a cifre di poco superiori all’assegno sociale. Tutto questo trasformerà “la questione giovanile” di adesso in una “questione anziani” nel futuro. Ma di questo i politici poco si interessano, è fuori dal loro orizzonte cognitivo.
Parlando della transizione verso l’età adulta, la gioventù è il momento in cui si entra nella vita pubblica. Preso atto che i giovani non considerano l’ordine sociale come un dato di fatto, ma come una realtà da scoprire, proprio per questo sono pronti, più degli adulti, a coglierne con spontaneità anche gli aspetti innovativi. Perché la potenzialità innovativa che i giovani rappresentano si trasformi in atto è necessario però che la società ne favorisca la mobilitazione, e dunque, che essa sia dinamica piuttosto che statica. Cosa ne pensa?
Nella società contemporanea le transizioni all’età adulta come si conoscevano negli anni 60-70 non esistono più. I momenti quali “la fine degli studi” e “l’inizio di un lavoro”, “la formazione di una nuova famiglia” e “la nascita del primo figlio” non segnano più i passaggi canonici alla vita pubblica. I giovani (e meno giovani) spesso coabitano con i propri genitori fino a tardi (soprattutto in Italia) e questo certamente rallenta il processo di transizione, anzi lo cambia nella sua stessa natura. Si entra nella vita pubblica in modo diverso, ancora un po’ dipendenti, più gradualmente e con identità multiple, alcune perfettamente integrate, altre ancora private ed escluse. Questo incide anche sulla capacità innovativa dei giovani, non fornendo a tutti dei contesti che favoriscano l’innovazione. È sempre stato così, ma oggi forse lo è ancor di più. Siamo di fronte a una frammentazione delle opportunità trasversale (ma collegata) alle appartenenze di classe. Internet sembra – almeno in parte – contrastare questa tendenza, ma l’Italia è agli ultimi posti nel digital divide in Europa e questo sicuramente non aiuta.
Com’è cambiato il concetto di partecipazione? Fioccano definizioni che marcano le distanze dagli anni delle contestazioni: “generazione del quotidiano”, “generazione degli sprecati”, addirittura “bamboccioni”. Qual è la sua opinione?
Esistono i bamboccioni, certo. Ma non sono sempre esistiti? Sicuramente si vive più nel quotidiano, perché il futuro è ancora più incerto. E quella dei giovani oggi, effettivamente, è una generazione “sprecata” perché non si ascolta la loro capacità di innovare e si dilaziona la loro possibilità di dare un contributo alla società. Ma non per colpa loro. La “colpa” – se così si può dire – è piuttosto dei genitori che non hanno colto l’importanza del ricambio generazionale e non hanno fornito loro strumenti per essere autonomi. È colpa delle istituzioni che costruiscono percorsi di esclusione istituzionalizzata non proteggendo i giovani nelle delicate fasi di transizione a partire dall’ingresso nel mercato del lavoro. Avere tassi di disoccupazione giovanile oltre il 30% non è solo un problema individuale del giovane disoccupato, è anche un problema sociale di una società che perde l’opportunità di far partecipare i giovani alla società in maniera più piena. Partecipare vuol dire tante cose, vuol dire esprimere opinioni che vengono ascoltate, vuol dire partecipare alle decisioni, vuol dire essere autonomi e come individui contribuire al benessere collettivo della comunità. I giovani di oggi partecipano solo in parte in questi termini.
Oggi si assiste a un’estensione dei percorsi formativi e a una permanenza prolungata nei nuclei familiari di origine da parte dei giovani. Il risultato è che i passaggi fondamentali per segnare la transizione verso l’età adulta subiscono un forte slittamento temporale. È un fenomeno temporaneo legato al momento di crisi o dobbiamo considerarlo come un cambiamento antropologico?
Di fatto sembrano sommarsi entrambe le tendenze. Non solo in Italia. Sono significative le difficoltà (se non la crisi) che sta attraversando l’istruzione e formazione professionale in diversi paesi Europei: sempre più ragazzi e ragazze scelgono l’istruzione generalista per posticipare la scelta di “cosa fare da grandi”. Da questo punto di vista, però, non è giusto colpevolizzare famiglie e giovani. Ci sono, infatti, importanti fattori strutturali che comportano la perdita di rilevanza dei canali di ingresso al mercato del lavoro e il perdurare di situazioni di disoccupazione o sottoccupazione che – quasi automaticamente – ritardano l’uscita dalla casa dei genitori. La questione, inoltre, ha anche un aspetto contingente legato alla crisi. Non è casuale l’aumento dei giovani adulti (18-34 anni) che vivono con i genitori. Negli ultimi 10 anni sono aumentati un po’ ovunque in Europa. Considerando i dati Eurostat il fenomeno ha dimensioni macroscopiche solo in alcuni Paesi mediterranei (tra cui l’Italia) e dell’Europa Orientale, ma è in crescita anche in Svezia, Danimarca, Olanda e Francia (si pensi al divertente film “Tanguy” di Chatiliez, uscito nelle sale già nel 2001). Solo in Germania la percentuale è scesa a poco più del 40% nel 2010. Nei paesi nordici (Norvegia e Finlandia), viceversa, i corsi di vita sono molto più fluidi e la transizione è più agevole (meno del 20% dei giovani adulti vive in famiglia). Culture diverse, certo, ma anche politiche diverse. In questo quadro, in particolare nei Paesi con un welfare residuale e poco protettivo nei confronti delle giovani generazioni come l’Italia, nella fase ciclica recessiva, le cose peggiorano drasticamente. Ma attenzione, non peggiorano solo a causa della disoccupazione (che non è la causa principale della coabitazione prolungata): solo 1/6 dei giovani adulti che vivono coi genitori sono disoccupati. In molti paesi, dove per esempio il supporto al diritto allo studio è limitato, c’è una quota rilevante di studenti, cui si aggiungono coloro che lavorano ma che non guadagnano sufficientemente per fare il salto “nell’autonomia”. Nel caso italiano, per esempio, la mancanza di un mercato degli affitti aperto ed economico riduce di molto le possibilità di uscita in presenza di redditi da lavoro dei giovani molto limitati. La mancanza di una politica della casa ormai da decenni è un forte limite strutturale. Con la crisi il fenomeno si amplifica. Per esempio, le indagini su “Famiglie Marchigiane e Mercato del Lavoro” svolte fra il 2008 e il 2010 ci dicono che la crisi ha prodotto il rientro in famiglia di giovani che vivevano da soli, con una crescita degli under 30 in famiglia che passa in soli tre anni dal 72% all’88%. Solo il 6% degli under 30 marchigiani è sposato o convivente. Questo comporta anche una crescente sofferenza economica per le famiglie d’origine, che vedono un reddito più o meno invariato a fronte di una crescita degli inattivi.
I cambiamenti subiti in questi anni dalle famiglie di origine che non sono più nuclei consolidati ma passibili di trasformazioni per le separazioni dei coniugi come hanno influenzato i giovani di oggi?
L’aumento di separazioni, divorzi e figli nati fuori dal matrimonio, il calo dei matrimoni, l’aumento delle convivenze e delle coppie con un coniuge straniero sono processi che caratterizzano tutti i Paesi europei e sono parte di quella che i demografi chiamano la seconda transizione demografica. È una transizione che rende le relazioni familiari molto più complesse, qualitativamente diverse da quelle del passato. Sia negli aspetti relazionali, sia in quelli delle pratiche quotidiane. Sono processi che avvengono anche in Italia, ma a ritmi di molto inferiori a quelli degli altri paesi europei, che mostrano un grado di secolarizzazione sicuramente più elevato. Si pensi che i tassi di divorzio sono in Italia (insieme all’Irlanda) i più
bassi in Europa: tre volte meno che non in Belgio e meno della metà della media europea. Lo stesso vale per le nascite fuori dal vincolo del matrimonio: nei paesi nordici ormai più della metà degli figli nasce così. In Italia sono solo poco più del 20%. Insieme alla Polonia il dato più basso in Europa. Il problema, tuttavia, non consiste tanto nei cambiamenti che sono evidenti in tutta Europa, quanto nel significato che rivestono nei vari contesti. E, soprattutto, nel modo in cui vengono affrontati. Da questo punto di vista, il welfare italiano è costruito in base ad una immagine di famiglia che non corrisponde più alla realtà sociale. Si tratta di un welfare che fa affidamento sul lavoro domestico familiare di cura che “dovrebbe” (culturalmente, socialmente,…) essere svolto dalle donne senza (o con pochi) servizi e risorse pubbliche. Ho chiamato questo meccanismo “sussidiarietà passiva”, poiché lo Stato delega responsabilità di cura (di minori-giovani e anziani) alla famiglia senza socializzarne il costo. Nei paesi nordici, viceversa, il welfare tende a defamiliarizzare le responsabilità di cura e nei paesi dell’Europa continentale, dove le responsabilità familiari rimangono centrali, queste sono accompagnate da investimenti significativi in servizi e trasferimenti di risorse importanti.
In questo scenario, la famiglia italiana è fortemente sotto stress. L’aumento dell’occupazione femminile e le difficoltà di inserimento occupazionale dei giovani rendono, infatti, difficile prendersi cura adeguatamente di minori-giovani e anziani (e il ricorso al mercato caotico delle “badanti” ne è esempio). A sua volta, questo riduce ulteriormente le possibilità dei giovani di costruire un futuro indipendente. I dati Istat sul rapporto genitori-figli sono particolarmente significativi da questo punto di vista. Moltissimi giovani, anche quando hanno avviato il loro percorso di vita indipendente andando a vivere da soli e facendosi una famiglia, vivono vicino ai genitori perché sono una delle poche risorse per affrontare i bisogni più svariati. L’attività di baby-sitting che i nonni svolgono, permette alle donne di andare a lavorare nonostante i servizi per l’infanzia (0-3 anni) siano particolarmente limitati. Senza contare, poi, il ruolo di ammortizzatore sociale intergenerazionale assunto dal sistema pensionistico, specie nel Mezzogiorno, dove nella carenza di redditi da lavoro specie per i giovani le risorse degli anziani contribuiscono significativamente al bilancio familiare. Ovviamente è una situazione che nel medio periodo diventa insostenibile. In particolare, quando diventeranno anziane le fasce di popolazione oggi in età lavorativa, la loro situazione patrimoniale, reddituale e pensionistica non permetterà più questo trasferimento di risorse e servizi, lasciando i giovani del futuro “abbandonati a loro stessi”.
La transizione all’età adulta è oggi più lunga e lenta che in passato. Questo matura nei giovani il diffondersi di un orientamento ancorato al presente e la conseguente riduzione della progettualità legata al futuro. Quali sono gli effetti nel comportamento dell’universo giovanile?
È quasi tautologico affermare che la transizione lenta porta i giovani a dilazionare le scelte. Può portare anche a forme di protesta estreme, come nelle banlieu parigine nel 2005 dove si protestava anche per la mancanza di futuro. Lo storico Le Goff le ha definite “la rivolta di una generazione che non ha più avvenire”. Come i disordini nell’estate del 2011 in alcuni quartieri di Londra. Se non si protesta si è relegati a forme di passività? Per molti – la maggioranza – sicuramente sì. I dati cui abbiamo accennato sui NEET in Italia sono – da questo punto di vista – esemplificativi e preoccupanti di una condizione estrema nello scenario europeo. I giovani hanno, però, anche un altro modo per dimostrare la propria insoddisfazione: andarsene dall’Italia. Si stima che ogni anno lascino l’Italia circa 60.000 under 40 e circa 45.000 laureati, attratti da salari, possibilità di carriera e protezione sociale attualmente inimmaginabile in Italia. Un fenomeno del quale si è parlato nei media, ma sul quale bisognerebbe riflettere di più e, soprattutto, fare qualcosa.
I giovani possiedono maggiore destrezza nel padroneggiare le tecnologie mediatiche. Potrebbero essere questi i canali preferenziali di partecipazione non convenzionale attraverso cui i giovani possono avvicinarsi alla vita sociale e politica?
Non ne sono certo. Infatti, se è pur vero che le tecnologie costituiscono un canale importante per “riavvicinare” i giovani alla partecipazione nel processo di decisione politica, i nodi da affrontare sono più profondi. Riguardano – tra le altre cose – un loro (mancato) ruolo attivo nella politica e la (im)possibilità di ricoprire ruoli di responsabilità. Con un’età media di 59 anni, la classe dirigente italiana è la più anziana d’Europa. Nelle ultime 3 legislature sono stati eletti soltanto 2 under 30 su circa 2.500 deputati, anche se il peso dei 25-29enni è pari a circa il 28 per cento della popolazione eleggibile (con più di 25 anni). Il premier svedese, quando è stato eletto nel 2006 aveva 41 anni e anche David Cameron – premier britannico – aveva 44 anni quando ha vinto le elezioni. Sicuramente, dunque, le nuove tecnologie possono contribuire a riavvicinare i giovani alla politica, perché permettono di parlare attraverso i loro linguaggi. Ma ci devono essere cambiamenti più profondi che affrontino alla radice l’esclusione sistematica che i giovani subiscono per rendere concreta questa possibilità.
Come vivono i giovani d’oggi il sentimento di appartenenza, nel clima di incertezza e fluidità, che caratterizza quest’epoca globale?
Non c’è un modo univoco di vivere il sentimento di appartenenza. In un clima di incertezze e precarietà esistenziale nella migliore delle ipotesi, i giovani potrebbero essere stimolati a cercare le certezze non più fuori, ma dentro di sè. Nella peggiore delle ipotesi, invece, in forme di xenofobia e razzismo, nella chiusura verso la diversità vista come causa di molti mali. Si pensi al proliferare dei gruppi di estrema destra nei Länder della Germania est dopo l’unificazione. Il senso di appartenenza è sempre più molteplice, come lo sono le identità e le forme di socializzazione che i giovani attraversano dalla nascita all’età adulta. Ed è questa moltitudine che si pone come potenziale risorsa e come potenziale nodo critico esistenziale dei giovani. Come risorsa nel momento in cui l’identità si arricchisce di punti di vista diversi. In un’epoca globale questo è più semplice di un tempo. Come criticità quando la diversità diventa fonte di esclusione e di chiusura sociale, dove il diverso diventa il capro espiatorio.
Secondo lei, le forme di partecipazione giovanile troveranno sempre e solo spazio sul web che rappresenta senza dubbio uno strumento che ha radicalmente rivoluzionato la trasmissione di informazioni (rapidità, esiguità dei costi, flessibilità, fruibilità 24 ore su 24) e le giovani generazioni, socializzate fin dall’infanzia al suo utilizzo, sono quelle che meglio ne sfruttano le potenzialità, padroneggiando ed utilizzando il mezzo per molteplici scopi?
Sicuramente no. Siamo piuttosto di fronte a forme ibride in cui tutti gli strumenti che i nativi digitali utilizzano per comunicare e vivere la loro quotidianità – da Facebook a Twitter, a Foursquare e altre Apps dedicate – sono parte delle strategie della loro quotidianità. Una quotidianità che non è virtuale, ma reale e comporta anche momenti condivisi di presenza attraverso una socialità più fisica. Questo discorso vale sia per il privato che per il pubblico. Vale per organizzare la serata a cena con gli amici o per organizzare un flash mob (si pensi a quello di giugno scorso organizzato a Milano in occasione del concerto di Madonna) o un incontro di mobilitazione di protesta, come abbiamo ben visto nella primavera araba. Le
diverse forme di comunicazione si integrano, diventano parte della vita, sono la “normalità”.
In conclusione se dovesse tratteggiare un identikit dei giovani d’oggi, come li descriverebbe? E quanto sono diversi dai loro padri e nonni?
È difficile tracciare un identikit dei giovani d’oggi. Più che mai le loro identità sono multiple, plurime, complesse e fortemente dinamiche. Non ci sono più transizioni “scolpite nella pietra”, ma transizioni fluide che cambiano da contesto a contesto e anche individualmente. In questo, i giovani d’oggi, sono sicuramente molto diversi dai propri genitori, quando finire gli studi e iniziare a lavorare coincideva spesso con la formazione di una nuova famiglia. Oggi si fanno figli molto più tardi (l’età del primo figlio è ben oltre i 30 anni in Italia), spesso fuori dal vincolo del matrimonio (nei paesi nordici sono più della metà), in un contesto di crescente precarietà esistenziale (più in Italia che altrove). Ma si è anche più mobili, sia fisicamente – si va più spesso all’estero – sia dal punto di vista lavorativo. Il dipartimento del lavoro degli Usa afferma che all’età di 38 anni in media si è cambiato lavoro almeno 10-14 volte. In questo quadro, quello che bisogna cercare di cogliere sono gli aspetti positivi di questi cambiamenti, quelli emancipatori che permettono ai giovani di costruire identità più flessibili, più complesse e al tempo stesso più aperte alla diversità, perché la diversità è diventata parte del vissuto quotidiano. Bisogna, dunque, cercare di contenere gli aspetti negativi delle nuove transizioni e trasformarli in opportunità di cambiamento.
(tratto da Vdossier numero 1 Anno 2012)