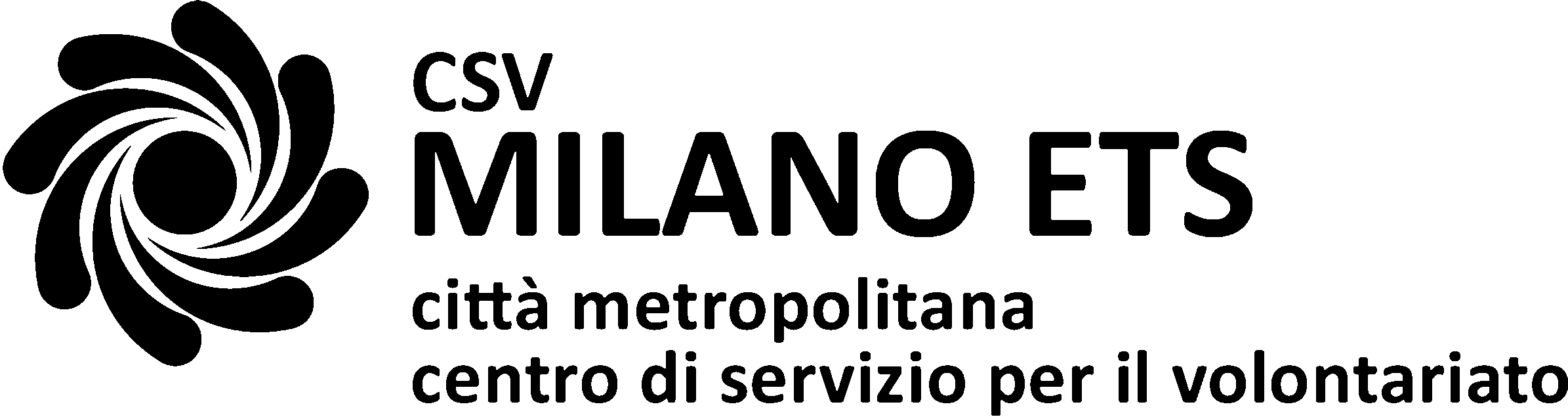Meno conti e più efficacia. La bilancia dell’impatto sociale pesi la ricaduta di ciò che si fa
Non serve dare i voti. Oltre a una gestione virtuosa, la buona reputazione si costruisce con l’eccellenza dell’attività. Parola di Paolo Venturi, direttore di Aiccon
di Paola Springhetti
La “valutazione dell’impatto sociale” è un termine che ritorna più volte nella legge delega al Governo per la riforma del Terzo settore (106/2016) e che è citato otto volte nel testo del Codice del terzo settore. La legge delega la definisce come «la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato» (articolo 7). La definizione è generica, ma un gruppo di lavoro al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sta lavorando alla definizione di linee guida, che probabilmente adotteranno una definizione più precisa.
La legge delega comunque considera la valutazione dell’impatto sociale come un punto di riferimento ineludibile per i rapporti tra Terzo settore e pubblica amministrazione, là dove si propone di «valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l’affidamento agli enti dei servizi d’interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione, nonché criteri e modalità per la valutazione dei risultati ottenuti» (articolo 4).
Anche i benefici in termini fiscali e il sostegno economico agli enti sono subordinati alla valutazione dell’impatto sociale, visto che si parla di «introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell’impatto sociale delle attività svolte dall’ente» (articolo 9). Il Codice rende obbligatoria la valutazione dell’impatto per gli enti con entrate superiori al milione di euro, dà alle reti associative la possibilità del «monitoraggio dell’attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale», e ai Csv quella di mettere in campo, tra l’altro, «servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale». Non obblighi, dunque, ma possibilità.
In attesa che vengano pubblicate le linee guida, possiamo però dire che c’è un problema innanzitutto culturale, e forse di formazione interna al Terzo settore e in particolare al volontariato: anche se da anni si studiano le prospettive e i metodi della valutazione d’impatto, non si può dire che sia diventata una prassi comune, anche se esistono esperienze molto interessanti. Ne abbiamo parlato con Paolo Venturi, che è direttore dell’Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del non profit (Aiccon) – il Centro studi promosso dall’Università di Bologna e dall’Alleanza delle cooperative Italiane – e direttore di The FundRaising School.
La necessità di far diventare la valutazione dell’impatto sociale uno strumento abituale del non profit è tema di discussione da qualche anno, anche prima della Riforma.
È vero, è un tema centrale nel dibattito più ampio sul valore economico e sulla policy del Terzo settore, nelle sue varie tipologie. Mentre per molto tempo la finalità sociale è stata un elemento esaustivo, rispetto ai soggetti che supportavano e finanziavano queste attività – per cui al Terzo settore si chiedeva tutt’al più di rendicontare correttamente – direi che ora il tema dell’efficacia è diventato discriminante. Il fatto è che oggi la dimensione della socialità riguarda più soggetti: per questo è richiesta la valutazione, che non è un giudizio di bontà, ma un modo per dare valore a quello che si fa. Non basta dimostrarsi efficienti nella spesa, occorre essere efficaci, cioè misurare il cambiamento prodotto dalle azioni poste in essere.
C’è già chi si misura con questo cambiamento?
Questo concetto è stato assunto anche in altri ambiti. Nella finanziaria, ad esempio, sono stati introdotti gli indicatori di impatto sociale (che si rifanno al Bes-Benessere Equo e Sostenibile), ma il tema dell’efficacia è stato introdotto anche nelle policy delle fondazioni bancarie e in quella della Fondazione con il Sud, soprattutto per quanto riguarda il bando sulla povertà minorile. Un crescente numero di organizzazioni dell’imprenditorialità sociale sta già lavorando in questo senso, basta guardare l’ultimo report della Fondazione Ant, che si occupa di tumori. Il consorzio CO&SO di Firenze ha prodotto un impact report basato sui diciassette obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Quello che si vuol fare è leggere l’attività sociale nella sua capacità di produrre cambiamento stabile.
Lei ha detto che la valutazione non è giudizio. Ma questo è proprio quello che molte realtà non profit temono: essere giudicati.
Nessuno dà i voti. In Italia la cultura della valutazione scarseggia in generale, anche nelle politiche pubbliche. Ma davvero la rendicontazione non basta più, neanche per le organizzazioni non profit, che pure sono chiamate a rendicontare. La valutazione è importante per chi fa fundraising: finanziatori e donatori vogliono sapere non solo se i soldi sono spesi bene, ma anche se producono impatto sociale. E anche le fondazioni o le banche sono sensibili alla buona reputazione, guardano se quello che fai cambia davvero le cose. Del resto, le linee guida su cui si sta lavorando danno valore all’autovalutazione. Da quando qualche anno fa è stata chiusa l’Agenzia per il non profit, in Italia non ci soggetti terzi che possano farsi carico della valutazione. L’autovalutazione resta la strada migliore.
Il volontariato è fatto di tante piccole realtà che non hanno competenze, ma probabilmente neanche tempo e disponibilità per affrontare anche l’impegno di questo tipo di valutazione (di solito chi fa volontariato desidera “stare sul campo” ed è poco disponibile per la parte più gestionale-burocratica della vita associativa).
Partiamo dall’assunto che il compito principale del volontariato è promuovere la cultura del dono e che la Riforma ne ha riconosciuto pienamente il valore. Detto questo, è evidente che la valutazione deve essere proporzionale anche all’entità dell’organizzazione e che non si può calare dall’alto, indipendentemente dalle risorse disponibili. Per tutti – per le piccole e per le grandi organizzazioni – occorre costruire una logica intenzionale, più che imporre una logica normativa. Il tema della valutazione va incoraggiato. Del resto anche lo storytelling, la narrazione, è un elemento di impatto sociale, fondamentale per coinvolgere i beneficiari, diretti e indiretti. Ed è uno strumento che viene usato sempre più spesso e sempre più intenzionalmente. Insomma, va incoraggiato il valore, non solo la funzione. Le realtà piccolissime devono continuare a fare quello che hanno sempre fatto, ma sapendo che il contesto è molto sensibile. E che il problema di adeguare le competenze c’è.
Si riferisce sempre al rapporto con i finanziatori?
Non solo. C’è ad esempio il tema dei nuovi volontari, che non hanno le stesse motivazioni prosociali che c’erano vent’anni fa. Prendiamo i millennials, ad esempio: non vogliono solo fare qualche cosa che produca benessere, ma vogliono condividerla con altri, purché produca cambiamento. O pensiamo al tema delle periferie, che in questo momento suscita tanto interesse. Misurare l’impatto non è altro che una valutazione di un prima e di un dopo. E poi, in fondo è il cambiamento che mette insieme le persone.
Dunque, valutare l’impatto significa misurare il cambiamento. Come si fa ad ascriversi il cambiamento? Non ci sono troppe interferenze, troppi fattori esterni che lo determinano?
Avere la certezza è impossibile: bisognerebbe adottare metodi di analisi controfattuale complicati e a volte impossibili. È evidente che l’intervento sociale dipende dal contesto. Molto dipende dagli indicatori che si scelgono. Noi distinguiamo tra outcome e impact. Outcome sono i risultati direttamente osservabili rispetto all’attività fatta, l’impact rientra invece in una logica di medio periodo. Voglio comunque ribadire che la valutazione dell’impatto non serve a giudicare se sei bravo o se non lo sei, ma se quello che fai serve.
Abbiamo già detto che il volontariato è profondamente diverso dall’impresa sociale e dagli altri soggetti non profit. L’economista Stefano Zamagni ha sempre detto che, al di là dei servizi o dei progetti, il valore del volontariato sta soprattutto nella creazione di beni relazionali. Come si misura tutto questo? Non si rischia di arrivare a semplificazioni eccessive?
Perché Fondazione Ant fa il bilancio inserendo anche la valutazione? Non per dare un numero a chi condivide il fine vita con qualcuno, ma anzi per non ridurre a prestazione il valore di quello che fa. Ci sono tre elementi che caratterizzano i beni relazionali: l’identità dell’altro conta; l’esito è sconosciuto, inatteso; cambia il rapporto.
Il dono è relazione e le relazioni cambiano i soggetti. Tutto questo diventa ancora più bello nella logica della valutazione, diventa invece più mortificante restringerlo dentro il numero di prestazioni. Naturalmente, bisogna capire qual è lo strumento adeguato rispetto al valore. Ma è importante dire, che non necessariamente parliamo di valori quantitativi. E che la valutazione attiene alla categoria dei mezzi, non dei fini. Alla Fondazione Ant non l’ha imposto nessuno e nessuno, spero, chiederà la valutazione alle piccole associazioni.
Quindi servono modelli, metodi di valutazione specifici per il volontariato.
Le grandi organizzazioni hanno già l’obbligo del bilancio sociale e, come ho accennato, molti si raccontano già in una logica di impact. Prima però bisogna rispondere alla domanda: come faccio a darmi obiettivi di impatto? Serve una metodologia. Noi crediamo nella teoria del cambiamento, che fornisce un modo semplice di osservare ciò che si fa. Le linee guida incoraggeranno questo approccio e forse spingeranno alcuni soggetti a integrare la rendicontazione sociale con una valutazione di impatto. Abiliteranno la cultura e incentiveranno l’autovalutazione. Non credo che ci siano indicatori adeguati per tutti: sono dimensioni, ma anche tipologie troppo diverse. Tre sono quindi i passaggi: individuare le dimensioni di valore di quello che si fa; di quelle dimensioni impostare la valutazione; non ingessare il non profit. L’obiettivo non è aumentare la burocrazia, ma motivare la dotazione di strumenti per la valutazione.
(Tratto da numero 3 di Vdossier anno 2017)