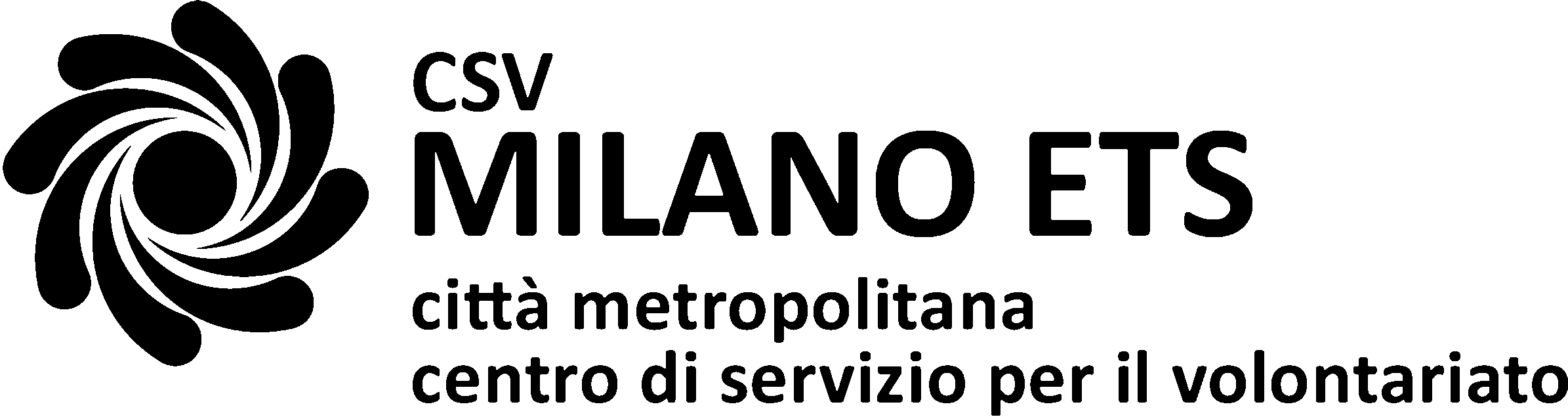Non profit, via d’uscita alla dittatura del desiderio e al capitalismo illiberale
Il sociologo Mauro Magatti spiega che in crisi non è soltanto un sistema economico e un’ingieneria finanziaria, ma un modello di produzione, di consumo e un’idea di cultura.
di Paolo Marelli
MIlano, maggio 2010 – «La vita sociale è come il mare; ma non si può studiare il mare. È troppo grande. Troppo maestoso». Eppure gli ultimi dieci anni li ha passati, giorno dopo giorno, a studiare le correnti profonde della modernità, a sviscerare la crisi del capitalismo tecno-nichilista (in cui «siamo dentro da almeno trent’anni»), a vincere una sfida concettuale: mettere in discussione “l’immaginario della libertà” per cercare e ritrovare la libertà autentica, quella che rende l’uomo più uomo, cioè un animale relazionale, più responsabile verso gli altri.
Sulla scrivania del suo studio, Mauro Magatti, che insegna sociologia all’Università Cattolica di Milano, sfoglia le pagine del suo libro, Libertà immaginaria. Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista, un volume vasto e complesso, che spazia da Max Weber a Friedrich Nietzsche, da Pierre Bourdieu a René Girard. E le sue riflessioni sulla crisi che sferza il nostro tempo spaziano dall’economia all’organizzazione sociale, dalla finanza all’etica, dalla psicologia alla filosofia. Il suo argomentare veleggia dal cosa e come desideriamo, produciamo, consumiamo; per passare al come ci rapportiamo agli altri, all’analisi dei nostri comportamenti e, infine, alla dimensione della solidarietà.
È un viaggio, che assomiglia a una scalata irta e difficile, per capire che il vero problema sta a monte: nella cultura che respiriamo, nell’immagine di ragione imbevuta di tecnica che abbiamo stampata nella mente, nell’idea di individuo, di “verità”, di socialità.
Alla fine del lungo colloquio con il professor Magatti, sarà più chiaro che ciò che è in discussione nel nostro tempo non è tanto un sistema economico, un’ingegneria finanziaria gravida di imperfezioni e di illusioni, che ha impoverito le nostre vite. «Il rischio vero – sintetizza il sociologo – è che, schiacciati come siamo in una prospettiva esistenziale di “immediatezza”, perdiamo la nostra libertà». Il nostro sistema culturale ed economico ha prodotto quella che lui definisce una vera “dittatura del desiderio”; o che tradotta in una formula accademica è “un’economia libidica del plusgodere”. Ma torniamo al punto di partenza: la crisi finanziaria, iniziata nell’autunno 2008 e che «non ci ha ancora abbandonati». Magatti muove dall’assunto che questa crisi «mette a nudo le contraddizioni derivanti dall’eccesso di “mercatismo”». Ecco perché porta «in superficie l’urgenza di correggere il modello capitalistico che si è imposto negli ultimi vent’anni».
Quanto accaduto può essere spiegato ricorrendo ad una similitudine: «Per fare la maionese – spiega – occorre sbattere il tuorlo dell’uovo in modo da farne aumentare il volume facendovi entrare aria. Ma, come tutti coloro che hanno provato, la miscela che, in questo modo si viene a formare, ha la caratteristica di essere altamente instabile. Basta poco e la maionese “impazzisce”».
Eppure lei sostiene che lo sviluppo del sistema finanziario degli ultimi 20-30 anni ha reso possibile uno straordinario aumento del volume delle risorse disponibili su scala globale.
Sì, è vero e lo ha fatto mediante l’introduzione di strumenti tecnici sempre più raffinati. Di più: non solo è aumentata vorticosamente la velocità degli scambi finanziari, ma è cresciuto anche, su scala planetaria, il volume complessivo delle risorse disponibili. Volendo fare una sintesi estrema, questa è ciò che chiamiamo globalizzazione.
Proprio quella innovazione finanziaria, di cui oggi vediamo l’inconsistenza, è stata uno degli ingredienti dello sviluppo economico globale degli ultimi due decenni. E va sottolineato che il sistema ha funzionato molto bene per diversi anni e la sua crisi – come quando la maionese impazzisce – è dovuta a errori ed esagerazioni che avrebbero potuto essere evitati. Ma il punto su cui conviene soffermarsi è un altro. Il problema è che, come la nostra maionese, l’architettura finanziaria su cui tale sistema si basava era estremamente precaria. E, nonostante molti osservatori ne abbiano sottolineato la vulnerabilità, poco o niente è stato fatto. Sul terreno di tale vulnerabilità è fiorito il capitalismo tecno-nichilista, con l’economia che ha smarrito qualunque scopo sociale. Il modello capitalistico presupponeva che la giustizia sociale e la cura della persona si realizzassero per mero effetto secondario. Usando un gergo ciclistico, la fuga del drappello di testa avrebbe generato l’inseguimento da parte del “plotone” rimasto indietro.
Non è stato così per certi versi?
Mi piace ricordare quello che mi ha detto uno dei principali manager di una grande banca italiana: “La globalizzazione non sarebbe esplosa e centinaia di milioni di persone non avrebbero raggiunto un livello di benessere superiore senza gli strumenti che chiamiamo tossici”. Il manager ha ragione, salvo il fatto che mette tra parentesi gli inevitabili “costi umani” che l’accelerazione impressa dal capitalismo tecno-nichilista ha comportato su individui e comunità.
Quindi viviamo sulla nostra pelle una crisi che ha perso il rapporto con la realtà. Wall Strett e la vita concreta sono separati da una distanza abissale?
Sicuramente. Tanto che i top manager che hanno occupato le posizioni di potere nelle grandi banche di investimento non avevano più alcun contatto con la vita concreta delle persone. Ciò spiega come mai, negli ultimi due decenni, la crescita economica abbia avuto come unico obiettivo una moltiplicazione della ricchezza, con un aumento indiscriminato delle opportunità individuali. Di fatto c’è stata la vittoria del profitto, su qualsiasi etica. Una tale prospettiva si è spinta fino al punto in cui ogni riferimento al “senso” – sia esso di ordine sociale, politico e morale su quello che si fa – è stato rimosso. Si è pensato che tale aumento delle opportunità costituisse un bene in sé, da perseguire comunque. Tutto ciò ha fatto sì che il profitto, mezzo e misura dell’efficienza economica, si sia imposto come fine in se stesso.
E lei, in proposito, ritiene che questa sorta di patologia finanziaria di cui stiamo sopportando le conseguenze, rappresenta uno dei casi più puri di quell’“immaginario della libertà” che si è progressivamente sviluppato nei Paesi avanzati.
Azioni e comportamenti sono stati svuotati di significato. Si è spinto l’acceleratore solamente sul lato del desiderio reso godimento. Nel capitalismo tecno-nichilista il messaggio è ossessivamente sempre lo stesso: per crescere occorre potenziare il desiderio individuale che è l’energia inesauribile in grado di alimentare indefinitamente lo sviluppo.
Siamo rimasti imprigionati all’interno di un modello di sviluppo che, convinto della sua onnipotenza certificata dai successi, ha finito per rimuovere interi pezzi della realtà. Ecco perché la crisi non ha fatto altro che rendere manifesti alcuni dei problemi impliciti in tale modello. Il crack finanziario ci ha impoverito, anche se gli ultimi segnali sembrano far pensare che siamo riusciti a scongiurare l’apocalisse. Ma ciò non toglie che le conseguenze di quello che è successo segneranno profondamente gli anni a venire.
Nel caso della crisi finanziaria, è come se il mondo fosse stato colpito da un grave infarto. In una tale situazione, la prima preoccupazione è, ovviamente, quella di sopravvivere.
E, in effetti, l’intervento d’urgenza delle autorità nazionali di questi ultimi mesi ha avuto – e ha ancora – proprio questo obiettivo: quando la crisi è acuta, il problema è usare i farmaci giusti; non c’è posto per nessun altra considerazione. Ma, ammesso e non concesso che possa essere considerata superata, la fase acuta altro non è che l’anticamera di un periodo – più o meno lungo – di convalescenza nel quale è fondamentale riconoscere che non si può più tornare quelli di prima. Pretendere il contrario, far finta che non sia successo niente, tornare a vivere esattamente nello stesso modo, è una reazione comprensibile, ma molto rischiosa e sbagliata.
Come dice il proverbio: “Non tutto il male viene per nuocere”. Allora l’impossibilità di continuare a essere quelli di prima potrebbe alla fine rivelarsi un vantaggio.
Forse si potranno recuperare dimensioni dimenticate, o scoprire di avere qualità che non conoscevamo. Comunque ci vorranno anni per riassorbire i costi umani e sociali che lo sconquasso ha provocato; e se ne uscirà solo grazie a un pensiero e un’azione innovativi, soprattutto per quanto riguarda la transizione individuo-istituzione.
Quale potrebbe essere invece una soluzione a medio termine?
Nel medio termine la soluzione della crisi non è semplicemente di tipo tecnico. O per meglio dire, ciò di cui c’è bisogno è di una tecnica che esprima una nuova visione culturale e una rinnovata logica istituzionale. Volendo risalire alla radice, la questione è, in ultima istanza, antropologica, perché la tecnica – compreso l’ambito economico e finanziario – ha fatto enormi passi in avanti nell’ultimo scorcio di secolo senza che il nostro pensiero (e le nostre pratiche) siano ancora in grado di governarli. Tali mutamenti, associati alla cultura prevalente e alle trasformazioni istituzionali che li hanno resi possibili, hanno favorito il formarsi di una concezione unilaterale della libertà, che – pensandosi come ab-soluta – ha finito per essere “immaginaria”. A ben guardare, se si prova ad apprendere la lezione che la crisi prova a darci, il problema che abbiamo di fronte consiste nel ri-costruire una relazione rispettosa della realtà, vista come un limite alla nostra volontà di potenza (come desiderio e come tecnica).
Ciò concretamente significa abbandonare l’idea secondo la quale tutto ciò che viene creato dall’azione umana è, di per sé, legittimo. Keynes aveva sostenuto che l’economia – ma dovremmo dire lo stesso della tecnica in generale – ha un difetto fondamentale: nell’inseguire la massimizzazione del profitto perde il proprio rapporto con il reale. Keynes
aveva bene in mente la radice del problema che egli chiamava “il feticcio della liquidità”: per lo sviluppo è indispensabile un sistema finanziario, ma tale sistema tende a perseguire un profitto di breve termine. E allora, quando tale tendenza riesce ad avere uno spazio troppo grande, le conseguenze possono essere devastanti, perché l’economia non serve più gli scopi sociali per i quali nasce. Il modello keynesiano assumeva che una crescita stabile necessitasse di uno sviluppo sociale complessivo e che la migliore garanzia per una crescita economica di medio-lungo termine fosse data dallo sviluppo sociale.
Da questo punto di vista, il tempo che stiamo attraversando è portatore di una straordinaria opportunità che non va assolutamente perduta…
La crisi, infatti, riorganizza l’agenda della nostra vita personale e collettiva, costringendoci a confrontarci con il problema della gestione dei costi umani e sociali che essa produce e, più in generale, della definizione di una nuova relazione tra economia e società. In fondo, essa costituisce un nuovo forte campanello d’allarme che permette di cogliere le contraddizioni del modello di sviluppo che si è affermato negli ultimi vent’anni. Da questo punto di vista, essa costringe alla ricerca di un pensiero nuovo.
Se lo scenario è questo, dobbiamo aspettare un incattivirsi dei rapporti sociali?
La sfida futura consisterà nel ristabilire una nuova logica dello sviluppo, che rinunci allo sfruttamento infinito del desiderio reso godimento, assumendosi la responsabilità di orientare tale energia per sostenere/riprodurre/rigenerare le basi della socialità.
Anche su questo secondo piano, dunque, la crisi pone questioni di vasta portata.
Pone la questione di un “nuovo immaginario della libertà”, in grado di decentrare l’ossessione del desiderio individuale e di reintrodurre, anche se in forma del tutto nuova, una dimensione “sociale” e “di senso”. Si tratta di costruire una strada che eviti le due derive opposte a cui siamo esposti: da un lato, quella individualistica, che pensa il singolo come un atomo indipendente e senza legami, in preda solo al suo desiderio; e dall’altro, quella collettivistica, che tende continuamente a riproporsi nella forma di fondamentalismi più o meno mascherati: religiosi, etnici, territoriali. La strada, invece, è quella di riconoscere la centralità delle due dimensioni negate dal capitalismo tecno-nichilista, quella relazionale e quella del senso. Per fare emergere questo nuovo immaginario ci vorrà tempo, ci vorranno nuovi soggetti sociali, ci sarà bisogno di nuove idee. Forse è ora di capire che ognuno di noi è troppo dipendente dagli altri per potere avere accesso alla felicità in modo individualistico e senza porsi domande su quello che sta facendo.
Come l’esperienza dimostra, un modello che punta solo sul desiderio soggettivo, se risolve alcuni problemi, lascia molte conseguenze negative.
Per questa stessa ragione, un tale ri-orientamento non potrà essere prodotto solo per effetto di un’azione politica, anche se è difficile immaginare di poterlo fare senza politica. Esso potrà avvenire solo se nella società civile e nell’economia nasceranno i germi in grado di sostenere tale visione. Ma si dovrà almeno trovare un’intesa sulla questione di fondo, e cioè sul fatto che la strada battuta negli ultimi decenni va corretta. Per tutte queste ragioni, l’uscita della crisi non avverrà in un arco temporale di mesi bensì di anni. E non solo: essa coinciderà con l’ingresso in una nuova fase di sviluppo, di cui oggi però non vediamo neanche i contorni. Al fondo, come è successo in tante altre epoche della storia, il problema è quello di ri-immaginare la libertà, in se stessa e in rapporto al mondo e agli altri, anche nel suo rapporto con le istituzioni. Per questo, non si tratta solo né essenzialmente di una questione tecnica. Ma, prima, viene una filosofia, una visione, un’ispirazione.
Servirebbe una sorta di rivoluzione per riportare al centro il bene comune, gli interesse collettivi, la cittadinanza attiva e per sbarrare una volta per tutte la strada alla dimensione privata individuale.
Cosa succederà dipenderà da tanti fattori, compresa naturalmente la capacità dei singoli e dei gruppi di mobilitarsi e di fare in modo che l’esito della crisi guardi in una direzione piuttosto che in un’altra. Diciamo che le due prospettive sono, da un lato, un possibile incattivimento ulteriore dei rapporti sociali e una radicalizzazione di tutta una serie di aspetti che, in una fase precedente, erano già emersi: pensiamo alla contrapposizione sociale tra ricchi e poveri, al restringimento degli orizzonti della propria vita su una scala sempre più piccola. Dall’altra parte, c’è la speranza o l’opportunità di andare avanti declinando questa libertà di cui disponiamo in un modo più maturo, diventando consapevoli del fatto che la libertà ha sempre una dimensione relazionale. Se ciascuno è libero per se stesso, il rischio è che la libertà si traduca in uno sfruttamento reciproco, oppure in una paura reciproca. Se invece la mia libertà ha strettamente a che fare con la libertà dell’altro e quella dell’altro ha strettamente a che fare con la mia, allora le due libertà sono profondamente intrecciate e non possono essere separate.
Secondo lei, con la crisi la spinta solidale in questi anni è cambiata? E come si concilia con i desideri individuali?
La solidarietà, dal mio punto di vista, è una parola che presenta numerosi problemi. Perché non è poi così positiva come spesso si presume. Anzitutto chiariamo che solidarietà deriva dall’essere in solido, cioè dal percepire di condividere una medesima condizione. E ancora: dall’idea che non ci si salva da soli. In linea di principio la solidarietà non è buona. Tanto che nella storia la solidarietà spesso è stata associata alla contrapposizione contro qualcun altro. Per esempio, le istanze localistiche di questi anni sono in un certo senso solidaristiche: “noi contro gli altri”, oppure “ci dobbiamo solidarizzare insieme contro qualcun altro”. Pensiamo alla solidarietà operaia e al ruolo giocato nella lotta di classe. Quindi la solidarietà ha i suoi problemi, così come la libertà ha i suoi problemi. Ritengo, invece, che il concetto di solidarietà sia legato all’idea di libertà, ma a una libertà che la cui natura deve essere relazionale, cioè siamo veramente liberi solo se siamo e stiamo in relazione con gli altri. La libertà se è individualistica, come lo è stata negli ultimi anni, è catastrofica. La crisi economica ne è la prova. Il soggetto sociale nato e cresciuto in un modello iper individualistico è isolato, rammentato, scollegato, solo.
Per definire la società attuale più che l’immagine della solitudine, userei quella dell’adolescenza. Le società avanzate hanno creato un soggetto sociale che assomiglia sempre più a un sedicenne. Un ragazzo che esce da casa e vive l’ebbrezza di essere lontano dai genitori. Come un adolescente, anche il cittadino dell’Occidente crede che libertà significhi fare quello che si crede. Ma si sbaglia di grosso. Deve imparare a gestire la propria libertà sapendo che ci sono dei limiti, senza i quali la libertà è distruttiva. Ecco perché il nostro adolescente deve imparare a mettere in relazione la propria libertà con quella degli altri. Tornando alla società attuale, è necessario rimettere al centro la responsabilità: “Se siamo liberi, dobbiamo anche saper decidere di non fare qualcosa che si potrebbe fare”. Questo comportamento vale quanto per l’economia come per la bioetica, ma anche per le relazioni sociali, per la soddisfazione dei desideri. La forza di un pensiero differente, libero, va misurata su questa prospettiva. E non è tutto: perché serve ripensare uno scambio sociale più adatto all’oggi. E qui entra il gioco il non profit, che porta con sé un’idea di libertà-responsabilità a cui guardare con grandissima attenzione per costruire un futuro più a misura d’uomo.
Tornando alla crisi finanziaria: una sua drammatica conseguenza è stata l’emorragia di posti di lavoro che ha investito l’Italia e i Paesi occidentali. E inoltre per riallacciarci a quello che diceva lei, a riguardo dell’emergere di istanze localistiche, questa recessione economica ha acuito la paura, la diffidenza, nei rapporti tra le persone? Possono essere questi una serie di tensioni che minano la coesione sociale? In questo scenario che ruolo occupa l’azione volontaria?
Come è noto la paura è una delle scorie negative che il modello di sviluppo che abbiamo alle spalle ha generato. E se il concetto è che “ognuno deve essere libero per se stesso”, uno degli esiti inevitabili è che diventiamo una minaccia l’uno per l’altro. Poi, essendo minaccia l’uno per l’altro, dato che ognuno deve ossessivamente essere libero per se stesso, collettivamente trova anche qualche valvola di sfogo, qualche capro espiatorio su cui scatenare quest’ansia che ci produciamo gli uni con gli altri. La paura serpeggiante è appunto uno dei danni che dimostra che quel modello non sta in piedi. Non bisogna però condannare la paura, ma occorre ragionare su questa paura. Faccio questo esempio per essere più chiaro: quando si è in una casa che brucia, è fondamentale spiegare alle persone impaurite dalle fiamme come comportarsi per non commettere errori che potrebbero avere conseguenze più gravi. Ecco, in preda a questa paura figlia della crisi, occorre riflettere su come comportarsi.
Secondo lei, qual è il percorso più idoneo da seguire?
Sapere che le soluzioni non si ottengono nell’emergenza, ma si otterranno solamente se ci sarà la capacità di fare adeguati investimenti culturali. È necessario fare uno sforzo per capire che l’innovazione e l’efficienza hanno bisogno di una fibra morale su cui basarsi, altrimenti in futuro non sarà possibile costruire niente di buono.
E questa fibra morale sulla base di quali valori va costruita?
Prima di tutto è indispensabile ascoltare il Paese, evitando di fare discorsi generici e campati in aria che non portano da nessuna parte perché non sono fondati sulla nostra cultura e sulla nostra storia.
Il volontariato è sopravvissuto alla crisi, ma a suo avviso dovrebbe innovarsi?
Il problema è che il volontariato in Italia ha avuto una spinta creativa negli anni Ottanta, che ha innescato tutta una serie di effetti positivi che si sono prolungati negli anni Novanta e in parte in questo decennio. Ma, adesso, se si pensa di rianimare quella stagione d’oro non si va da nessuna parte. Il volontariato per rilanciarsi ed essere adeguato ai tempi di oggi, deve riuscire a cogliere più in profondità la natura di una crisi che è, in primo luogo, di ordine morale. Per fare questo non c’è bisogno né di soldi né di strutture, c’è bisogno del profilo più caratteristico del volontariato, che è la sua capacità di rimboccarsi le maniche.