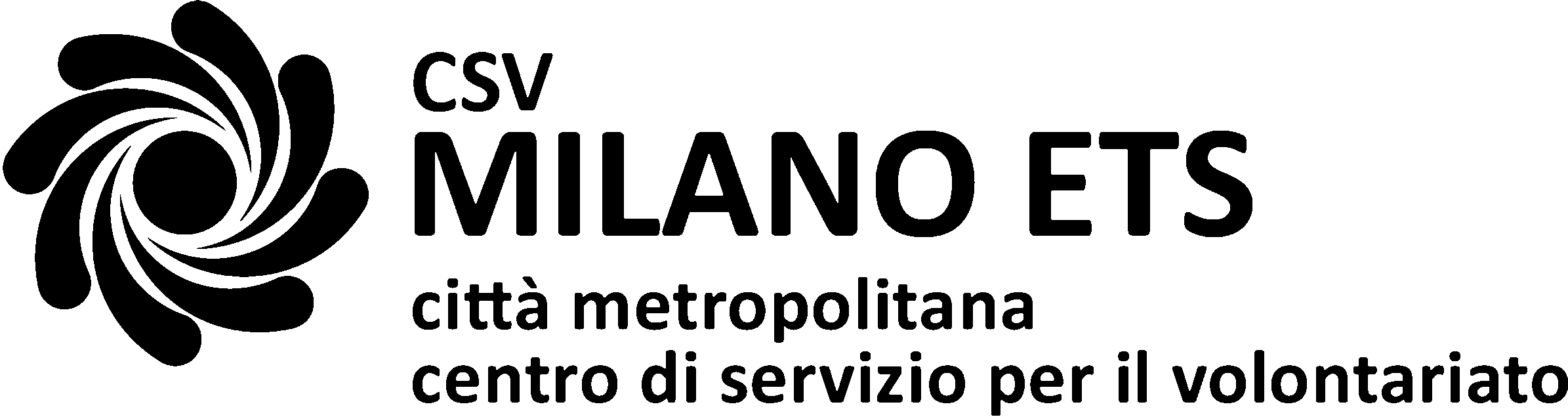Nuova legge, scommessa persa per eccesso di burocrazia e vincoli
Ombre e difetti della Riforma. L’economista Grumo e i sociologi Fazzi e Ascoli radiografano la normativa: si doveva e poteva fare di più.
di Elisabetta Bianchetti e Anna Donegà
Il difetto della Riforma? Si doveva e poteva fare di più?». Marco Grumo, professore di economia e management delle organizzazioni non profit all’Università Cattolica di Milano, è perplesso su alcuni aspetti dei decreti legge – Codice del Terzo settore e Impresa sociale – approvati l’estate scorsa. Un mix di dubbi, scetticismo e critiche illustrati anche durante la lezione di presentazione dell’executive master in Social Entrepreneurship dell’Alta Scuola Impresa e Società della Cattolica. «Mi concentro su una serie di aspetti che riguardano il funzionamento delle organizzazioni, perché il nodo della Riforma è quello di tenere insieme la qualità della progettazione imprenditoriale con l’impianto normativo». Il professore, che da anni studia il management degli enti non profit, prende in esame sia il Codice del Terzo settore sia quello dell’Impresa sociale. Spiega: «Le norme contenute nella Riforma richiedono alle organizzazioni un salto culturale su cui dovranno prepararsi e per farlo dovranno utilizzare gli strumenti giusti. Nel Codice ho contato ben 67 vincoli alla gestione dell’organizzazione. Obblighi che sono stringenti e onerosi soprattutto per le piccole-medie organizzazioni. Se analizziamo le regole sul funzionamento degli organi sociali o sulla gestione delle attività troviamo una complessità tale che soltanto le grandi organizzazioni potranno sbrogliare da soli. Mentre per quelle mediopiccole ciò comporterà una serie di difficoltà risolvibili solo con un aiuto esterno».
Quando le forme di finanziamento zoppicano
Un secondo aspetto nel mirino dell’esperto di management non profit concerne le forme di finanziamento e, quindi, la possibilità di poter progettare e continuare ad “appartenere” al mondo non profit: «Non c’è possibilità di autofinanziarsi con attività diverse da quelle di interesse generale – chiarisce il docente della Cattolica -. E se lo si fa ci sono troppo vincoli. A queste condizioni è difficile fare utili e, dunque, porre le basi per poter realizzare iniziative e attività a medio termine. La sostenibilità economica di un ente di Terzo settore si basa solo sulle attività legate all’interesse generale che può arrivare da bandi pubblici o privati, da donatori oppure con il “social lending”. Se all’interno di queste attività ci sono perdite, per la legge non ci sono problemi. Se invece ci sono degli utili, allora iniziano i distinguo, perché l’attività è considerata commerciale». Grumo entra nel dettaglio della legge e punta l’indice sull’articolo 6 del Codice: «È il caso dell’articolo che norma le “attività diverse, secondarie e strumentali” degli enti di Terzo settore. Attività che possono esercitare a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e che tengano conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite. Capite la difficoltà per un consiglio di amministrazione di controllare continuamente quando l’asticella della propria attività è commerciale e quando non lo è. Ed è una norma inserita solo nel Codice del Terzo settore, tanto che per l’impresa sociale è prevista la possibilità di reinvestire gli utili».
Sul versante della sostenibilità economica, Grumo rimarca il caso in cui un’organizzazione di volontariato stipuli una convenzione con la pubblica amministrazione. «La legge prevede solo il rimborso delle spese sostenute e documentate. Ma un conto è guadagnare per fare attività speculativa, un conto è ricavare un utile per sostenere le proprie attività. A mio parere sono due film totalmente diversi. Se l’utile è visto negativamente a priori, come fa un’organizzazione a sostenersi senza utili? È condannata alla dipendenza finanziaria. Ma sappiamo che la dipendenza finanziaria vuol dire fragilità. E la fragilità vuol scarso impatto sociale».
Burocrazia e controlli, trappole per le piccole Odv
Un altro punto dolente sottolineato dal direttore di “Cattolica per il Terzo Settore” riguarda le norme sulla trasparenza previste nel dettato legislativo, soprattutto per enti con dimensioni medio-piccole: «Entrare nel Registro unico nazionale del Terzo settore prevede controlli da parte del ministero del Lavoro, controlli delle autorità competenti come in materia fiscale, controlli degli organi interni – compresi quelli di denuncia e di intervento – che dovranno essere tarati sulle regole del collegio sindacale previsto dal codice civile per le società. Poi ci sono i controlli sul bilancio, quindi la revisione legale del bilancio, ci sono le responsabilità degli organi di governo e c’è la responsabilità degli organi di controllo». E continua: «Bisogna poi produrre un bilancio economico con determinati requisiti, c’è il diritto degli associati di esaminare i libri sociali, sono previste scritture contabili professionali, il rendiconto della raccolta fondi e, per gli enti con entrate superiori a un milione di euro, c’è l’obbligo del bilancio sociale e della misurazione dell’impatto sociale».
Obblighi di controllo e di bilancio che implicano dei costi «Si tratta di un impianto disegnato – continua Grumo – più per le grandi organizzazioni che per le piccole. In particolare, l’organo di controllo interno diventa di fatto un collegio sindacale, pertanto un organo forte con grosse responsabilità. Non a caso una nota del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, prima della pubblicazione del decreto legge, suggeriva di adottare al posto del collegio sindacale l’organo dei revisori dei conti, disciplinato dallo statuto dell’ente e, di conseguenza, non ai sensi del Codice civile». Un passaggio cruciale per il non profit visto che il collegio sindacale è obbligatorio per le associazioni riconosciute e per quelle non riconosciute quando, per due esercizi consecutivi, sono superati due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale 110mila euro; entrate per 220mila euro; 5 dipendenti occupati a tempi pieno. «Sono numeri bassi – commenta ancora Grumo – facilmente superabili se, per esempio per il primo caso, l’ente possiede un immobile come un appartamento. Quindi gli enti di Terzo settore sono sì stati riconosciuti, ma liberi di fare impresa lo sono un po’ meno».
I due piani della Riforma: visibile e nascosto
Concorde con le linee generali della Riforma, ma altrettanto critico sulle applicazioni reali è Luca Fazzi, ordinario e direttore del master in Gestione dell’impresa sociale dell’Università di Trento. Chiarisce perplessità e dubbi sul reale impatto che avrà la nuova Magna Charta del Terzo settore soprattutto sul welfare dei prossimi anni. «La nuova normativa – spiega – si può descrivere su due piani, uno visibile e uno nascosto. Quello visibile sono le norme pubblicate e tutto il dibattito che ci sta dietro. Quello nascosto riguarda come si è arrivati a questa Riforma e quali sono stati gli interessi in campo».
Tra gli aspetti positivi, evidenzia, «intravedo la volontà di dare spazio a questo settore come soggetto autonomo, di farlo uscire dagli interstizi del sistema per portarlo in superficie e dargli legittimità. Anche se, gli ultimi vent’anni, sono stati anni di leggi e norme che continuamente hanno posto al centro le organizzazioni di Terzo settore». Poi Fazzi veste l’abito del professore e fa notare che «ogni concetto, sociologicamente parlando, quando è discusso e messo al centro del dibattito pubblico acquisisce una sua legittimità, altrimenti rimane marginale. Ma i dibattiti pubblici sono sempre problematici perché andrebbero analizzati rispetto agli interessi o alla posta in gioco. Rispetto a questo processo la mia impressione è che la maggior parte della discussione sulla Riforma sia stata molto ambigua. Se ne decantano i meriti, ma si omettono le dinamiche che hanno portato ad assumere certe posizioni».
Perché si favorisce una competizione sleale
Un primo passaggio riguarda il contesto in cui si colloca questa nuova legislazione. «Scorrendo gli articoli – dice Fazzi – la prima osservazione è che non si capisce quale modello di welfare si voglia perseguire o meglio non viene dichiarato. Il secondo riguarda le negoziazioni che hanno portato al testo finale. Infatti se osserviamo una serie di misure troviamo delle contraddizioni inspiegabili. Per esempio, per quanto riguarda il volontariato, la legge introduce una forte discontinuità rispetto al passato: le associazioni potranno avere come iscritti fino al 50% dei dipendenti. È quanto prescrive l’articolo 36 del Codice per le associazioni di promozione sociale “In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati”. Tradotto significa che sarà possibile avere un’associazione con dieci iscritti di cui cinque volontari, che magari svolgono attività per un’ora a settimana, e cinque dipendenti invece che lavorano per 36 ore alla settimana. Di fronte a questo caso la domanda sorge spontanea: dov’è andato a finire lo spirito volontaristico? E, soprattutto, uno dei grossi interrogativi che pone questa misura, è che le leggi poi vanno applicate alla realtà. Ma la realtà, oggi, è quella di un sistema di welfare dei servizi fortemente caratterizzato da tagli e dove è presente una competizione marcata all’interno del Terzo settore. Quindi, con questa norma, quello che rischia di accadere è di favorire una competizione scorretta fra associazioni di volontariato “spurie” e altri soggetti di Terzo settore. Ma siccome la legge afferma che si possono fare convenzioni solo a condizioni migliorative rispetto a quelle del mercato, è evidente che questa norma presta il fianco ad un uso strumentale da parte delle pubbliche amministrazioni».
Retorica e corporativismo: le contraddizioni
Fazzi snocciola tutte le contraddizioni contenute nel testo. «Il percorso seguito da questa legge è stato caratterizzato da due spinte: la prima è una retorica che voleva il Terzo settore come attore e generatore di occupazione; la seconda è il corporativismo. Infatti il mondo del non profit nel dibattito su questa legge si è comportato esaltando le dimensioni corporative delle sue componenti. Per esempio, la norma che citavo in precedenza sui volontari, è stata voluta da alcune parti che, in quel momento, avevano più voce e più spazio». Altro esempio: «Il caso delle cooperative che, sempre secondo la norma, possono occuparsi solo di alcuni settori, mentre le nuove imprese sociali di altri. Ma perché una cooperativa sociale non potrà occuparsi di turismo o di cultura mentre un’impresa sociale sì?».
Il sociologo procede poi nella sua analisi per far emergere quello che definisce il lato non visibile: «La discussione sembra interamente centrata sul fatto che finalmente c’è una legge che lascerà libero il Terzo settore di muoversi in autonomia e la finanza lo aiuterà a fare questo. Ma tutto ciò non è affatto vero, perché i motivi che spingono la finanza a entrare nel sociale sono esclusivamente interessi di tipo profittuale. Non a caso una serie di soggetti privati legati alla Social Impact Investment Task Force ha prodotto il rapporto “La finanza che include”: un’analisi articolata dell’ecosistema dell’impact investing in Italia». «Questo rapporto – continua Fazzi – ipotizza che nel nostro Paese dal 2014 al 2020 il gap tra fabbisogno sociale e spesa pubblica sarà intorno ai 150 miliardi di euro. Una cifra appetibile per il mondo degli investimenti. Sempre nel documento troviamo l’indicazione di promuovere, presso i governi, i fondi pensione e i piani di risparmio a lungo termine e tutta un’altra serie di misure a sostegno della defiscalizzazione delle imprese sociali. A onor del vero, però, va detto che parte di queste spinte sono state arginate nel decreto sull’impresa sociale che ha imposto alcuni limiti sulla redistribuzione di utili». Fazzi spiega, inoltre, quali potrebbero essere i limiti all’imprenditoria sociale: «È il tentativo di creare un sistema dove scomparirà lo scenario tra volontariato e non profit che, in accordo con le politiche pubbliche, creano un’offerta. Per virare verso un “nuovo” soggetto imprenditoriale, definito Terzo settore, che userà il più possibile la leva della finanza privata, anche se non si capisce come funzionerà e per rispondere a quali obiettivi. Tutto questo ha dei risvolti non indifferenti. È vero che l’impresa profit può anche essere benevola e lo dimostrano i numerosi progetti fatti in partnership con soggetti non profit in Italia. Ma è altrettanto vero che, con la Riforma, l’impresa sociale che opera su certi settori potrà avere delle detrazioni sui capitali di rischio. Mentre le cooperative sociali rischiano di rimanere operative prevalentenente nei vecchi comparti, quelli dove il pubblico sta riducendo il proprio intervento. Infine il volontariato viene alterato e si introducono degli elementi dove, in un clima di restrizione del welfare, il rischio è che diventi una “lunga manus” di interventi strumentali».
Così il profit inghiotte il non profit
Ad aggiungere benzina sul fuoco sono i numerosi vincoli inseriti lungo tutto il Codice. «Siamo in presenza poi di un’architettura di controlli che in parte è “borbonica” e in parte rischia di essere poco efficace. “Borbonica”, perché carica le piccole organizzazioni di adempimenti assurdi. Risibile, perché per controllare le organizzazioni con un bilancio superiore a un milione di euro è previsto un bilancio d’impatto o bilancio sociale. Ma i bilanci sociali sono uno strumento risibile per controllare le imprese». Per concludere Fazzi fa una sintesi della sua lettura della Riforma: «È una legge che difetta di un quadro di riferimento delle politiche ed è infarcita di elementi di contraddittorietà che rischiano di far venir meno anche gli aspetti positivi che vi sono contenuti. È chiaro, e tutti lo sappiamo, che il welfare non potrà più essere finanziato solo dalla mano pubblica. Così come è fondamentale che il Terzo settore abbia gambe per poter camminare nella comunità e nella finanza. Ma un conto è creare un sistema a più pilastri dove le governance rimangono in mano al mondo chiamiamolo solidaristico, un altro invece è creare una serie di soggetti ibridi dove il privato rischia di assorbire all’interno delle sue logiche il Terzo settore. Un sistema di policy basato sui principi universalistici – chi ha bisogno riceve – non può avere una base privatistica. Altrimenti somiglierebbe troppo al sistema statunitense, dove un terzo dei cittadini sono poveri. Ed è una diseguaglianza che fa paura. Qui abbiamo un problema serio che è quello di porci la domanda dove va il welfare. Perché, se si fa una legge sul Terzo settore, si dovrebbe dire chiaramente in che direzione procede il welfare. Poi bisogna fare in modo che tutti i vantaggi della finanza sociale siano aperti a tutti i soggetti. Perché, per esempio, le cooperative nate 36 mesi prima della legge non possono usufruire dei capitali di rischio visto che parliamo di 14 mila enti che gestiscono la gran parte del welfare sociale nazionale? Se prendiamo in esame i social bond dobbiamo sapere che i primi a fare progetti di finanziamento sui risultati sono stati nel 2008 la banca di affari JP Morgan e la Rockefeller Foundation. Ma la valutazione d’impatto serve ai grandi gruppi finanziari per avere indicatori omogenei, mentre l’impatto dovrebbe essere la valutazione delle politiche e non è mai stato fatto. Ma se la valutazione d’impatto è fatta per attirare investitori deve essere necessariamente positiva, appetibile. Quindi tutti quei progetti che riguardano soggetti molto fragili avranno pochi margini di risultato. È evidente che un investitore sceglierà un progetto in cui i margini di obiettivo sono alti. Quindi la valutazione d’impatto muove gli investitori interessati al guadagno, ma quel guadagno da dove arriva? Giunge come al solito dalle casse pubbliche. Di conseguenza, perché un privato dovrebbe guadagnare dal pubblico? Questo non è chiaro. A meno che non siano le fondazioni a farlo, Poi ci sono progetti sui cui fare valutazione d’impatto è impossibile, in quanto i costi e le variabili in campo sono tali e tante da non portare a nessun risultato. Per esempio, nel caso di un progetto di prevenzione per minori a rischio quando si potranno vedere dei risultati? Dopo uno, due o dieci anni. Dunque, alcuni risultati si possono vedere, mentre altri no, oppure il risultato è discorde rispetto agli interessi degli attori in gioco. Con questo non voglio affermare che il Terzo settore non debba misurare le sue azioni, o non debba liberarsi dalla stretta del pubblico, anzi. Voglio solo dire che la valutazione dovrebbe farla il soggetto pubblico o un soggetto terzo e non gli interessi dei privati. La valutazione dovrebbe essere generale e sulle politiche, non sui singoli progetti».
I cavalli di Troia che snaturano il volontariato
«La Riforma porta in dote al volontariato pochi vantaggi e tanti problemi ». Anche Ugo Ascoli, studioso che ha saputo coniugare sociologia ed economia, nonché esperto di lungo corso del non profit, una cattedra all’Università Politecnica delle Marche ad Ancona e un mare di pubblicazioni su questi temi, boccia la nuova legge partorita dal governo Renzi e dal centrosinistra. Accusa: «Sembra infatti una norma non pensata per il mondo del volontariato, ma cucita addosso alle altre forme del Terzo settore, tra le quali le imprese sociali e la cooperazione. In tal senso, quindi, la Riforma difficilmente potrà aiutare le associazioni a creare innovazione sociale perché tende ad ingabbiarle limitandone l’autonomia».
Passando sotto la lente articolo dopo articolo, Ascoli sostiene che la Riforma contiene diversi “cavalli di Troia”, con il pericolo di snaturare il senso stesso del volontariato. «La prima criticità riguarda il concetto di gratuità, che è messo a dura prova con l’emendamento che prevede l’autocertificazione da parte del volontario delle spese sostenute, per un massimo di 10 euro al giorno oppure di 150 euro al mese. Pur parlando di autocertificazione e di rimborsi non forfettari e, quindi, basandosi sulla buona fede del volontario, è altrettanto chiaro che la norma di fatto consente una, se pur minima, “ricompensa” dell’attività volontaria. Se a questo si aggiunge che spesso un volontario è attivo in più associazioni, si potrebbero davvero nascondere forme di volontariato per lo meno “ibride” o rapporti di lavoro non regolamentati. In sostanza, nel momento in cui viene meno il concetto di gratuità legata al volontariato, si aprono scenari che vanno a mutare il valore di dono fine a sé stesso».
Centri di servizio a rischio dimezzamento
Un’altra insidia insita nella Riforma, a parere di Ascoli, è la questione relativa ai canali di finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato. «Tali enti escono dalla Riforma ridimensionati, pur essendo innovativi nel panorama europeo perché non hanno realtà simili in altri Paesi, e risultando, anche nella ricerca riportata nella recente pubblicazione “Volontariato e innovazione sociale oggi in Italia”, elementi fondamentali per la crescita delle organizzazioni di volontariato negli ultimi vent’anni. È infatti prevista una riduzione del numero – si parla di un dimezzamento – una probabile riduzione di risorse e, di pari passo, un aumento di competenze. Si prevede infatti che i Centri di servizio divengano agenzie di promozione e sviluppo del volontariato ovunque si manifesti, quindi la platea si amplia a tutto il Terzo Settore. Non vi è però previsione di un aumento di risorse che, presumibilmente, nei prossimi anni rimarranno stabili o in leggera flessione; inoltre, con la diminuzione del numero, si riduce anche la forza principale dei Csv, ovvero il loro stretto legame territoriale». Da questo scenario risultano, secondo Ascoli, due principali nodi problematici: «Innanzitutto la possibilità che i Csv, per sopravvivere, possano mettere in vendita almeno parte dei loro servizi e, d’altra parte, una forma di controllo e legittimazione dei Centri molto centralizzati, fortemente influenzati e diretti dalle Fondazioni bancarie attraverso i nuovi organismi previsti».
Capacità di innovazione? Una chimera
Altro elemento che è messo in dubbio da Ascoli è il ruolo del volontariato e il rapporto con l’ente pubblico. «Il rischio, in parte implicito nell’articolo 56 relativo alle convenzioni, è che si entri in una mera logica di appalti e che il volontariato possa “vincere” unicamente giocando al ribasso. Tale logica però limita e ingabbia le organizzazioni e riduce il valore aggiunto del non profit che non può essere paragonato ad una qualsiasi altra azienda e valutato solamente per l’aspetto economico. Le convenzioni con l’ente pubblico dovrebbero invece potenziare il ruolo del volontariato e valorizzare quella marcia in più che i volontari sanno apportare nella gestione dei servizi, insita nel concetto di “welfare mix”. Inoltre in uno scenario che vede un aumento della povertà assoluta, fenomeni emergenti tra i quali i cosiddetti “working poor” e i “fast job”, risulta fondamentale trovare risposte adeguate e strategie che individuino nuove tutele per i bisogni emergenti. Da sempre la capacità del volontariato è stata quella di intercettare i nuovi bisogni e individuare rapidamente delle soluzioni.
Se però le organizzazioni vengono ingabbiate da una normativa non adeguata, il rischio è che la capacità di innovazione diventi una chimera». Da ultimo, osserva il professore di sociologia economica, «perché il volontariato rimanga forza innovatrice e generatrice, è importante che ne sia garantita la libertà e l’autonomia, che non sia appiattito unicamente a servizio del pubblico. È fondamentale che sia facilitata la governance delle organizzazioni, che siano sostenute da un lato la capacità di advocacy del volontariato e, dall’altro, l’azione critica che può svilupparsi solo grazie a reti nazionali forti, in grado di imporsi nei luoghi e nei tavoli decisionali».
(Tratto da numero 3 di Vdossier anno 2017)