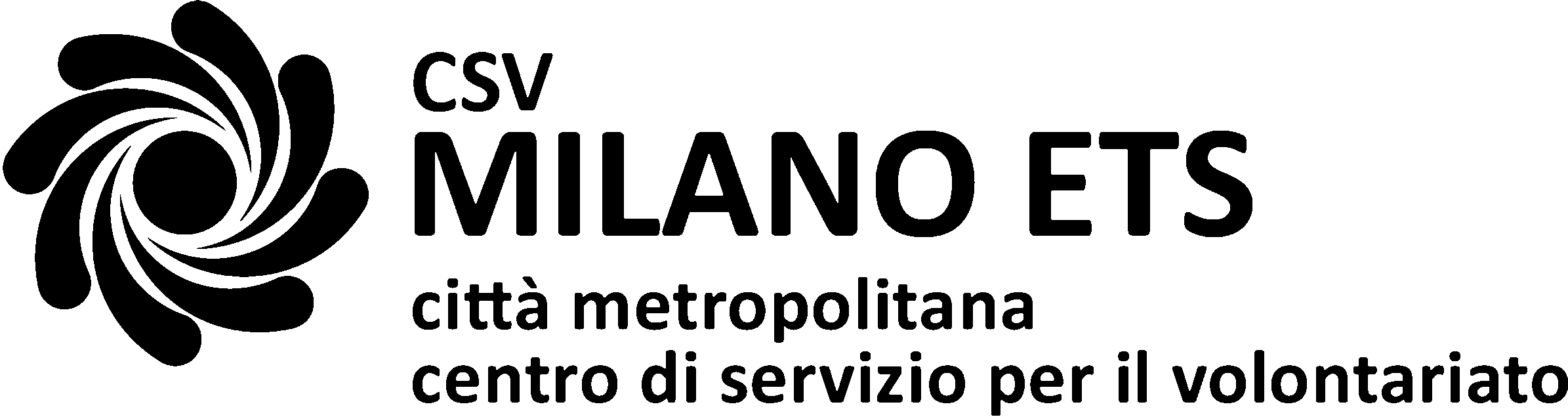Parola d’ordine? Condivisione. Lo Stato “lavori” assieme a imprese ed enti non profit
Né verticale, né orizzontale, per Arena e Zamagni la sussidiarietà deve essere circolare per un volontariato che punti alla corresponsabilità e a fare comunità
di Paolo Marelli
Alla metà degli anni Ottanta, Barack Obama, il futuro presidente degli Stati Uniti, era un apostolo della solidarietà. Era un giovane laureato in legge che lavorava come community organizer per la Gamaliel Foundation nelle periferie di Chicago. Lotta a povertà ed emarginazione, miseria e discriminazione: Obama, schierato dalla parte degli ultimi, non ha mai dimenticato quell’esperienza. Un impegno sociale che ha ricordato anche nel suo discorso di addio da numero uno d’America e che è raccontato in un libro (“Why Organize?”) del 1988, a conclusione di quei tre anni di servizio. «Il community organizing – scriveva – parte dalla premessa che i problemi che devono affrontare le comunità dei quartieri disagiati non sono una conseguenza della mancanza di soluzioni efficaci, ma della mancanza di potere per implementare tali soluzioni». In queste parole si potrebbe leggere in filigrana come il giovane Obama contrapponesse al potere del dominio la forza delle relazioni per rispondere ai bisogni della comunità. Sintetizzando, una sorta di manifesto della sussidiarietà a stelle e strisce, considerato che essa rimane la precondizione di ogni pratica del non profit, la dimensione di tutte le attività di partecipazione.
Fare comunità: missione del volontariato
Alla forza delle community organizing, al di là dell’intuizione di Obama, si è appellato anche l’economista dell’Università di Bologna, Stefano Zamagni. Lo ha fatto prima, durante e dopo le “Giornate di Bertinoro”, il tradizionale workshop che si tiene in Romagna dal 2001, una bussola per il pianeta solidarietà. Zamagni non ha nascosto che, dopo la Riforma, la nuova missione del Terzo settore italiano è di fare comunità. E ha lanciato un invito al volontariato affinché crei relazioni che scongiurino la minaccia dell’isolamento, un male del mondo occidentale e postmoderno. Occorre, secondo Zamagni, «un modo alternativo di impegno “politico” che consenta alle persone, la cui voce mai verrebbe udita, di contribuire al processo di inclusione sia sociale sia economica». Come? «Con le pratiche di organizzazione delle comunità (le community organizing, appunto), le quali sono una strategia né meramente rivendicativa né mirante a creare movimenti di protesta. Piuttosto, mirano a tradurre in realtà il principio di sussidiarietà circolare, articolando in modo nuovo le relazioni tra mercato, Stato e comunità».
Comunità organizzate come coalizioni civiche apartitiche per il bene comune e la giustizia sociale, con l’obiettivo di dare potere ai cittadini attraverso le relazioni fra le persone, l’azione intorno a interessi comuni di organizzazioni diverse dalla società stessa e la formazione di leader civici per l’agire pubblico. Perché, come sosteneva la scrittrice ecologista americana Terry Tempest Williams, se «il cuore è la prima casa della democrazia», allora le community organizing (un metodo testato nel corso di 75 anni, in oltre cento città e cinque diversi Paesi del mondo) sono la politica nel significato più vasto del termine in quanto riconnettono le persone tra loro. Ma tanto negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, quanto in Italia a fondamento dell’esperienza delle organizzazioni di comunità c’è in generale la sussidiarietà, concetto chiave per rispondere ai bisogni dei più svantaggiati per Obama; strategia indispensabile per infondere nuova linfa al Terzo settore post Riforma per Zamagni.
Orizzontale o verticale? Meglio circolare
Ma qual è l’essenza della sussidiarietà circolare sponsorizzata dall’economista di Bologna e che potrebbe imprimere un ulteriore slancio al volontariato? E in che cosa si differenzia da quella verticale e orizzontale? Se è vero che queste ultime due tipologie di sussidiarietà ben si sposano sia con il welfare capitalism americano, decollato agli inizi del ‘900, sia con il welfare state europeo affermatosi dopo la fine della seconda guerra mondiale; secondo Zamagni è altrettanto vero che esse non sono sufficienti per il welfare civile che oggi tenta di uscire dal vicolo cieco in cui si sono infilati i due modelli precedenti al di là e al di qua dell’Atlantico e i cui limiti sono ormai sotto gli occhi di tutti. Così come «con le due forme tradizionali di sussidiarietà si ha una cessione di quote di sovranità dallo Stato a enti pubblici territoriali e/o funzionali (sussidiarietà verticale) oppure a soggetti della società civile portatori di cultura (sussidiarietà orizzontale), mentre con la sussidiarietà circolare si ha una condivisione di sovranità».Tradotto: «Non faccia lo Stato ciò che meglio possono fare gli enti inferiori e i soggetti della società civile» è lo slogan della sussidiarietà verticale e orizzontale; «faccia lo Stato assieme alle imprese e ai soggetti non profit», è quello che descrive la sussidiarietà circolare. E quest’ultima, per ammissione dello stesso Zamagni, è assai vicina alla nozione di “amministrazione condivisa” portata avanti da Gregorio Arena.
La virtuosa alleanza fra cittadini e amministrazioni
Presidente di Labsus (Laboratorio per la sussidiarietà fondato a Trento nel 2005), una cattedra in diritto amministrativo all’Università di Trento, una lunga lista di libri e articoli, una crociata in difesa dei beni comuni e in nome della cittadinanza attiva, Arena puntualizza che il significato del termine sussidiarietà affonda le sue radici nell’esercito dell’antica Roma: «Era usato per indicare le truppe sussidiarie, quelle che non entravano in battaglia fin dall’inizio, ma venivano tenute in disparte per poi entrare in campo successivamente in aiuto (subsidium) dei commilitoni che già stavano combattendo. Che cosa ci insegna la storia? Che l’essenza della sussidiarietà, ciò che rende unico questo concetto, è la creazione di una relazione di condivisione per raggiungere un obiettivo comune. Come le legioni romane univano le forze per sconfiggere i nemici di Roma, così oggi cittadini e amministrazioni si alleano per affrontare insieme gli enormi problemi derivanti dalla complessità dei nostri sistemi politici, economici e sociali, cui nessuno può pensare di far fronte da solo», ha scritto in un editoriale per il sito di Labsus.
Non solo però una lezione di etimologia applicata alla cittadinanza attiva e al Terzo settore. Nelle parole di Arena traspare anche la certezza che il ruolo della sussidiarietà è vitale nel creare e nel cementare quell’alleanza fra cittadini e istituzioni architrave per il modello organizzativo dell’amministrazione condivisa. Di più: «La valenza relazionale di questo principio si eleva anche sotto altri profili, fra cui il rapporto tra le persone e i beni». Facendo qui tesoro dell’insegnamento lasciato dal sociologo Carlo Donolo possiamo aggiungere che la sussidiarietà consiste anche «nel fornire le competenze necessarie alla gestione di beni comuni». In parte perché, ne era consapevole l’ex professore della Sapienza di Roma, servono strumenti giuridici, in parte perché c’è bisogno di abilità e conoscenze per dare vita «a relazioni di condivisione di responsabilità e di risorse che rendano possibile la cura dei beni comuni da parte di cittadini e amministrazioni alleati fra di loro».
La scissione fra uso e possesso
Dall’eredità di Donolo, che anche volontari e organizzazioni non profit non dovrebbero mai dimenticare, si arriva ben presto al cuore della questione: «Quando si parla dei beni comuni – avverte Arena – il punto centrale è la scissione fra uso e possesso». Il presidente di Labsus chiarisce che «mancando la proprietà di tali beni sembrano mancare sia le competenze necessarie per prendersene cura, sia soprattutto l’interesse a farlo». E fa l’esempio della sharing economy: «Nella società della condivisione si usano beni di cui qualcuno è proprietario e dunque se ne prende cura. Nel car sharing si noleggia un’auto che un’azienda si preoccupa di mantenere in buone condizioni». Il Bla-bla car è un altro esempio: «C’è un privato che mette a disposizione la propria auto in cambio di un vantaggio economico e che tiene la sua auto in ordine. La stessa cosa succede nello scambio di case e nelle tante altre esperienze che danno vita a questo nuovo modello di economia e di società».
Detto che il punto di contatto fra la società della condivisione e i beni comuni è dato dal fatto che in entrambe le situazioni l’uso è più importante del possesso, anche se c’è una differenza sottile ma sostanziale: nel caso dei beni comuni, non essendoci nessun proprietario, nessuno è interessato alla manutenzione dei beni, mentre tutti sono interessati al loro uso. Ecco perché per i beni comuni ci si deve porre il problema di chi e come si può prendere cura di loro. «Non essendoci proprietari, non dovrebbe esserci nemmeno un interesse egoistico alla loro manutenzione. E invece le centinaia di casi raccolti nella sezione Beni Comuni del sito di Labus dimostrano che «esistono persone che si prendono molta cura dei beni comuni materiali e immateriali presenti sul territorio dove vivono, pur non essendo né potendone mai diventare proprietari», afferma Arena.
Testimoni che un altro mondo è possibile
Cittadini attivi e volontari. Solidarietà e gratuità. Responsabilità e altruismo. Sussidiarietà circolare e amministrazione condivisa e la lista potrebbe continuare. In ogni caso, però, il comune denominatore è unico: chiunque sposi questi principi e valori si erge a testimone che un altro mondo è possibile. D’altro canto, per Arena queste esperienze non dovrebbero sorprenderci, poiché da almeno un secolo «abbiamo nel volontariato un altro caso di scissione, non fra possesso e uso come per i beni comuni, bensì fra appartenenza e cura. È infatti considerato normale prendersi cura delle persone che fanno parte della propria cerchia familiare, esattamente come è considerato normale prendersi cura dei beni di cui si è proprietari. I volontari sono delle eccezioni rispetto a questa regola dell’appartenenza familiare, così come i cittadini attivi lo sono rispetto alla regola della proprietà, ma entrambi dimostrano con il loro comportamento che un altro modo di intendere i rapporti con le persone e con i beni è possibile. Dunque, un mondo fondato sulla condivisione di responsabilità e risorse per un obiettivo comune, cioè fondato, più semplicemente, sulla sussidiarietà è fattibile». Dopotutto, chiosa Arena, «cittadini attivi e volontari sono “disinteressati” alla cura dei propri interessi in via prioritaria, in quanto entrambi esercitano una nuova forma di libertà, solidale e responsabile, che ha come obiettivo la realizzazione non di interessi privati, per quanto assolutamente rispettabili e legittimi, bensì dell’interesse generale».
Il sigillo costituzionale al Terzo settore
In linea con quanto detto finora, risulta che non solo la sussidiarietà sia il cuore della cittadinanza attiva e non solo lo sia del volontariato. Ma altra considerazione che viene di conseguenza è la legittimazione costituzionale della stessa sussidiarietà che, come la partecipazione alla vita pubblica, sono colonne del riordino e revisione organica del Terzo settore. E per assicurare un peso specifico a tale orizzonte, non si può dribblare un accenno alla riforma del Titolo V (articoli 118 e 119) della Costituzione, varata nel 2001, dopo un dibattito politico e pubblico snodatosi per decenni. «La “costituzionalizzazione” del principio di sussidiarietà – spiegava ancora Zamagni sulla rivista “Vita” alcuni mesi fa – ha legittimato non solo la libertà di intervento dei privati in attività di interesse generale, ma anche la loro priorità per ragioni di prossimità. Il senso profondo della Riforma è dunque quello di dare ali alla costituzionalizzazione del Terzo settore, attraverso il superamento definitivo del binomio pubblico/privato a favore del trinomio pubblico / privato / civile. Costituzionalizzazione significa pieno riconoscimento nell’ordinamento giuridico del Terzo settore. È da questo riconoscimento che deriva l’obbligazione in capo a tali enti di procedere alla riorganizzazione profonda del proprio modo di agire e di operare. Tenendo presente che la familiare distinzione tra forma e contenuto – cioè tra soggetti e attività – non regge nel caso del Terzo settore, perché il modo in cui queste realtà “sono” deve dettare anche il loro modo di operare e viceversa». Dopotutto i decreti in via di emanazione puntano ad una costituzionalizzazione civile del non profit che sia né Stato-centrica né mercantile. Ecco perché nella nuova normativa sono distinte le nozioni di fine, missione, identità degli enti di Terzo settore. Ancora Zamagni: «Il fine di una organizzazione è la sua ragion d’essere; per la quale essa esiste e svolge la sua attività. La missione dice, invece, del modo in cui il fine viene raggiunto. Sono tante, infatti, le vie che portano ad un determinato punto di arrivo. E la scelta del sentiero non è mai una questione solo tecnica, dato che essa postula il riferimento a specifici giudizi di valore. Infine, l’identità ha a che vedere con le regole che governano la vita interna dell’organizzazione, regole che, per un verso, devono assicurare la visibilità della missione e, per l’altro verso, devono rendere efficace il perseguimento del fine. È rispetto alla missione e alla identità che va ricercato il proprium di un ente di Terzo settore. Non rispetto al fine perseguito che può essere lo stesso di organizzazioni non di Terzo settore. (Si pensi, per esempio, alle società benefit, introdotte nel nostro ordinamento nel dicembre 2015). L’omeomorfismo che si è andato registrando nel corso dell’ultimo ventennio nel nostro Paese è in buona parte conseguenza della grave confusione di pensiero tra fine, missione, identità, termini troppo spesso presi come sinonimi, anche nella letteratura specialistica. Se si vuole che il Terzo settore giunga a connotarsi come social polity dotata di una specificità diversa da quella delle istituzioni dello Stato e delle organizzazioni del mercato occorre assicurare la congruenza piena tra fine, missione e identità».