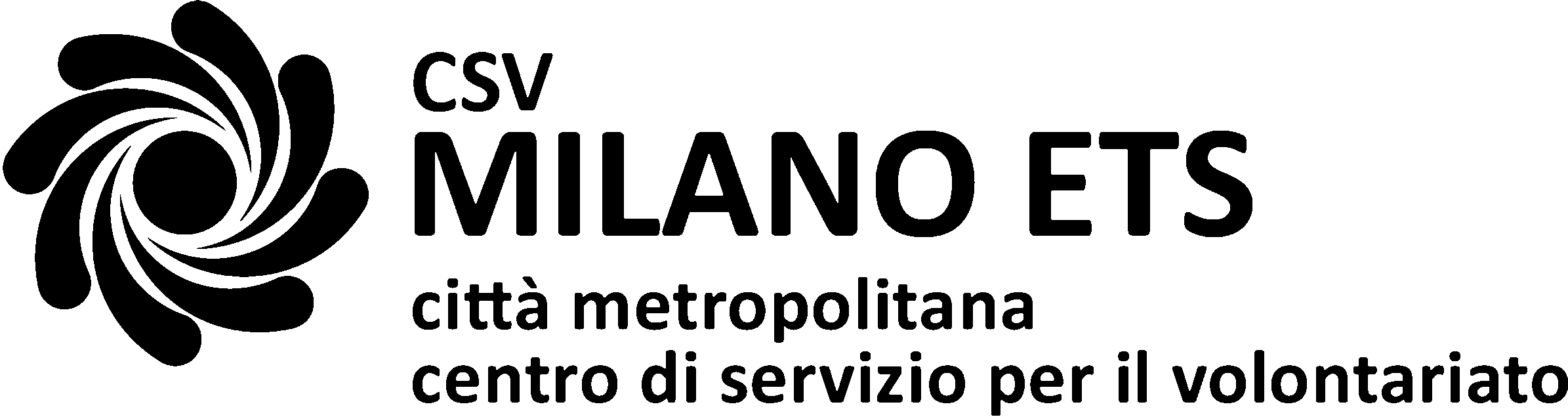Piccolo non è utile. Bisogna tessere una rete per salvare il welfare
Per Veneziani, portavoce del Forum del Terzo settore della Lombardia, c’è stata una sottovalutazione degli effetti della crisi e dei danni che ha causato nell’autostima delle persone
di Elisabetta Bianchetti
MIlano, maggio 2010 – Una lettura superficiale, univoca e, quindi, errata. «A Milano e nella sua provincia c’è stata una sottovalutazione degli effetti provocati dalla crisi economica e dei danni che essa ha causato al benessere dei cittadini, alle relazioni sociali e all’autostima delle persone», afferma Sergio Veneziani, portavoce del Forum del Terzo settore della Lombardia e presidente di Auser Lombardia. E subito precisa: «Tutti hanno considerato questa crisi come ciclica e storica: ma non è così. È diversa da tutte le altre e in quanto tale richiede risposte diverse, non convenzionali». Il peccato è stato all’origine. Per Veneziani il passo falso è stato commesso quando si è ipotizzato che il tracollo economico-finanziario scaturito dal 2008 in avanti non incidesse sul tessuto sociale e che pian piano si potesse risolvere.
«Un approccio sbagliato – dice -. Sicuramente da questa crisi si uscirà, ma quello che attualmente non siamo ancora in grado di sapere è come il tessuto sociale uscirà da questo tunnel». Secondo Veneziani solo l’arcivescovo di Milano, il cardinale Dionigi Tettamanzi, non ha sottovalutato gli effetti della crisi, tanto che ha posto al centro della sua azione pastorale il problema del lavoro, le cui conseguenze sul piano psicologico e sociale sono devastanti. «Anche se una persona non perde il posto di lavoro, ma va soltanto in cassa integrazione, passa da un reddito di 1.200-1.300 euro al mese a uno di 800 euro. Ebbene questa persona si trova di colpo in una situazione di povertà e in più patisce uno stigma sociale negativo tremendo, perché è indubbio che attraverso il lavoro una persona si realizza, anche nella propria comunità».
Mentre adesso serpeggiano paura e vergogna fra chi è disoccupato o precario.
Sì. E inoltre le persone cercano di nascondere la propria situazione, con un abbassamento complessivo della qualità della loro vita e delle comunità in cui vivono.
La crisi è penetrata dentro il tessuto collettivo e nelle relazioni umane, come uscirne? Con quale ricetta?
Non ho la soluzione, però ho un’idea: se la situazione è questa, se ne esce solamente insieme, stando uniti, perché individualmente non si va da nessuna parte.
Quindi chi può dare una risposta o chi può alleviare il senso di malessere, disagio e frustrazione delle persone che perdono il lavoro?
Solo una comunità accogliente. Quell’autostima che le persone non riescono ad avere attraverso l’attività lavorativa, la possono avere da una comunità attiva, attenta, che non li fa sentire soli, che li aiuta a sopportare una parentesi difficile. La risposta, proprio perché è di senso, la può dare solo la comunità. Che può essere il quartiere, il paese, la piccola città. Esistono dei terminali sul territorio che sono in grado di percepire e comprendere questi bisogni. Se il problema diventa una risposta collettiva, bene; altrimenti chi non ce la fa “si arrangi!”. Non c’è nessun altra possibilità. Una comunità che fa coesione crea anche i presupposti per permettere al singolo in difficoltà di poter riemergere. Questo è quello che si potrebbe fare e che invece manca. Ad una comunità con queste caratteristiche devono concorrere tutti, nessuno escluso. Anzi, ognuno faccia la sua parte: sindacato, parrocchie, associazioni di volontariato, enti di promozione sociale, cooperative. In sostanza, è fondamentale la partecipazione dei cittadini alla ridefinizione del tessuto sociale. Sembrano frasi fatte, però si possono tradurre in realtà.
Qual è il limite che in questa crisi ha avuto e sta avendo il volontariato?
Ha prevalso la cultura del fare rispetto alla cultura del capire, del comprendere quello che stava succedendo nella società. Ognuno di noi è abituato a dare risposte alle emergenze, come per esempio il terremoto in Abruzzo. E questo è relativamente facile: perché è un meccanismo che mette in campo cultura, tradizione, modi di lavorare già collaudati. Ma il problema vero è la quotidianità. La qualità e la maturità del volontariato in Lombardia e nel Milanese non si misurano con le emergenze, perché per quelle le coscienze si mobilitano. Il volontariato, invece, si misura tutti i giorni con le emergenze delle persone.
Cosa prevale quindi dentro l’idea del volontariato?
Che l’importante è il fare e la relazione, ma la relazione se non ha una dimensione più grande finisce e si esaurisce in quell’atto che stai facendo. Questo è il limite, il difetto che ancora ha il volontariato. E questo problema si supera attraverso non la rinuncia al fare, ma attraverso l’inserimento del fare dentro una rete più grande, dove il fare di ognuno diventa un patrimonio per tutti, e tutti possono insegnare a tutti come fare. In economia si direbbe “fare sistema”. Ritorniamo al concetto che, se io aiuto te e la mia azione si esaurisce in quel gesto, allora ha poco peso, poca forza, ha un senso ridotto ai minimi termini. Ma, se quello che faccio diventa patrimonio, diventa rete, pian piano ci si sposta sulla risposta al problema.
A suo dire, questo sarebbe il grosso limite del volontariato. La sua è quasi un’autocritica.
Sì, perché sono anch’io presidente di un’associazione di volontariato. Ma la verità, è che ognuno individua degli spazi piccoli, quelli del suo intervento, del suo fare e ne è gratificato, ha una corrispondenza diretta perché ha una relazione con le persone, poi però tutto finisce lì. Adesso, invece, stiamo andando verso un nuovo modello di Welfare – che inevitabilmente si dovrà ricostruire perché si dislocano diversamente le risorse – e che sarà uno Stato sociale dentro il quale le reti del Terzo settore diventeranno dei soggetti non solo integranti ma dei soggetti integrati. La nostra comunità vivrà meglio o peggio se i soggetti, cioè l’autorganizzazione dei cittadini, diventerà un pezzo del modello di sviluppo del territorio. Questo è sostanzialmente quello che immagino avverrà. In altre parole, bisogna fare un salto dalla legittima difesa orgogliosa delle proprie peculiarità, ad una messa in comune di queste peculiarità. In questo modello ognuno continua a fare quello che fa e lo farà anche meglio a patto che però insegni qualcosa a qualcuno e impari a sua volta.
Il volontariato ha le capacità, è preparato, ha le competenze per partecipare a questo modello di Welfare?
In questo momento, no. Ma non è un “no” definitivo. Certo anch’io ho difficoltà in qualità di presidente a partecipare ai tavoli di programmazione perché bisogna essere esperti, competenti. Ma non è questo il problema. L’ostacolo che dobbiamo superare è la costruzione della rete e come realizzarla. Ma dove non riesce la piccola associazione da sola, ci riesce una rappresentanza costruita assieme, ossia ci riesce la rete. Se si entra nei terreni dell’autoprogrammazione (piani di zona, Asl, tavoli tematici, tavoli del Terzo settore), chi vi partecipa, rappresenta, conosce, promuove e sostiene quello che avviene sul territorio, allora anche la piccola associazione di tre volontari diventa un patrimonio.
Ma il volontariato, secondo lei, ha la percezione dell’importanza della rappresentanza, della partecipazione?
Come ho detto prima penso che sia ancora molto forte la cultura del fare rispetto a quella della rete e, quindi, è faticoso capire questo passaggio. Ma il quesito, a mio avviso, va posto in modo differente: quando si definiranno i nuovi modelli di Welfare, quando si comincerà a mettere in discussione diritti consolidati ma non più garantiti, solamente allora si capirà l’importanza dell’annodare legami saldi, perché non c’è alternativa. Saremo con le spalle al muro: o si seguirà questa strada maestra, percorrendo la via della coesione fra persone e associazioni, oppure saremo tagliati fuori. È vero che, volendo muovere una critica al volontariato, si può accusarlo di una scarsa visione d’insieme, però è altrettanto vero che il volontariato non è in alcun modo “ingabbiabile”. Il valore vero del volontariato è che gruppi di persone si mettono assieme, poiché sanno che ci sono dei bisogni e cercano di darvi delle risposte. Sono pienamente d’accordo che è sbagliato limitare la capacità di autorganizzazione dei cittadini. Ma il nodo da sciogliere è quello di riuscire a riempire di un senso le cose che si fanno; e una volta dato un senso, costruire una rete. Ma guai se non difendessimo la capacità di autorganizzazione, vorrebbe dire far venir meno la ragione del volontariato.
La mission del volontariato è l’aiuto alla persona, ma questa relazione si dà dentro a un Terzo settore forte, strutturato e organizzato. Come coniugare questo obiettivo, con un calo dei volontari registrato dalle associazioni di Milano e provincia?
Certo i volontari non si possono cercare per mezzo di un annuncio pubblicitario. Per esperienza personale, posso dire che nella nostra associazione abbiamo costruito un progetto di reclutamento che si intitola “Vi stiamo cercando”. I risultati sono stati positivi, tanto che laddove l’abbiamo proposto, abbiamo trovato persone disposte a impegnarsi. Altro problema invece è che, dopo averli reclutati, i volontari vanno gestiti, a cominciare dal dirgli cosa fare. Resta una questione aperta, così sintetizzabile: diminuiscono i volontari ma è ancora possibile promuovere le attività di volontariato. Rispondo con una provocazione: in futuro una persona dovrà fare il volontariato per scelta o perché non ci sono alternative se vuole difendere un modello di welfare che ponga al centro la persona, se vuole difendere l’esercizio dei diritti, se vuole difendere la qualità della propria vita. Piuttosto che un impegno per necessità, preferisco una società nella quale una persona fa volontariato per piacere, perché dà un senso alla vita, perché è gratificante. E lo verifico nella mia esperienza: i primi avvantaggiati dal volontariato non sono quelli che usufruiscono del servizio, ma sono coloro che fanno qualcosa per gli altri.
C’è poi un difetto di visibilità sui mass media: il volontariato rimbalza su tv e giornali soltanto quando è direttamente coinvolto nelle emergenze, come un terremoto; mentre il volontariato non è solo lo straordinario, ma soprattutto è l’ordinario. C’è in questo un problema di comunicazione da parte del volontariato, ma c’è anche un problema di visione della società. Attualmente in Lombardia ci sono 870mila ultra settantacinquenni e, secondo le statistiche, nel 2025 saranno 3 milioni. Una situazione difficile sia per il lavoro che per la comunità. Ma se queste sono le previsioni come cambierà la società? Per esempio, nel mio paese, quando sono nato, c’erano 2.500 abitanti, di cui 600 bambini e 25 anziani. È chiaro che la società si era organizzata per dare una risposta ai bambini; in quello stesso paese fra 25 anni la situazione si sarà ribaltata: ci saranno 600 anziani e 25 bambini. Allora quei 600 ultrasettantacinquenni possono essere una risorsa per la comunità? Ritengo di sì, al punto che potrebbero offrire una mano alle giovani coppie accudendo i loro figli quando mamma e papà lavorano. Con questo voglio dire che occorre promuovere il volontariato, ma su una visione ancorata alla società, con scenari e modelli attuali. Il volontariato deve abbandonare un ruolo caritatevole e spingersi verso un ruolo di promozione della qualità della vita delle comunità.
C’è, a suo modo di vedere, una crisi del volontariato giovanile?
Né più né meno di prima. Il problema è il numero di giovani presenti nella nostra società. Se prima c’erano mille giovani e il dieci per cento faceva volontariato, il risultato erano cento volontari. Oggi la realtà è cambiata: ci sono cento giovani, il dieci per cento continua a impegnarsi, ma il risultato è diverso, perché sono appena dieci i giovani che fanno volontariato. Penso che rispetto al passato, non c’è né maggiore né minore voglia di fare volontariato, semmai ci possono essere opportunità diverse di farlo.
Cioè l’azione volontaria va inserita in una visione del futuro?
Esattamente. Da sempre i giovani pensano di avere il futuro in mano, hanno energie, entusiasmo, ottimismo; così sono portati anche a dare una mano agli altri, Ma la realtà è mutata: oggi un giovane laureato che si barcamena con contratti precari e a malapena arriva a guadagnare uno stipendio di 800 euro al mese, ritengo che abbia poca voglia di impegnarsi gratuitamente.
Il volontariato è congiunto con la fiducia nel domani.
È uno sguardo di prospettiva che limita la partecipazione al volontariato dei giovani. Perché parliamo di un’attività che fa diventare cittadini attivi, che fa pensare a un futuro per sé e per gli altri.