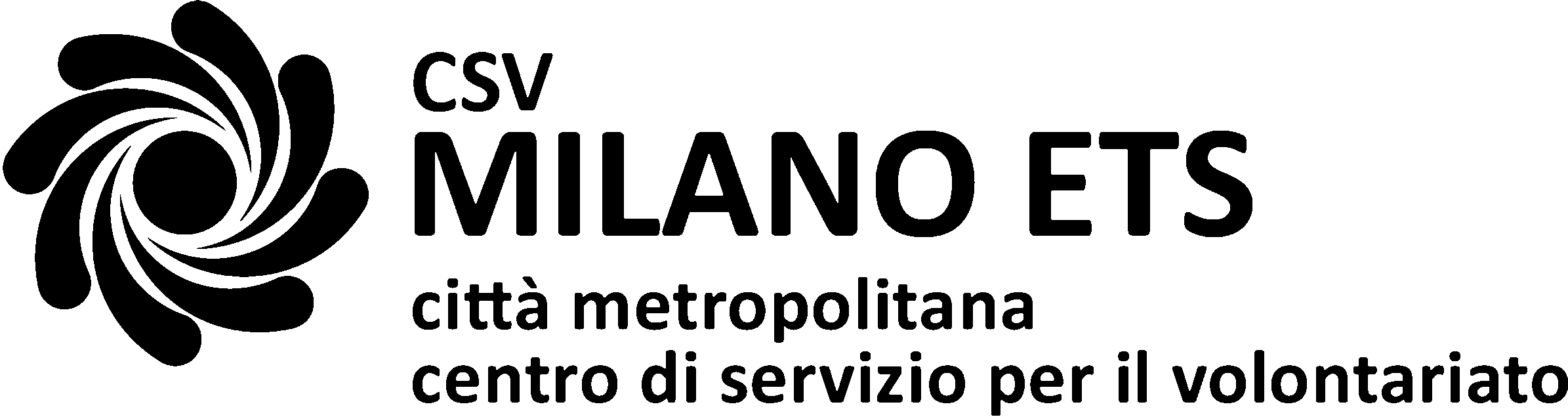Più iniziative transfrontaliere. Ecco come l’Europa diventa il villaggio della solidarietà
Per Luca Jahier, membro del Cese, per costruire un volontariato europeo servirebbe un salto di qualità, a cominciare dalla condivisione transfrontaliera di iniziative, progetti e persone
di Elisabetta Bianchetti
Milano, dicembre 2011 – Nell’Unione Europea 94 milioni di persone, il 23% della popolazione dei 27 Stati, è impegnata nel volontariato. Chiediamo a Luca Jahier, torinese, esperto di cooperazione internazionale allo sviluppo e presidente del terzo gruppo del Cese, il Comitato economico e sociale europeo, cifre alla mano, se sia possibile considerare il Terzo settore come il più grande “Stato europeo”.
«Di sicuro questi numeri tendono al ribasso perché le persone che si impegnano nel volontariato in Europa sono molte di più. Ci sono tanti modi per fare volontariato e tanti non sono neppure recensiti dai sistemi di rilevazione. Basti pensare alle numerose attività nelle strutture religiose, o alle modalità di impegno civile in aree rurali o nelle zone montane. Tutte azioni che, pur non finendo sotto il cappello ufficiale del volontariato, di fatto, comunque, esistono. Si tratta di un vero e proprio “popolo del bene” che è molto difficile da monitorare e il motivo è altrettanto semplice: il volontariato è definito, concepito e praticato in modi diversi nei Paesi dell’Ue. Ecco perché sui numeri c’è un problema di misurazione e, a oggi, non abbiamo a disposizione stime oggettive. Un esempio? La forma più diffusa di volontariato nelle statistiche europee è quello legato alla sfera sportiva. In Italia, invece, questo approccio è poco considerato.
Se non esistono, dunque, dati empirici sul fenomeno, perchè non c’è ancora una definizione condivisa all’interno degli Stati membri, è altrettanto vero che un dato è certo e inconfutabile: le persone impegnate nell’ambito del volontariato e, in generale, nel Terzo settore vanno a costituire senza ombra di dubbio lo stato europeo più grande che esista. A dirlo sono una serie di stime, piuttosto precise, raccolte ed elaborate dai diversi stakeholder che operano all’interno del mondo del volontariato e degli enti pubblici, che costituiscono un sistema di censimento come quello delle cooperative, dell’artigianato o delle imprese. Parliamo di cifre che sono una somma di stime che provengono dai singoli Stati, pur basate su elaborazioni profondamente diverse».
Il pianeta volontariato da Lisbona a Varsavia, da Berlino a Roma, non è ovviamente tutto uguale: in che cosa si differenzia? In questa sorta di “gioco delle differenze” in quali Paese vede degli aspetti positivi e in quali degli aspetti negativi?
Certamente un aspetto positivo delle varie forme di volontariato è che esse rappresentano una grande palestra di educazione alla cittadinanza attiva. E poi c’è da rilevare che la spinta al bene rimane stabile nonostante l’onda lunga della prevalenza del privato sul collettivo. Da questo punto di vista, il volontariato con la sua costellazione di associazioni, ha rappresentato e rappresenta tuttora una forma di contrasto a questa deriva individualistica. Del resto, il volontariato non è solo un’espressione collettiva ma è anche un’esperienza personale: la singola persona mette a disposizione una porzione del proprio tempo per dare una mano al vicino, ma questo rendersi utile si completa e assume valore in sè in quanto crea condivisione, in quanto intesse relazioni con l’altro. Questi possono essere annoverati come gli aspetti positivi del volontariato. D’altro canto, però, restano, a mio giudizio, alcuni nodi, come la tendenza del volontariato a dare un’immagine di sé un po’ troppo ipersettoriale e iperspecialistica. Infatti in alcuni Paesi, anziché crescere e svilupparsi nella direzione di un fatto più complessivo, si è caratterizzato per questa sua difficoltà a concepirsi nel suo aspetto più globale. Il caso italiano è evidente. Dagli anni Ottanta a oggi le spinte al bene si sono moltiplicate, trascinando con loro tantissime e pregevoli iniziative, ma nel contempo c’è stata una perdita di consistenza e di pregnanza del movimento nel suo insieme. Altri Paesi, invece, hanno assistito a un maggiore consolidamento del settore, forse perché venivano da una tradizione molto diversa. Pensiamo ai Paesi dell’Est Europa dove, dopo la caduta delle dittature e la costruzione di un percorso verso un sistema democratico, sono nate una miriade di iniziative di impegno civico e di volontariato che hanno vissuto in questi vent’anni un processo di aggregazione piuttosto che di frantumazione.
Allargando il discorso, se volessimo compilare una pagella, che voto darebbe al “sistema” volontariato dell’Italia?
Non mi sento nella condizione di farlo anche se, per tanti anni, ne sono stato un protagonista diretto. Mi sembra che il volontariato italiano incarni una storia straordinaria e di grandissima levatura, forte di un notevole bacino di energie e di una molteplicità di campi d’azione, ma altrettanto sfibrato da tre problemi. Il primo è l’indebolimento complessivo della capacità di rappresentarsi delle organizzazioni di volontariato, che sono sussidiate dalle strutture che appartengono al sistema dei Centri di servizio, che però si sono trovati molto spesso nella condizione di svolgere un mestiere di elaborazione politica che non gli era proprio. Infatti i CSV erano nati per sostenere la strutturazione delle organizzazioni di volontariato, piuttosto che per assumerne una sorta di leadership e di rappresentanza. Questa sorta di sovrapposizione di ruoli è avvenuta perché si sono verificate, nell’arco degli anni, una serie di circostanze che hanno modificato la capacità del volontariato di darsi una sua dimensione di movimento.
Il secondo problema è che il volontariato ha attraversato, in questi ultimi vent’anni, un cambio di rotta: da grandi battaglie di carattere nazionale si è spostato a questioni più locali e più legate alla gestione diretta dei servizi. A volte mi chiedo se esiste ancora una differenza tra le attività svolte da una organizzazione di volontariato e quelle messe in campo da una impresa sociale. È come se tutto, in qualche misura, si fosse uniformato, con la conseguenza che è prevalsa una competitività di tipo gestionale piuttosto che un’azione più educativa e sperimentale, di innovazione e di movimento.
La terza questione è più strutturale e non tocca solo il volontariato, ma tutto il Terzo settore. Serve, infatti, un cospicuo investimento formativo sulle capacità strategiche di formazione della leadership e dei dirigenti. Un bisogno che, ripeto, non tocca solo il volontariato ma l’insieme dell’azione sociale organizzata in Italia. Si tratta, ovviamente, di un orizzonte a lungo termine perché per formare una classe dirigente non bastano cinque o sei anni, serve molto più tempo. Sono processi lunghi che non si improvvisano. Eppure noi, oggi, siamo costretti a subire le conseguenze di un ventennio in cui si è disinvestito nella formazione della classe dirigente dopo i gloriosi Anni Ottanta, che venivano dopo gli straordinari anni Settanta. Poi con gli anni Novanta è arrivata la crisi ed è comunicata una ristrutturazione con l’obiettivo sia di rispondere ai bisogni delle comunità, sia di reperire fondi o gestire progetti. In questo ventennio c’è stato un sostanziale investimento sulla formazione tecnica a scapito della formazione strategica a medio e lungo termine. Finalmente, con l’inizio del nuovo millennio, il problema è di nuovo tornato nell’agenda delle priorità.
Quando e come sarà possibile non più parlare di volontariato italiano, francese, spagnolo, inglese, ma più semplicemente di volontariato europeo?
Esistono già alcune forme di volontariato europeo, anche se non sono ancora del tutto sviluppate. Penso al Servizio volontario europeo che è uno strumento che, in dieci anni, ha avuto una certa capacità di dare buoni risultati. Il problema è che i numeri non sono stati così ampi come avrebbero dovuto essere per poter avere un impatto significativo all’interno dei volontariati nazionali e all’interno delle percezioni dei vari movimenti sociali. Ma tornando alla domanda, io invece spero che ci siano tanti volontariati nazionali.
L’Europa non è chiamata a diventare una sorta di marmellata, o un cocktail di ingredienti da cui si debba originare un menù modello, una sorta di standard europeo dell’artigiano, del volontario o dell’impresario. Piuttosto il futuro dovrà continuare ad essere all’insegna della naturalità, del rispetto delle identità di ciascun Paese. Si dovranno invece combinare particolarità e volti diversi, come in qualunque altra parte della società, perché esistono storie, tradizioni diverse tra loro. Questo, però, non significa che questi aspetti non possano incontrarsi, come del resto hanno dimostrato di poter fare molte organizzazioni in occasione dell’Anno europeo del volontariato. Basti pensare alle importanti conclusioni
del documento adottato a Varsavia a dicembre dell’anno scorso, la “Pave”, ossia l’agenda politica del volontariato in Europa. Questo è il frutto di un processo largamente condiviso tra molti movimenti, strutture e organizzazioni di volontariato europee.
Penso che bisognerebbe avere anche il coraggio, nonostante alcune resistenze, di condividere con altri soggetti alcune battaglie importanti per costruire una dimensione della cittadinanza europea. Personalmente sono convinto da molto tempo ormai, che c’è stato un errore tragico in Italia: quello di sospendere il servizio militare obbligatorio e il servizio civile, sostituendoli con il servizio volontario sia militare che civile. Soprattutto quest’ultimo è stato ridotto ai minimi termini. So che il servizio civile volontario non può essere equiparato al volontariato, ma il mio sogno è che diventi parte di un curriculum obbligatorio per i nostri giovani. Proprio come la scuola, spero che venga “caldamente” consigliato
a tutti i ragazzi con meno di 25 anni, di fare un’esperienza di sei mesi di volontariato o di servizio civile su scala europea. I vantaggi sarebbero enormi, a partire dalla garanzia di una mescolanza delle pratiche, delle conoscenze sociali, dell’interscambio e dalla condivisione di esperienze. Sarebbe un forte stimolo a creare davvero una cultura più europea, con un concetto di cittadinanza più solido, ma anche convergenze più significative dei movimenti di volontariato e sociali.
Come tradurre in concreto questo concetto?
Basti pensare a cosa è stato il servizio militare obbligatorio in Italia, quando i ragazzi del Sud si trasferivano al Nord e viceversa. Ciò ha permesso di riavvicinare gli abitanti delle regioni e farli sentire italiani. Oggi, con un salto nell’atlante, questo potrebbe valere per i cittadini europei, facendo per esempio trascorrere un periodo di tempo in Finlandia agli italiani e in Italia ai finlandesi. Bisognerebbe avere il coraggio di fare una scelta di questo tipo. Così il volontariato diventerebbe una opportunità per tutti e non per pochi. E a dimostrare che quello di cui parlo è un orizzonte a portata di mano ci sono i numeri degli Erasmus, degli Sve, di chi fa progetti transfrontalieri: non si tratta di volontariato, ma sono esperienze il cui valore intrinseco è quello di essere uno strumento di educazione alla cittadinanza, proprio come lo è la scuola. Anche nel caso in cui non diventino pratiche obbligatorie ma solo sponsorizzate dalla rete dell’associazionismo, comunque, queste sono le scelte che potrebbero formare più facilmente la costruzione di una dimensione europea, oltre che la crescita di movimenti europei di volontariato. Altrimenti tutto è lasciato alla spontaneità dell’iniziativa di singole associazioni che, però, sono più radicate sul territorio, più limitate a una dimensione locale, ed è pertanto difficile che un movimento locale avverta la necessità di sviluppare un’esperienza di volontariato a Helsinki. Certo, non è detto che non possano fiorire spinte del genere, ma queste troverebbero origine più nel caso, o nell’intelligenza e nello spirito d’iniziativa del suo leader, o sarebbero semplicemente frutto della partecipazione a un convegno di questa o quella realtà che si incontra con un’altra organizzazione europea che lavora nello stesso campo. Insomma, si tratterebbe di casi sporadici. Se consideriamo, poi, la carenza di fondi, è altamente probabile che questa vocazione non sia considerata una priorità. Tutto questo, dunque, non aiuta uno sviluppo diffuso di interscambi che favorisca il consolidamento del movimento europeo.
Lei prima si immaginava un servizio volontario obbligatorio rivolto ai giovani sotto i 25 anni, ma c’è in qualche Paese europeo un’esperienza di questo tipo?
L’obbligatorietà del servizio civile è stata cancellata dappertutto. Eppure io ribadisco quanto sia importante che il nostro Paese torni a ripercorrere quella strada, pur nella consapevolezza, però, che il servizio obbligatorio non deve essere accostato all’idea di un anno speso invano o sacrificato per il Paese. Al contrario, questa esperienza dovrebbe essere letta attraverso nuove lenti, cioè quelle dell’opportunità, visto che rappresenterebbe un’occasione unica per i giovani, una pietra miliare nel loro percorso formativo, con la possibilità di maturare crediti nel proprio curriculum professionale. Su questo tema sono ottimista perché in Europa si è aperto un dibattito sulla necessità di attribuire all’azione volontaria un valore decisivo, quale via di educazione non formale. Un riconoscimento che, dopo anni di rivendicazioni da parte del volontariato, finalmente anche l’Unione Europea ha fatto proprio, inserendolo nelle conclusioni finali dell’Anno europeo del volontariato. Nell’attività di ogni giorno, di fatto, l’aver vissuto un’esperienza che va al di là delle proprie competenze professionali, rappresenta già un valore aggiunto. E questo lo si può toccare con mano nelle aziende dove, in fase di selezione dei curriculum, vengono valutate anche le attività extrascolastiche di formazione dei candidati, che danno l’idea delle capacità di lavorare in squadra, a maggior ragione in un mondo del lavoro così complesso come quello attuale. Insomma, le società di selezione del personale stanno già riconoscendo le competenze non formali legate alle esperienze di servizio civile.
Dentro questa partita, magari prevedendo anche una serie di incentivi, avremmo un ritorno straordinario in termini di cittadinanza e anche di conoscenza, perché un giovane, nel corso di un’esperienza pur fatta per obbligo, potrebbe scoprire una passione nella vita o una spinta al bene che coltiverà nel suo tempo libero come azione volontaria. Se una persona, infatti, non si trova a vivere delle situazioni, o non ha l’opportunità di intercettare nuovi stimoli e di appassionarsi, è difficile che faccia determinate scelte, o comunque decida di investire una parte del suo tempo e del suo denaro, scommettendo su se stesso. Certo l’opportunità deve essere quella di poter fare esperienza in tessuti organizzativi legati a comunità locali: tutto questo potrebbe imporre un’accelerata al processo di svecchiamento di alcune forme di volontariato che esistono nei Paesi europei e aprire un po’ di finestre sul mondo, visto che obbligherebbe molte organizzazioni a riposizionarsi e ad aprirsi a idee e ad esperienze nuove. E, come si sa, le novità nelle organizzazioni provocano due tipi di reazione: il rifiuto per l’incapacità di modificarsi, oppure innovazioni straordinarie. Normalmente nel volontariato prevale più la seconda reazione. Ecco perché sono convinto che sarebbe un gioco al ritorno quasi assicurato per il volontariato.
Cambiando argomento, da sempre, ma in questi periodo ancor di più, il volontariato italiano, e immaginiamo anche quello di altri Paesi, è alle prese con una grave crisi economica, che si traduce anche in una difficoltà nel reperire fondi da parte della associazioni: sarà possibile, in futuro, immaginare un unico modello comunitario di fund raising?
Questo è un problema comune in tutta Europa. Le organizzazioni di volontariato, anche qualora non gestiscano servizi pesanti come quelli che riguardano l’assistenza sanitaria o il pronto soccorso, hanno un grosso problema di reperimento dei fondi. È un ostacolo che si presenta in tutta Europa e interessa sia l’aspetto del fund raising strettamente inteso (la capacità di raccogliere soldi dai privati rallenta perché la concorrenza è molto alta e in tempo di crisi le disponibilità diminuiscono, così come le fonti di finanziamento), sia quello di reperimento di progetti e fondi. E quest’ultimo caso si verifica, per lo più, per difficoltà burocratiche, per complessità del sistema, perché non si è sufficientemente attrezzati per partecipare a bandi complessi. Questo è uno dei tratti più comuni a tutta Europa e sui quali esistono più facilmente anche rivendicazioni comuni.
Non c’è una ricetta che funzioni?
Dipende dal tipo di problema. Su questo tema si affastellano molte questioni e tutte diverse tra loro. Non esiste una sola ricetta. Al contrario ce ne sono tante e questo perché le strutture fiscali, le donazioni e i lasciti, le modalità per la raccolta fondi nei diversi Paesi sono molto diversificate. Fino a pochi anni fa, in Italia, la questione dei lasciti testamentari era praticamente inaccessibile per le organizzazioni che non fossero le grandi sigle tradizionali e caritative del mondo cattolico, o forse qualche partito. Mentre il tema era più sviluppato nel mondo anglosassone sia per tradizioni e cultura, sia per l’elaborazione di forme giuridiche. Ci sono, quindi, tradizioni che non permettono di arrivare allo stesso meccanismo di raccolta delle risorse. Per esempio, il 5 per mille è stato, nel nostro Paese, un successo straordinario. I suoi effetti sono andati largamente al di là delle aspettative, tanto da imporre allo stesso legislatore la necessità di un intervento per mettere dei paletti, cioè aggiustando un meccanismo che, ancora oggi, non è completamente stabile. Il 5 per mille è stato per le casse delle associazioni una tal boccata d’ossigeno che, alcune di esse, dipendono per una larga fetta del loro bilancio da questo contributo. In altri Paesi, invece, lo stesso tipo di meccanismo, con clausole addirittura più avanzate, ha dovuto registrare una plateale sconfitta. Questa è la dimostrazione che lo stesso impianto di sussidiarietà fiscale dipende dalla storia sociale di ciascun Paese, dalle sue tradizioni e dalle sue abitudini. A questo proposito, ricordo che durante un seminario del Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro a Roma, Luca Antonini, vice presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, rimase particolarmente colpito dalla legge ungherese, molto più avanzata di quella italiana, perché garantisce la possibilità di destinare una parte delle proprie tasse non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche. Pensate quante risorse potrebbero essere dirottate sul settore del non profit se il 5 per mille fosse possibile anche per le imprese. Eppure, a fronte di questa legge, i numeri dell’operazione fiscale in Ungheria sono molto modesti. Perché? Semplice. Non è detto che gli stessi modelli funzionino allo stesso modo. Il medesimo discorso potrebbe essere replicato parlando della tradizione dei fund raiser britannici, largamente diversa da quella italiana, anche se si stanno facendo passi in avanti.
A proposito di finanziamenti e volontariato: le associazioni italiane, soprattutto di piccole e medie dimensioni, faticano a partecipare ai bandi europei. Quali consigli darebbe loro?
Quando parliamo di accesso ai fondi europei dobbiamo essere consapevoli del fatto che ci sono tante possibili ricette da mettere in campo con l’obiettivo di recuperare nuove risorse. Però va anche chiarito, in modo altrettanto deciso, che esistono anche alcune ambizioni da parte del volontariato che sono assolutamente spropositate. Da una parte, infatti, è legittimo e sensato che le associazioni bussino alle porte dell’Europa per chiedere sostegno economico per i propri progetti e in questo senso bisogna, come evidenziato da più parti, semplificare le procedure e le modalità di accesso ai bandi. Però è anche una pretesa fuori misura che piccole realtà associative, che nel tessuto italiano rappresentano ancora una componente rilevante dell’azione locale, possano trovare una risposta alle loro richieste nel ginepraio di finanziamenti europei, terreno in cui la concorrenza è altissima e sul quale si rischia di giocare una partita impari senza una regia da parte di associazioni più grandi. A questo proposito, l’Italia è stato il primo Paese europeo a rimettere in discussione la quota per il co-finanziamento dei progetti, che dovrebbe prevedere anche il riconoscimento del lavoro volontario, mettendo regole, fissando parametri di misurazione e un tetto massimo per evitare abusi. È infatti illogico che una organizzazione di volontariato che investe in un progetto, coinvolgendo in esso una quantità enorme di risorse impegnate gratuitamente, non possa far pesare questa voce nel budget per il suo finanziamento. Certo, il tutto va sottoposto a regole precise e mi rendo conto che queste voci siano difficilmente valutabili da un soggetto che, per lontananza geografica, incontra degli ostacoli oggettivi ad esercitare un controllo sugli abusi e una limitazione degli stessi. È un aspetto su cui è necessaria una riflessione di ampia portata, anche perché determina di fatto uno spostamento sulle priorità organizzative delle associazioni: se, infatti, nell’accesso ai fondi una realtà non vede riconosciuta e valorizzata l’azione sulle persone, allora tenderà a investire più sul reclutamento di fondi che non sul coinvolgimento dei volontari stessi. Del resto, nell’ambito di un progetto di solidarietà, si può rendicontare il pagamento di una collaborazione mentre non si può tradurre in moneta l’opera di duecento volontari che, spesso, costano uno sforzo enorme in termini organizzativi, ma che non trovano alcuna voce nei capitoli di bilancio. Di fronte a queste osservazioni, è evidente che ci sono ancora problemi strutturali da risolvere.
Come accennavo prima, però, resta una pretesa un po’ fuori misura che una piccola organizzazione di volontariato, con un bilancio di qualche decina di migliaia di euro, possa avere struttura organizzativa, capacità e dimensioni per poter interloquire e concorrere nel ginepraio infinito dei finanziamenti europei. Certo, è un’ambizione legittima, ma fuori misura. E anche largamente inconcludente, perché spesso porta a uno spreco immane di energie, oltre alla perdita di motivazioni di fronte a risultati molto scarsi. Senza contare, poi, che sarebbe troppo oneroso per una piccola-media realtà di volontariato capire come funzionano le regole a Bruxelles, partecipare a seminari, proporre dei progetti e così via. Penso che questo, alla lunga, provochi anche grandi distorsioni. Occorrerebbe invece lavorare di più su una divisione più produttiva dei compiti. Ecco perché, a questo punto, bisognerebbe percorrere anche in Italia una strada che in alcuni Paesi europei è già tracciata e che ha a che vedere con le grandi organizzazioni ombrello. Sono queste, infatti, che dovrebbero sviluppare un’attitudine di progetto di più ampio raggio. L’unica soluzione è lo sviluppo di una capacità di raccordo di organizzazioni ombrello o di grandi organizzazioni nazionali o di grandi coordinamenti su scala europea. L’organizzazione locale, invece, deve ottenere risorse dal livello territoriale. Eppure nel nostro Paese questo percorso è ancora tutto in salita, complice un campanilismo che spesso dissipa energie, anziché unire le forze.
Il welfare da riformare è un leitmotiv che ormai echeggia in tutta Europa. Ma nello stato sociale del futuro quale peso e quale ruolo dovrebbe avere il volontariato e la cittadinanza attiva?
Al di là dei ragionamenti di natura economica e di sostenibilità finanziaria, che sono assolutamente rilevanti e in futuro saranno del tutto determinanti, credo sia urgente rispondere a un bisogno che si è fatto molto più frastagliato e che richiede risposte molto più personalizzate piuttosto che di massa. Accompagnare un anziano in un percorso di vita che si è molto allungato e che si fa più complicato con carichi di malattie, disabilità, non autosufficienza, garantendo un minimo di servizi e di standard per tutti, è un percorso che si può sviluppare solo con una forte capacità organizzativa di tante strutture locali generate dai cittadini, in stretta collaborazione con gli enti locali. Il futuro del welfare in Europa dipenderà dal protagonismo delle diverse forme di cittadinanza attiva, per ripensare ad una organizzazione diversa del nostro tempo di vita e di lavoro, ma anche per valorizzare una dimensione di partecipazione diretta del governo del territorio. Saranno anche le ragioni economiche ad imporcelo, ma il concetto va ribaltato applicando fino in fondo il concetto di sussidiarietà. In che modo? Ampliando le realtà di assistenza esistenti, garantendo loro più strutturazione, più ordine, con un intervento del pubblico solo nel caso in cui tutte queste caratteristiche non riescano a garantire un servizio. Questo favorirebbe una ri-articolazione di un tessuto sociale meno abbandonato all’atomizzazione come quella che noi oggi viviamo nelle realtà urbane dell’era post moderna e mettendo in circolo una quantità di energia relazionale che fa dell’investimento sociale, dell’investimento sulla promozione di risposte collettive e anche del dono una qualità di vita associata, capace di garantire risposte molto più efficaci e meno costose di quelle attuali. I nostri servizi, invece, non sono preparati ad affrontare il cambio strutturale del calo demografico e dell’allungamento dell’età di vita e stanno diventando sempre più
insostenibili. Il futuro, quindi, è anche nelle mani di tutte le componenti del Terzo settore: l’obiettivo è che siano sempre più capaci e organizzate così da garantire risposte capillari.
Ovviamente, questo non deve coincidere con una deresponsabilizzazione del soggetto pubblico che, al contrario, è chiamato a stabilire regole uguali per tutti, oltre ad avere l’obbligo del controllo e del monitoraggio a garanzia dei servizi. Abbiamo di fronte una grande sfida che ci chiama, dobbiamo rispondere con convinzione a questa chiamata, nell’ottica di un protagonismo civico diverso e di un riconoscimento delle energie nascoste che sono presenti nella nostra società.
In un Europa sempre più unita non solo dalla moneta unica, ma speriamo anche da una politica comune, internazionalizzare la solidarietà resterà un utopia, o un sogno realizzabile?
L’Europa ha già realizzato nel corso della sua storia un’“Europa della solidarietà”. I Paesi europei nel dopoguerra sono stati ricostruiti grazie a una catena di politiche comuni. Per esempio l’agricoltura dipendeva dai sussidi americani, poi, con lo sviluppo del mercato comune europeo, ha scalato nuove vette fino ad arrivare a produrre beni di qualità sani e biologici. Questo è un esempio di solidarietà di produzione. Inoltre tutto il processo di accompagnamento alla conversione di politiche economiche e sociali, ad esempio con l’abbandono delle dittature di Spagna, Portogallo, Grecia e poi l’affrancamento dei Paesi dell’Est che prima erano divisi dalla cortina di ferro. Oggi questi Paesi sono parte integrante di un processo condiviso. La storia europea è quindi una storia di solidarietà, di condivisione, voluta per potere garantire pace e benessere a tutti. Un discorso che vale anche per la moneta unica che ha salvato sia i Paesi deboli, che vivevano in balia di monete più fragili, sia i Paesi più forti nei quali l’introduzione dell’euro ha garantito maggiore stabilità, minor rischio di speculazione e un allargamento del mercato dei prodotti. L’Europa si è costruita usando strumenti economici, ma traducendo nella vita di tutti i giorni una straordinaria solidarietà, con benessere e pace per tutti. La vera domanda a cui dovremo dare una risposta è un’altra: domani saremo ancora all’altezza di questa storia? Oggi siamo chiamati a fare un salto di qualità “terzium non datur” (non si dà la terza possibilità), le scelte importanti da fare sono serie, in parte dovute a una irresponsabilità che ha accompagnato l’età del “consumiamo tutti di più, al di là delle nostre possibilità” e oggi i nodi vengono al pettine per l’eccesso di indebitamento pubblico e privato. L’Europa ha davanti a sè o il tracollo o un salto più intenso in termini di coordinamento e di integrazione delle economie e delle società. Ma questo salto si potrà fare solo se si metterà in campo più solidarietà.