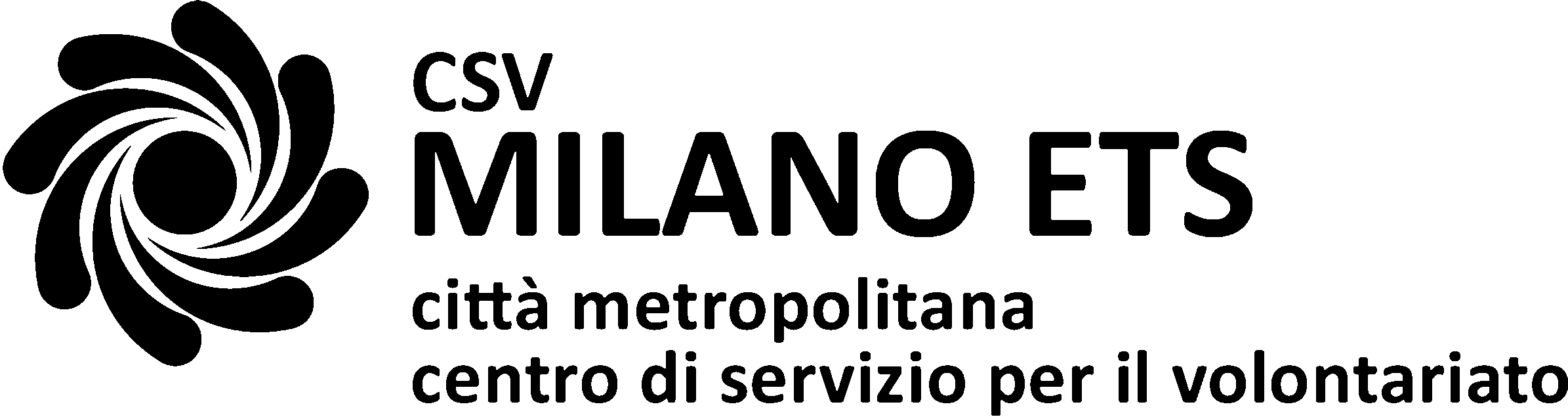Riforma Terzo settore: vincono corporazioni e mercato. Differenze e pluralismo azzerati
Piccoli enti esclusi dal dialogo con le istituzioni: avremo un non profit modello Confindustria. Per il sociologo Giovanni Moro, la Riforma tradisce anche la Costituzione
di Giovanni Moro, presidente di Fondaca
Non sono tra coloro che hanno salutato la riforma del Terzo settore come alba di una nuova era, anche se trovo giusto riconoscere che essa presenta aspetti positivi e nuove opportunità, oltre che – purtroppo in misura maggiore – criticità e rischi. La ragione principale delle mie perplessità è legata all’assenza di una precisa definizione delle attività di interesse generale, che pure dovrebbero essere l’elemento distintivo delle organizzazioni di Terzo settore. Ovviamente una lunghissima lista di campi o settori di policy, come quella contenuta nel Codice del Terzo settore (articolo 5.1, lettere a-z), non sostituisce una tale definizione, cosicché si può dire che a oggi il Terzo settore è solo il risultato di una operazione aritmetica: sottraendo al non profit i partiti, i sindacati, le associazioni imprenditoriali e professionali, le fondazioni bancarie ecc., ecco che appare il Terzo settore. Un così grande sforzo ha, insomma, prodotto un risultato terribilmente simile al precedente. Come conseguenza, le organizzazioni che scavano le macerie dei terremoti continueranno ad avere lo stesso valore di quelle che promuovono sagre gastronomiche.
Ma, al di là di questo, c’è un aspetto che il dibattito pubblico non ha considerato a sufficienza e che invece, a mio parere, merita la massima attenzione. E’ quello della cultura su cui la Riforma è stata costruita o a cui si ispira. Il punto è rilevante perché, come insegna l’analisi delle politiche pubbliche, ogni provvedimento di policy ha alla sua base un modo di rappresentare la realtà che contiene valori e disvalori; situazioni, comportamenti e standard di vita giudicati positivi o negativi; immagini della società desiderabile; priorità collettive e modalità per conseguirle. Concentrando lo sguardo sulla cultura sociale, politica e amministrativa che guida la riforma del Terzo settore, si possono cogliere alcuni modelli o paradigmi che è bene tenere presenti perché produrranno conseguenze rilevanti. Discutere degli effetti pratici della Riforma è sacrosanto; ma si devono considerare anche questi altri aspetti, che potrebbero risultare non meno importanti.
Senza pretesa di esaustività, voglio segnalare cinque modelli culturali che sono alla base della riforma e che, per quanto mi riguarda, aumentano di molto le perplessità su questa operazione.
La metamorfosi della cittadinanza attiva
Il primo di questi è il modello associativo. Per il legislatore la realtà del Terzo settore è costituita da associazioni, cioè da insiemi di persone che si uniscono in modo formale e permanente per perseguire finalità definite in modo univoco negli statuti e con mezzi prefissati per attuarle, promuovendo attività che li coinvolgono direttamente e in modo organico. Questo modello è sotteso a tutte le diverse forme giuridiche che la Riforma prevede.
Non ci sarebbe niente di male in tutto questo se non fosse che le forme concrete con cui i cittadini si uniscono e operano per scopi di interesse generale sono sempre meno o per nulla coerenti con questo modello. Come tutti coloro che hanno rapporti con la realtà sanno perfettamente, da tempo le modalità organizzative della cittadinanza attiva si stanno trasformando e pluralizzando: una organizzazione può avere contemporaneamente molte delle forme previste dalle leggi, o anche una del tutto diversa da quelle stabilite, pur continuando a svolgere attività di interesse generale. Fin troppo facile, al proposito, fare l’esempio della miriade di iniziative civiche su Internet, che di “associativo” non hanno proprio nulla, ma che sono sempre più diffuse e rilevanti. La cultura del legislatore, tuttavia, non ne coglie nemmeno la esistenza.
Questo divorzio dalla realtà riguarda anche le forme di adesione degli individui, disegnando un cittadino attivo che è essenzialmente socio di un’associazione, con un legame di tipo formale di lunga durata e che partecipa a tutta la vita dell’associazione stessa. Le cose però non stanno più così: esiste una molteplicità di modi di partecipazione a una organizzazione civica che sono limitati nella durata, focalizzati nel campo di intervento o concentrati su un ruolo da svolgere o una operazione da compiere, ma non per questo sono meno rilevanti. Si tratta di cittadini che partecipano, ma magari non votano nelle assemblee statutarie; mentre sovente accade anche l’opposto. Un caso estremo ma niente affatto marginale è quello del cosiddetto volontariato occasionale: persone che prestano la propria opera per un periodo di tempo o per un solo progetto da realizzare. Come tutta questa realtà plurale possa entrare nei libri degli associati o nei registri dei volontari non è difficile da capire: non ci entra per nulla.
«Mettere a sistema il Terzo settore»
Un altro modello culturale che ispira la riforma lo chiamerei amministrativizzazione delle organizzazioni di Terzo settore. Si è sentito ripetere, lungo tutto l’iter della Riforma, l’espressione “Mettere a sistema il Terzo settore”; ed è appunto proprio questa la visione del legislatore. In base a questo modello, le organizzazioni di Terzo settore esistono in quanto soddisfano precisi e minuziosi criteri di tipo burocratico, ma anche perché svolgono un ruolo di tipo para-amministrativo, cioè funzionale agli scopi, alle priorità e alle attività dell’amministrazione. Una prova evidente sta nella prima stesura del Codice del terzo settore, dove si diceva che tra le attività svolte da queste organizzazioni ci sono “prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) come definiti dalle disposizioni vigenti in materia” (articolo 5.1, lettera b). E’ l’amministrazione, insomma, ad essere l’unico soggetto che definisce e pratica attività di interesse generale, alla cui realizzazione le organizzazioni di Terzo settore collaborano. Inutile dire che in tutto questo non c’è alcuno spazio per soggetti, problemi, luoghi e valori inascoltati o marginalizzati, così come per un rapporto paritario di tipo politico (che comporta anche il conflitto) tra organizzazioni civiche e istituzioni.
Va aggiunto che questo modello culturale emerge in modo ricorrente nel nostro Paese, probabilmente come reazione alla progressiva perdita di poteri e legittimazione delle istituzioni pubbliche, di fronte alla quale si cerca di conformare la realtà alle logiche e alle esigenze dell’amministrazione. Se ne possono trovare, ad esempio, chiari sintomi nel codice di condotta che le Ong italiane impegnate nel soccorso ai migranti in mare hanno dovuto firmare, o nelle forme di regolamentazione delle attività di volontariato al livello locale, o negli stessi regolamenti comunali per la “amministrazione condivisa” dei beni comuni. Che tutto questo possa ricostituire, o almeno sostituire, la fiducia dei cittadini, è davvero molto improbabile.
Sì al volontariato, ma solo a buon mercato
Un terzo modello culturale che ispira la Riforma è quello che identifica la mission canonica delle organizzazioni di Terzo settore nella erogazione di servizi, che ciò avvenga in chiave di mercato o di prestazioni d’opera alla pubblica amministrazione. Del resto, le parole “utenti” e “prestazioni” risuonano nei testi normativi; e anche previsioni interessanti come quelle legate alla co-programmazione e alla co-progettazione sono funzionali alla erogazione di servizi. Niente di simile, invece, è previsto con riferimento ad altre strategie operative delle organizzazioni di cittadini diverse dalla erogazione di servizi, quali l’advocacy o l’intervento diretto in luoghi e situazioni. Non c’è da stupirsi che, all’articolo 56 del Codice, si affermi che le convenzioni con organizzazioni del Terzo settore possano essere stipulate all’unica condizione che esse siano economicamente più vantaggiose rispetto ai prezzi di mercato. Anche la retorica (spesso si tratta proprio di una retorica) sulle qualità relazionali del Terzo settore che rappresenterebbero un valore aggiunto rispetto alle offerte pubbliche e private di gestione dei servizi, qui è scomparsa. Erogatori di servizi, insomma, ma al massimo ribasso; oppure venditori di servizi nel mercato del welfare. Non c’è niente di strano, in questa logica, nel fatto che per essere definita “di volontariato” una organizzazione possa avere anche solo il 50% dei soci volontari; o che nella compagine delle imprese sociali ci possano essere anche aziende private e amministrazioni pubbliche.
Una rappresentanza morta in culla
Un altro aspetto della cultura del legislatore è chiaramente identificabile come un modello di rappresentanza di tipo corporativo, del tutto simile a quello, per intenderci, di Confindustria e sindacati: ci sono organizzazioni che rappresentano interessi di lavoratori e datori di lavoro; e in base alla quantità dei loro iscritti, quelle “maggiormente rappresentative” negoziano a nome di tutti, ad esempio il contenuto dei contratti di lavoro. Come tutti sanno, questo modello funziona sempre meno per l’ambito per il quale è stato inventato; ma nel caso del Terzo settore non funziona affatto e non potrà mai funzionare.
Nel nostro caso, infatti, non si può definire chiaramente né qual è l’universo dei soggetti rappresentati (chi), né quali sono gli interessi che vengono rappresentati (cosa), né le forme di verifica sulla esistenza e la qualità della relazione rappresentativa (come). Di conseguenza, nella incertezza di chi parli a nome di chi, e soprattutto chi sia legittimato da chi, l’amministrazione decide che tratterà solo con la più importante organizzazione in termini quantitativi (numero di aderenti) e solo con quella. E’ un po’ come se il Governo, quando convoca i sindacati, invitasse solo la Cgil e non anche la Cisl e la Uil. Il modello corporativo, quindi, in questo caso, oltre che a sproposito, è anche utilizzato in modo escludente. Per decisione del Governo, quindi, ci sarà una e una sola “Confindustria del Terzo settore”. Sarà anche comodo per gli assessori e i funzionari che vogliono “parlare con uno solo”, ma che senso ha?
Su questo punto ci sono poi da considerare due aspetti tutt’altro che marginali. Il primo è che le situazioni e le posizioni di cui molte organizzazioni di Terzo settore si occupano sono irrilevanti in termini quantitativi ma costituiscono una priorità perché riguardano ad esempio diritti umani che valgono, come è noto, anche per una singola persona. Una associazione che difende i diritti dei portatori di una malattia rara o di minoranze etniche non sarà mai “maggiormente rappresentativa”, ma è importante almeno quanto una associazione con milioni di soci (della cui reale esistenza, peraltro, non viene prevista alcuna certificazione esterna). Inoltre – questo è il secondo aspetto – si ignora il fatto che, quando una organizzazione che si occupa ad esempio di disabilità avanza le sue proposte al Governo, alla Regione o al Comune e sottoscrive un accordo sul modo di impiegare il denaro pubblico, non sta “parlando a nome” e “agendo per conto” (questo vuol dire rappresentanza) solo dei suoi associati, tanti o pochi che siano, ma di tutte le persone con disabilità. In casi simili i sindacati indicono un referendum tra i lavoratori per verificare il loro consenso; ma qui chi e come dovrebbe essere coinvolto? Il tema della rappresentanza, insomma, è estremamente complesso e delicato anche perché tocca questioni costituzionali. Ma la consapevolezza di questo è estranea alla cultura su cui la Riforma si fonda.
Se legge tradisce la Costituzione
Proprio a proposito della cultura costituzionale dei legislatori va annotato un ultimo modello culturale, che però è il più importante e forse all’origine di quelli citati fin qui. Si tratta della negazione del principio costituzionale dell’autonomia delle formazioni sociali. Dato che il linguaggio tradisce sempre le intenzioni, il fatto che si sia intitolata una legge “Riforma del Terzo settore” ci dice di un mancato riconoscimento della autonomia e della libertà delle organizzazioni di Terzo settore in quanto formazioni sociali, come le chiama la Costituzione all’articolo 2.
Il punto è che le formazioni sociali non possono essere riformate, né dal Governo, né dal Parlamento. Esse sono infatti la espressione dell’autonomia della società e lo Stato deve limitarsi a riconoscerle, garantendone le possibilità di sviluppo; e in particolare nel caso di quelle che si occupano di attività di interesse generale, le deve favorire senza condizioni (articolo 118). Qui invece siamo andati oltre. Quanto oltre ce lo può far capire l’esercizio di sostituire alla espressione “Terzo settore” quella di “Chiesa cattolica”, o quella di “sindacati dei lavoratori”, due indiscutibili esempi di formazioni sociali. A nessuno verrebbe mai in mente di intitolare una legge “Riforma della chiesa cattolica”; e quando alcuni mesi fa Luigi Di Maio dichiarò la intenzione del Movimento 5 Stelle di farlo per i sindacati ci fu una giusta levata di scudi. Invece quando una legge con questo titolo è stata promulgata sul Terzo settore nessuno ha obiettato. Resta il fatto, però, che le organizzazioni di Terzo settore sono formazioni sociali e non possono essere riformate dal potere politico, o – peggio – dall’amministrazione.
Per concludere, non saprei dire se questi cinque modelli culturali – quello associativo, quello amministrativo, quello della erogazione di servizi, quello della rappresentanza corporativa e quello della “messa a sistema” delle formazioni sociali – siano dovuti a una precisa volontà politica (come qualcuno dice) o più semplicemente a una cultura primitiva. Resta il fatto che la (cosiddetta) riforma del Terzo settore ne è impregnata. Questa non è una buona notizia e richiede, da parte dei soggetti coinvolti nella Riforma, una attenta vigilanza, nonché uno scatto in quella capacità di essere interlocutori qualificati anche sul piano della cultura pubblica che è stata finora a dir poco carente.
(Tratto da numero 3 di Vdossier anno 2017)