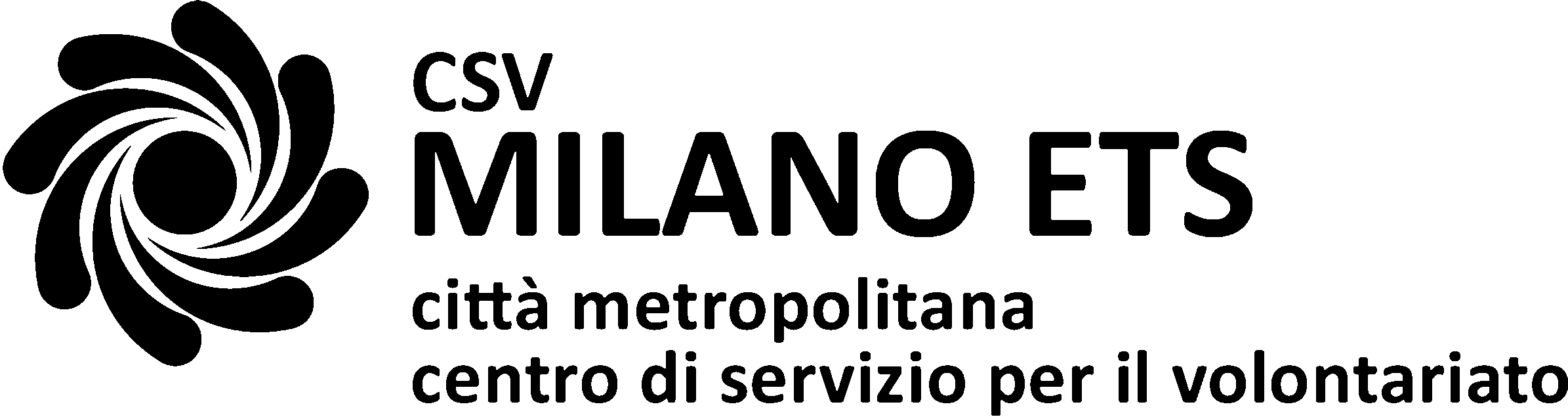Sharing economy: crescono piattaforme e utenti
Aumenta l’impatto dell’economia collaborativa. Le cifre lo confermano. Dati in rialzo in Italia e in Europa. Una rivoluzione non solo economica: cambia anche lo stile di vita
di Elisabetta Bianchetti
Milano, luglio 2018 –
«Governare con lungimiranza questa rivoluzione con regole a livello comunitario». L’appello è riportato nero su bianco in un dossier che giace negli archivi della Commissione mercato interno del Parlamento europeo. Una richiesta che misura l’importanza acquisita dalla sharing economy e conferma il peso che si prevede abbia in futuro. Parole supportate dalle stime che circolano a Strasburgo: un ritmo di crescita del 25% l’anno e ricavi per oltre 3,6 miliardi di euro nel 2015. Una somma di denaro che potrebbe sfondare, nel solo Vecchio Continente, quota 83 miliardi già nel 2025 su un giro d’affari di 570 miliardi. Sono questi i numeri che fanno dell’economia della condivisione – Airbnb, Uber, BlaBlaCar ma anche tanti servizi sociali – uno dei fenomeni di questi anni post recessione.
Noleggio, donazione, prestito, coabitazione, co-lavoro: nuovi modelli, spesso anche micro, basati sulla condivisione di beni, servizi, informazioni e competenze. Nel mondo, in Europa e anche in Italia, sull’onda della crisi del 2008, l’economia collaborativa è diventata un terreno fertile. E il seme della sharing economy sta cambiando la cultura del consumo e della produzione, spostando il confine tra pubblico e privato. Due poli tra i quali si sta facendo largo anche il Terzo settore. Perché condividere è bello, utile, costruttivo e sostenibile. Virtù che sono un’iniezione di fiducia nel motore della crescita.
La galassia sharing è variegata. Non ha una direzione unica. È piuttosto un seme di cooperazione diffuso con varie modalità, avendo soprattutto per volano le opportunità del web. In sintesi, potremmo dire che è il “social” trapiantato su un piano economico.
Le parole che contano nel fenomeno sono varie: “sharing”, la condivisione in senso stretto; “swapping” il baratto, lo scambio di beni visto come nuova forma commerciale; e poi vi è il crowding, dall’inglese “crowd” folla, che è la pratica dove più persone si uniscono per creare un servizio o un prodotto, tramite idee creative in caso di crowdsourcing o tramite risorse economiche in caso di crowdfunding.
Dagli Usa all’Italia, un’ascesa incessante
La crescita e la diffusione dell’economia collaborativa è confermata dai numeri. La sharing è un mercato che rapida ascesa negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, al punto che ha superato il tetto del 1,3% del Pil (Prodotto interno lordo). Una percentuale destinata a salire al 15% entro i prossimi cinque anni, secondo le stime di collaborativeconsumption.org nello studio “The people who share”. Lo studio rivela anche che il 64% degli adulti britannici pari a 32,5 milioni di persone ha dichiarato di prendere parte all’economia della condivisione in maniera attiva. Negli Stati Uniti il 52% dei cittadini ha affittato o prestato i propri beni negli ultimi due anni e l’83% ha detto che farebbe altrettanto se fosse più facile.
Anche in Italia il fenomeno cresce a ritmo sostenuto. Le piattaforme che offrono servizi collaborativi in Italia sono ad oggi più di 120, a cui se ne aggiungono quaranta di crowdfunding e almeno cento coworking. Si può passare infatti da beni materiali come la macchina fotografica, la bicicletta, il computer a spazi come la casa (co-housing), una stanza o luoghi di lavoro; ci sono servizi collaborativi dove si scambiano idee, tempo, competenze e alcune volte anche denaro.
Gli esempi sono svariati da Warmshowers, che offre ospitalità gratuita ai cicloturisti a GuestToGuest per scambiare gratuitamente casa. Poi c’è il mondo creativo e co-working di “The Hub”, una rete di spazi fisici dove imprenditori, creativi e professionisti possono accedere a risorse, lasciarsi ispirare dal lavoro di altri, condividere idee innovative, sviluppare relazioni utili e individuare opportunità di mercato. È una società di capitali indipendente dedicata alla social innovation, un mondo neppure tanto utopistico di “changemakers”, persone che vogliono cambiare il mondo attraverso progetti nuovi. A questo proposito fare un giro nella sede di Milano o in quella di Roma a San Lorenzo di “The Hub” è rigenerante e non solo per i giovani appena usciti da scuole superiori o università ma anche per chi vuole ripartire. Nato nel 2005 in Gran Bretagna, in Italia è anche in Trentino, in Sicilia, a Trieste, Bari e Firenze.
Fisco e previdenza, gli anelli deboli
L’economia della condivisione piace e fa sempre più proseliti. Eppure non mancano le ombre. Critiche lanciate soprattutto dai sindacati che puntano l’indice su fisco e previdenza. Una ricerca del 2016, durata dodici mesi e promossa dalla Fondazione europea per gli Studi progressisti (FEPS) e da UNI Europa (la federazione internazionale dei sindacati), analizza come la “sharing economy” focalizzandosi su Regno Unito e Svezia, due avamposti del comparto. I dati sul Paese scandinavo mostrano che il 12% della popolazione sta già lavorando nell’economia digitale basata sulle piattaforme online, mentre il 24% sta cercando di trovare lavoro attraverso le nuove tecnologie. Nel Regno Unito cinque milioni di persone sono pagate mediante le piattaforme online; di queste, più di tre milioni sono regolarmente impegnate in varie forme di “crowd working”. Ma per questi lavoratori i vantaggi sono di gran lunga inferiori rispetto ai svantaggi, vale a dire lavoro precario senza coperture sociali, senza indennità di malattia, ferie, contributi pensionistici o garanzie di salario minimo. Così come le pratiche di crowd-sourcing non prevedono alcun pagamento a titolo di imposte sul reddito né versamento di contributi sociali. Ciò potrebbe comportare, in futuro, il rischio di mancati introiti fiscali e previdenziali per gli Stati, quindi una perdita di risorse economiche. Di fronte a questa fotografia in chiaroscuro, in un congresso a Roma, Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, ha evidenziato una serie di questioni aperte a proposito dell’asse sharing-lavoro. «Sebbene la ricerca sia focalizzata su Gran Bretagna e Svezia, i risultati sono rappresentativi per l’intera Europa, compresa l’Italia, dove la crescente economia detta “crowd working” è parte del nuovo mondo del lavoro ed è innegabile che essa abbia un potenziale di sviluppo positivo per la società. In questo momento, però, stiamo vedendo principalmente l’aspetto negativo di un mercato del lavoro quasi completamente non regolamentato». Da qui, sempre secondo Camusso, la necessità di di «lottare per un lavoro davvero dignitoso e di chiedere all’Ue il varo di standard minimi comunitari da applicare in tutti i Paesi».
Nonostante l’allungarsi del cono d’ombra su lavoro, fisco e previdenza; nonostante l’appello all’Unione europea perché si faccia carico di instaurare un ordine normativo in questo nuovo mondo della condivisione, resta il fatto che una rivoluzione è in corso: «Il grande pubblico se ne sta accorgendo lentamente, anche se si tratta di un cambiamento radicale dei nostri stili di vita – spiega April Rinne, una delle maggiori esperte a livello internazionale sulla sharing economy -. Un mutamento profondo: non soltanto economico, ma anche del modo di pensare, di relazionarsi con gli altri, di far parte della propria comunità. Un capovolgimento nel nome del risparmio, della sostenibilità, della collaborazione, della reciprocità e della fiducia».
Una geografia di valori che appartengono al Dna dell’economia della condivisione, la quale si presenta sempre più come una medaglia con due facce: da un lato il settore profit sta vivendo una profonda trasformazione e i numeri lo confermano, dall’altro lato, come un ‘effetto valanga, la sharing comincia a diffondersi nel non profit. Una tendenza e un fenomeno sui quali è ormai necessario che si sposti l’attenzione del volontariato e, più in generale, del Terzo settore.
La mappa delle piattaforme collaborative
Cruciale a tale riguardo è il quadro che emerge dalla terza indagine sulle piattaforme collaborative presenti in Italia e che si pone l’obiettivo di approfondire lo studio della sharing economy da Nord a sud della Penisola. Curata da Ivana Pais di Unicatt TRAILab e da Marta Mainieri di Collaboriamo.org, (piattaforma di informazione e servizi sulla sharing economy), la ricerca permette di individuare alcuni interessanti spunti di riflessione al fine di delineare le caratteristiche dei servizi attivi nel nostro Paese e osservare l’influenza economica, occupazionale e ambientale dell’affermarsi del modello collaborativo. Ecco perché i principali risultati emersi dall’analisi sono di seguito descritti utilizzando la chiave di lettura dell’impatto (che ha caratterizzato anche la presentazione dello studio nel corso di Sharitaly, il principale evento del settore in Italia) che la sharing economy dimostra di avere sulla società attuale. Come rileva anche l’indagine, prima di tutto occorre focalizzarsi sull’impatto della crescita.
Come negli anni precedenti, anche nel 2016 il numero delle piattaforme collaborative attive è aumentato (più 10% rispetto al 2015). Va precisato comunque che rimane alto il tasso di mortalità, con l’11% delle piattaforme attive nel 2015 che risulta ad oggi inattivo. Rispetto al 2015, tutti i settori registrano un numero pari o superiore di piattaforme attive; i trasporti, lo scambio/affitto/vendita di oggetti e il turismo continuano a rappresentare gli ambiti dove si concentra il maggior numero di aziende collaborative. Da segnalare la crescita delle piattaforme dedicate ai servizi alle imprese, alla cultura e alla formazione.
Cresce anche il numero degli utenti della community: nello specifico, oggi il 31% delle piattaforme sharing raggiunge più di 30mila utenti (erano il 20% nel 2015). Nonostante questo, però, il mercato si dimostra ancora poco maturo, con un numero di transazioni ancora limitato e non sufficiente a garantire un ritorno economico adeguato. A questo si aggiunge la difficoltà nel trovare finanziamenti, che porta gran parte degli imprenditori a investire, soprattutto inizialmente, i propri capitali personali. Anche l’ecosistema in cui sono inserite appare ancora piuttosto debole ed evidenzia rapporti frequenti delle piattaforme soltanto con clienti e fornitori.
Gli effetti su occupazione e politica
Un secondo elemento da analizzare è l’impatto sull’occupazione. In particolare, i fondatori delle piattaforme collaborative italiane sono per lo più uomini, laureati, con un’età media di 39 anni e molto spesso con precedenti esperienze imprenditoriali. Si tratta inoltre di persone che spesso lanciano un servizio pur mantenendo delle posizioni lavorative pregresse, diminuendo così i rischi connessi all’avvio di una nuova attività ma, contemporaneamente, sottraendo tempo e energie fondamentali per far crescere la piattaforma. Per quanto riguarda i collaboratori, in linea con quanto emerso negli anni scorsi, sono poche le piattaforme con più di quindici occupati; mediamente si tratta di aziende con sei collaboratori. È inoltre interessante approfondire la percezione che le piattaforme collaborative hanno del proprio impatto sulla vita degli utenti. Fra i principali benefici che si riconoscono all’economia collaborativa, le piattaforme dichiarano di generare soprattutto, nell’ordine, un impatto relazionale, organizzativo, economico e, infine, ambientale. L’impatto economico e organizzativo è più forte nel settore dei servizi alle persone, dove gran parte delle piattaforme propongono prevalentemente scambi monetari; l’impatto relazionale è più forte nei trasporti dove prevale il carpooling che ha una forte componente relazionale e quello ambientale è più forte nel settore dello scambio/vendita/affitto oggetti dove prevalgono le piattaforme che si occupano di riuso. A fronte di queste dichiarazioni, però, occorre sottolineare che le piattaforme che hanno introdotto modalità per la misurazione degli impatti sono ancora poche.
Per quanto concerne invece l’impatto sulle politiche, le piattaforme collaborative italiane auspicherebbero innanzitutto un regime di favore sia in ambito fiscale, che in ambito giuridico. Queste aziende percepiscono la mancanza di una legge dedicata alla sharing economy e riconoscono l’importanza di un sistema di autoregolamentazione (per es. un codice etico) e di una distinzione tra operatori professionali e non. Infine, relativamente all’impatto economico, come già emerso nelle edizioni precedenti dell’indagine, anche nel 2016 la percentuale sul transato risulta il modello di business più utilizzato (per il 36% delle piattaforme è l’unico canale utilizzato), seguito dall’abbonamento, dalle sponsorizzazioni e dalla pubblicità sulla piattaforma. Gli investimenti continuano a rimanere bassi (la grande maggioranza delle piattaforme non investe più di 50mila euro all’anno) e a interessare prevalentemente le risorse umane e tecnologiche. A partire da questi spunti sarà interessante valutare, nei prossimi anni, se e come assisteremo a un processo di maturazione delle piattaforme e come si cambierà l’intero sistema che ruota attorno alla sharing economy.
Millennials i protagonisti di domani
Se questa è la fotografia scattata per l’Italia, una panoramica sull’Europa – contenuta in uno studio del network internazionale PwC – ha rilevato che, nel 2015, nei principali stati europei (Svezia, Polonia, Italia, Belgio, Spagna, Germania, Olanda, Regno Unito, Francia) sono attive 275 società del mercato della sharing economy. Sia nel Regno Unito che in Francia si contano più di 50 società di questo settore, mentre sono più di 25 le imprese presenti in Germania, Spagna e nei Paesi Bassi. Meno di 25 società, invece, sono operanti in Svezia, Italia, Polonia e Belgio.
Questi dati possono essere letti alla luce dei diversi regimi normativi che, ad esempio in Francia e nel Regno Unito, favoriscono la diffusione dei nuovi modelli di business di questo mercato.
Nel panorama europeo però l’Italia fa ancora fatica a trarre completo beneficio dalla sharing economy. Una ricerca commissionata da “PHD Italia” e condotta nel giugno 2016 dall’Università degli Studi di Pavia afferma che nel 2015 questo mercato ha generato un giro d’affari pari a 3,5 miliardi di euro e tra 10 anni potrebbe valere fino a 25 miliardi. È evidente, quindi, il ruolo ormai rilevante che ha l’economia della condivisione sugli stili di vita e i consumi degli italiani, ma allo stesso tempo è importante considerare i limiti esistenti che frenano una rapida diffusione di questi nuovi servizi. L’Italia è, infatti, tra i paesi europei con maggior ritardo nel processo di digitalizzazione dell’economia e della società. Un dato, questo, confermato dal Digital Economy and Society Index 2016 (Dise), indice sviluppato dalla Commissione Europea per misurare il grado di diffusione del digitale nei paesi Ue, che confina l’Italia alla 25esima posizione tra i 28 Paesi dell’Unione europea.
Nel nostro Paese sono soprattutto i Millennials a utilizzare i servizi di sharing economy: i giovani che appartengono ad una fascia d’eta compresa tra i 18 e i 34 anni hanno, infatti, sviluppato una cultura della condivisione e dell’accesso ai beni e ai servizi più che al possesso di questi ultimi; inoltre, a causa della crisi e dei tanti cambiamenti sociali sono diventati più attenti al risparmio e alla convenienza. Per questo motivo tra i giovani servizi come quelli dell’home sharing o del car sharing trovano meno resistenza e si diffondono più facilmente. Le tecnologie e il digitale rendono più semplice ed economico trovare modi per condividere risorse, connettere persone, condividere oggetti o accedere a piattaforme di sharing già attive.
La sharing economy per crescere realmente e affermarsi come digital disruption necessita, però, di diffondersi tra tutte le fasce d’età. In Italia, infatti, il coinvolgimento degli over 34 nel target di riferimento della sharing economy porterebbe ad un mercato con valore tra lo 0,7% e l’1,3% del Pil nel 2025. Una proiezione ottimistica che sottolinea come l’innovazione e il digitale possano essere un volano per l’economia italiana.