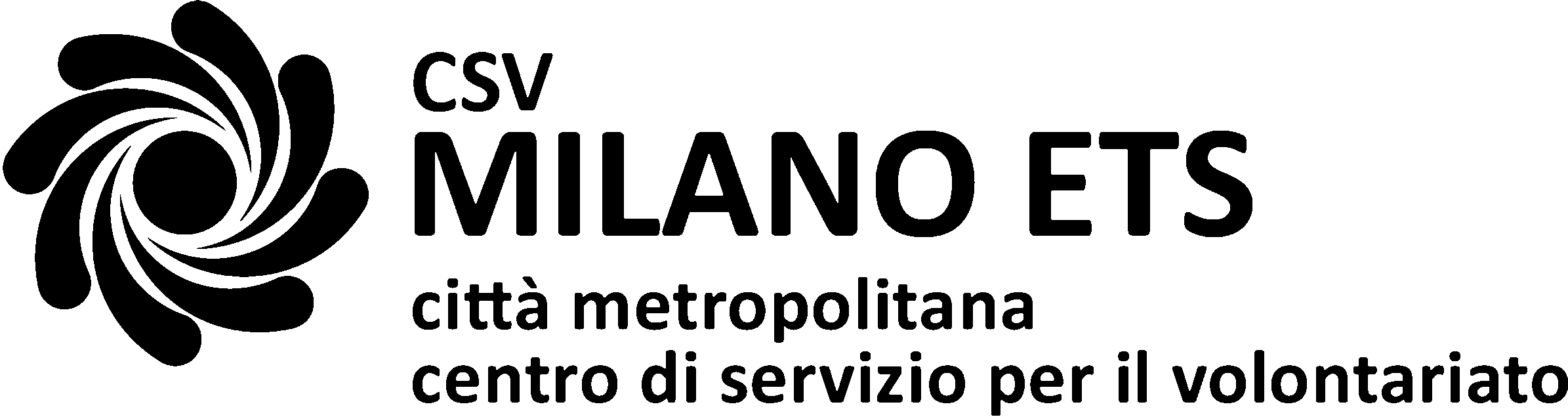Stato (non più tanto) sociale. Alle radici del nuovo modello pubblico, privato e civile
ll welfare state cede il passo al welfare civile: l’economista Stefano Zamagni illustra i quattro pilastri che sorreggono il nuovo sistema. Il Terzo settore sarà protagonista
di Paolo Marelli
Dove andrà il welfare? E soprattutto quale ruolo giocherà il Terzo settore dopo la sua Riforma? Come superare il dilemma della “coperta corta”, che antepone l’impennata della domanda sociale ai tagli alla spesa pubblica? Cavalcando l’attuale onda del consenso e della diffusione, il welfare aziendale sarà la risposta ai bisogni di una fetta della nostra società? Oppure quali altre soluzioni escogitare? Questi sono alcuni degli interrogativi che rimbalzano da un capo all’altro della Penisola, da Nord a Sud, anche se la lista delle domande potrebbe allungarsi ancora. Sono quesiti che interpellano non soltanto la classe politica, le organizzazioni sindacali, intellettuali e studiosi, ma anche il non profit. Perché oggi quest’ultimo, è ormai assodato da anni, recita un parte sempre più importante di sostegno al pubblico e per la salvaguardia dei beni comuni. Ma domani, alla luce del riordino tracciato dalla nuova legge, quale peso avrà? Così come, è il dubbio che tanti esperti sollevano, perché la riforma del Terzo settore non ha camminato a braccetto con una rivoluzione del welfare? O quantomeno si è detto a quale modello ispirarsi o quale direzione indicargli?
Se perplessità, critiche e interrogativi sono alla luce del sole, l’unica certezza in questo orizzonte in chiaroscuro è che in Italia, da sempre, il welfare sociale pubblico è sotto-finanziato. E anche se, nel 2017, il vento della crescita economica ha ripreso a soffiare dopo nove anni, rimane il fatto che la distribuzione degli stanziamenti da Roma è blindata da vincoli di bilancio. Dopotutto, se nel 1950 la spesa pubblica corrispondeva al 20 per cento del Pil (Prodotto interno lordo), nel 2010 ha raggiunto il 50 per cento. E nei prossimi anni, le risorse statali e locali saranno sempre meno sufficienti e la loro assegnazione sarà sempre più complicata.
La crisi del sistema americano ed europeo
Come abbiamo visto, lo scenario che abbiamo di fronte è intricato e tortuoso. Ma le domande poste finora non sono secondarie. Semmai fotografano una realtà in divenire. Sono lo specchio di un modello sociale che ha bisogno di cambiare i propri protagonisti ed è a caccia di modelli di riferimento. Anzi, i quesiti sollevati sembrano il terreno fertile sul quale avviare una riflessione di più ampio respiro. Considerazioni che aiutino a comprendere sia la crisi del modello americano di welfare capitalism, sia del modello di welfare state che si è andato realizzando in Europa occidentale a cominciare dalla fine della seconda guerra mondiale.
L’analisi di questa duplice crisi è quanto mai un passaggio obbligato che servirà da guida per suggerire il modello di welfare di cui le nostre società post-industriali hanno urgente bisogno per affrontare con successo le sfide odierne. E inoltre è la leva sulla quale far forza per illustrare i quattro principi a fondamento del welfare civile verso cui, è la tesi dell’economista Stefano Zamagni, le nostre comunità dovrebbero muoversi con passi rapidi e decisi. Argomentazione sostenuta in un saggio (“L’evoluzione dell’idea di welfare: verso il welfare civile”) del 2015. Ma il professore dell’Università di Bologna fa notare che non si tratta di «una crisi dei valori che lo hanno sorretto fin dal suo nascere, né è la negazione del fatto che le conquiste dello stato sociale rappresentano una delle manifestazioni più alte di progresso democratico per la civiltà occidentale. La radice della crisi di tale modello non è di natura fiscale – questa è piuttosto l’effetto, non la causa – ma è da rinvenirsi nella sua incapacità di coniugare, in modo sostenibile, equità e libertà. I cittadini delle nostre società avanzate non accettano più rinunce alla loro libertà per conseguire più elevati standard di tutela dai rischi. Quando il perseguimento della sicurezza sociale entra in rotta di collisione con l’allargamento degli spazi di libertà è l’efficienza stessa a risentirne: di qui la crisi fiscale e perciò l’insostenibilità finanziaria dello stato sociale».
Il tallone d’Achille del welfare capitalism
A partire dagli anni Venti del secolo scorso, l’edificio del welfare capitalism (capitalismo del welfare) a stelle e strisce si fondava sull’accordo grazie al quale «alle imprese spettasse il compito di farsi carico delle sorti di benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie e ciò in forza del principio di restituzione (restitution principle). L’impresa restituisce così una parte dei profitti che ha conseguito a coloro che hanno concorso a ottenerli. È questo un principio che è tipico della matrice culturale americana: bisogna restituire post factum una parte di quello che è stato ottenuto grazie anche al contributo che la comunità ha dato al buon svolgimento dell’attività produttiva. Ma a partire dagli anni successivi alla grande crisi del 1929, il modello del welfare capitalism comincia la sua parabola discendente: in parte per la trasformazione delle corporation americane da private company (dove uno o pochi proprietari dirigono e controllano l’impresa) a public company, con migliaia di azionisti che mirano solo al profitto; in parte perché non soddisfa il requisito dell’universalismo. Quest’ultimo si rivela come il suo autentico tallone d’Achille: il patto non ha valore erga omnes, trattandosi di un atto di tipo privatistico su base volontaria.
Ascesa e caduta del welfare state
Un welfare particolaristico, come il welfare americano, non assicura però una pace sociale, né tantomeno serve a ridurre le ineguaglianze e garantire la coesione sociale. Per superare questo limite in Gran Bretagna, nel 1939, l’economista John Maynard Keynes, in un suo saggio (“Democracy and efficiency”), sosterrà che solo con l’universalismo del welfare ci sarà ordine sociale democratico.
In linea con questa intuizione, nel 1942, Lord William Beveridge, membro del parlamento inglese, farà approvare il “pacchetto Beveridge”, da cui prenderà avvio il servizio sanitario nazionale, l’assistenza gratuita a disabili e anziani non autosufficienti, la scuola gratuita fino a una certa età per tutti. Ha così inizio nel Regno Unito il modello del welfare state: è lo Stato e non più l’impresa che si prende cura del benessere dei cittadini. Notevoli sono stati i meriti e i successi del welfare state, tanto più che ha rafforzato la democrazia in Europa occidentale. Ma, osserva Zamagni, negli ultimi venticinque-trent’anni, «anche questo modello ha iniziato ad accusare disturbi seri, svelando un duplice tallone d’Achille». Il primo è quello della sostenibilità finanziaria: «I servizi di welfare, se vogliono essere di qualità, tenendo il ritmo del progresso scientifico e tecnologico, hanno costi crescenti nel tempo e la fonte principale che lo Stato ha a disposizione per coprirli è la tassazione generale. Ora per rendere quest’ultima sufficiente a coprire l’intera spesa, si dovrebbe arrivare ad applicare livelli di pressione tributaria insostenibilmente elevati, il che minaccerebbe la crescita stessa del prodotto». Il secondo è la standardizzazione dei servizi offerti: «I bisogni delle persone non sono standardizzabili. C’è un’asimmetria tra i bisogni umani, che sono eterogenei, e la loro copertura da parte dell’ente pubblico, che invece deve e può solo essere omogenea. Questo è il motivo per cui i servizi sociali sono cerchiati da un alone di malcontento e da una bassa considerazione da parte dei cittadini».
La via verso il modello “civile”
Preso atto delle aporie del welfare state, si riesce a comprendere meglio l’interesse crescente per il modello di welfare civile. In quest’ultimo, spiega Zamagni, è «l’intera società, e non solo lo Stato, che deve farsi carico del benessere di coloro che in essa vivono». È evidente allora che occorra mettere in relazione le tre sfere di cui si compone ogni società: gli enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, enti parastatali), le imprese e la società civile organizzata (associazionismo di vario genere, cooperative sociali, organizzazioni non governative, fondazioni). Ma come fanno queste tre sfere a interagire fra loro? A suonare come un’orchestra e non come singoli strumenti? C’è un principio di cui il welfare civile ha bisogno per trovare applicazione concreta?
La risposta dell’economista che insegna a Bologna è la seguente: «Il principio è quello della sussidiarietà circolare. Le tre sfere devono darsi modi di interazione sistematica sulla base di pre-definiti protocolli sia nel momento in cui si progettano gli interventi che si ritiene di porre in campo sia nel momento in cui occorre provvedere alla loro gestione e erogazione». Si noti l’analogia: «Come il welfare capitalism postula il principio di restituzione e il welfare state quello di redistribuzione, così il welfare civile esige il principio di sussidiarietà circolare».
Non soltanto con questo modello si superano le due aporie del welfare state di cui si è detto, ma il welfare civile consente, in mancanza di fondi pubblici, di reperire le risorse necessarie dal mondo delle imprese. Osserva Zamagni: «Il punto è che sinora nessuno ha pensato di attingere alle risorse provenienti dal mondo delle imprese per incanalarle verso la fornitura di servizi di welfare. D’altro canto, la presenza dell’ente pubblico resta fondamentale in questo modello allo scopo di garantire l’universalismo, perché il pericolo dell’esclusione di alcuni gruppi sociali dalla fruizione dei servizi deve sempre essere tenuto presente. Infine, le organizzazioni della società civile, occupano un posto speciale nella sussidiarietà circolare in quanto portatrici sia di conoscenze specifiche (chi meglio di un’associazione di volontari può sapere se in un certo quartiere della città vi sono particolari bisogni da soddisfare?) sia di modi di governance capaci di elevare la qualità relazionale dei servizi erogati».
I quattro pilastri del nuovo welfare
Quali principi però devono sostanziare e guidare l’attuazione del modello di welfare civile che decollerà grazie al motore del Terzo settore? Zamagni ne indica quattro. Il primo è l’universalismo delle prestazioni. «Una democrazia stabile può sopravvivere solo se i suoi programmi di welfare si ispirano a principi di “generalità”: cioè di universalismo». Inoltre non ci deve essere discriminazione fra gruppi sociali, perché uno stato sociale discriminatorio favorisce lo spreco delle risorse e finisce con il frazionare la società erodendo quel patto di solidarietà che è il cemento di una democrazia stabile.
Il secondo principio è la centralità della persona: «Gli interventi in cui si sostanzia il welfare sono, per loro natura, indirizzati al sostegno e al rafforzamento di rapporti tra persone: medico-paziente; insegnante-studente; assistente sociale-emarginato (o anziano). Ciò comporta che non si possono soddisfare i bisogni delle persone in modo anonimo, prescindendo dalle loro preferenze e dalla trama delle relazioni che legano tra loro soggetti di domanda e di offerta». Non a caso, «il fruitore di tali servizi attribuisce importanza, e perciò un valore positivo, non solamente al soddisfacimento del bisogno che lo ha investito, ma anche ad outcomes quali il rispetto dell’autonomia e la qualità relazionale». Anche perché «se il soddisfacimento dei bisogni non avviene secondo modalità relazionali, non si crea benessere sociale. Anzi, essere assistiti ma non rispettati potrebbe aumentare il risentimento, vero e proprio tarlo della coesione sociale».
Terzo principio: il bene comune. Che non va confuso né con il bene privato, né con il bene pubblico. «Nel bene comune – dice Zamagni – il vantaggio che ciascuno trae per il fatto di far parte di una certa comunità non può essere scisso dal vantaggio che altri pure ne traggono. Come a dire che l’interesse di ognuno si realizza assieme a quello degli altri, non già contro (come accade con il bene privato) né a prescindere dall’interesse degli altri (come succede con il bene pubblico). Una distinzione chiarita da Hannah Arendt nel suo “Vita activa”. Per la filosofa e scrittrice tedesca, pubblico è “ciò che sta alla luce”: ciò che si vede, di cui si può parlare e discutere. «Ogni cosa che appare in pubblico può essere vista e udita da tutti».Invece privato è ciò che è sottratto alla vista. Comune è «il mondo stesso in quanto è comune a tutti e distinto dallo spazio che ognuno di noi occupa privatamente». «In quanto tale, comune è il luogo di ciò che non è proprio, e cioè il luogo delle relazioni interpersonali», precisa l’economista bolognese.
Se è vero che “nemico” del bene comune è chi si comporta da egoista puro, chi vive sulle spalle di altri (per esempio, l’evasore fiscale), è altrettanto vero che anche l’altruista puro, colui che annulla il proprio interesse in favore di quello altrui non è “amico” del bene comune. Chi è allora suo “amico”? Colui che si comporta ispirandosi al principio di reciprocità: ti do liberamente qualcosa affinché tu possa a tua volta dare, secondo le tue capacità, ad altri o eventualmente a me. Quarto principio è la sussidiarietà circolare. Ma quest’ultimo pone una domanda: a che serve la sussidiarietà circolare ai fini della implementazione del modello di welfare civile? Per rispondere, occorre prestare attenzione all’evoluzione, dal dopoguerra in poi, delle politiche dei vari servizi di welfare. E si possono distinguere tre fasi. Anzitutto la “Old Public Administration”, a partire dagli anni ’50, che aveva come obiettivo di «aumentare i livelli di efficienza delle organizzazioni pubbliche, dando maggiore autonomia ai dirigenti e responsabilizzandone il comportamento». Come? Attraverso regole, controllo e, soprattutto, gerarchia tenuti insieme dalla burocrazia. In secondo luogo, la fase che inizia negli anni ’70, la “New Public Management”: si inseriscono nelle organizzazioni pubbliche elementi di mercato, cioè la proprietà dei servizi di welfare rimane pubblica ma la gestione è di tipo privatistico per ottenere migliori livelli di produttività ed efficienza. Ed è in questo periodo storico che si è registrata la massima espansione degli enti del Terzo settore, grazie a convenzioni, gare al massimo ribasso, accordi di programma, piani di zona con le pubbliche amministrazioni.
Infine a cominciare dal nuovo secolo scatta la terza fase, la “New Governance Model”: «L’idea base – commenta Zamagni – è quella della co-produzione, secondo cui il fruitore è visto come un portatore di bisogni che non può essere privato degli attributi di cittadino. Il fruitore-cittadino è un soggetto che può esprimere il suo punto di vista circa il servizio e coopera per l’individuazione delle soluzioni migliori. Va sottolineato che mentre il passaggio dal primo al secondo modello non è stato quasi avvertito, essendo avvenuto in modo indolore, il passaggio alla co-produzione sta incontrando sacche di resistenza», sia per ragioni culturali e ideologiche, sia perché l’interazione fra i diversi stakeholder interviene in tutte e quattro le fasi del ciclo di produzione dei servizi di welfare: pianificazione, progettazione, erogazione e valutazione».
La triplice alleanza: pubblico, privato e civile
La transizione dal welfare state al welfare civile postula che si passi dal binomio “pubblico e privato” al trinomio “pubblico, privato e civile”, intervenendo con urgenza sull’assetto istituzionale a livello sia giuridico sia economico-finanziario. Infatti la distinzione, introdotta nella modernità, tra pubblico e privato non riesce più a far presa sulla realtà perché essa lascia fuori segmenti importanti della società. Su quale base poggia un tale assunto? Risponde Zamagni: «Sulla constatazione che il sistema politico non riesce più ad assolvere il compito della rappresentanza dell’intera area del sociale. Infatti, la crescita rapida del pluralismo sociale è oggi tale che gli individui non possono più dirsi rappresentati da una sola organizzazione, fosse pure un grande partito oppure un grande sindacato. È il fatto della pluriappartenenza, ossia che le persone nella società odierna possono scegliere la propria identità come risultato di appartenenze plurime, a far sì che il tradizionale sistema della rappresentanza non sia più sufficiente a coprire tutti gli ambiti in cui si esprime l’esistenzialità delle persone.
Posso anche aderire ad un partito politico ed essere iscritto ad un sindacato, ma questi due luoghi istituzionali non mi bastano più per dare piena espressione alla mia identità; oltre che piena tutela ai miei interessi». L’antropologo americano di origini indiane, Arjun Appadurai, ha definito la capacità di aspirare come la capacità delle persone di partecipare alla costruzione delle rappresentazioni sociali e simboliche che danno forma al futuro, ai progetti di vita. Un racconto dello scrittore britannico Bruce Chatwin indica come fare per coltivare questa capacità: uno schiavista bianco riesce a convincere i suoi schiavi neri ad accelerare l’andatura in cambio di denaro. Ma avvicinandosi alla meta, gli schiavi si fermano rifiutandosi di riprendere il cammino. Alla richiesta di spiegazioni per il loro comportamento, replicano: “Vogliamo dare tempo alle nostre anime di raggiungerci”. È proprio così, conclude Zamagni: «Nelle fasi di crisi, cioè di transizione, abbiamo bisogno di sostare un po’ per consentire al pensiero pensante di raggiungere (almeno) il pensiero calcolante».
(Tratto da numero 3 di Vdossier anno 2017)