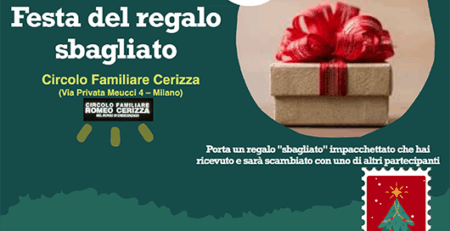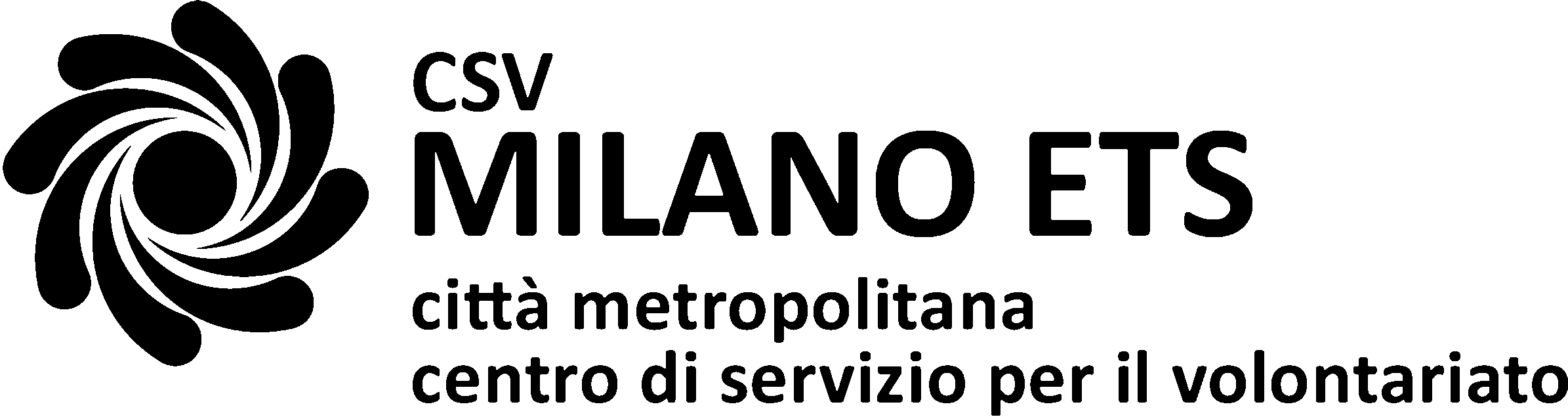Volontariato e parità di genere: il divario invisibile e la sfida dell’inclusione
Il volontariato riflette ancora disparità di genere: gli uomini dominano il volontariato formale, mentre le donne operano più spesso in ruoli informali e di cura. La leadership femminile resta limitata. Per diventare un motore di cambiamento, offrendo nuove opportunità e superando gli stereotipi di genere, servono azioni più inclusive e un maggiore equilibrio nella distribuzione dei ruoli.
di Elisabetta Bianchetti
Quando pensiamo ai volontari, immaginiamo persone altruiste di ogni età e provenienza, unite dal desiderio di aiutare. Eppure, dietro questa facciata di bontà collettiva, si cela un dato sorprendente: il volontariato non è affatto “neutro” rispetto al genere. In tutto il mondo, gli uomini e le donne partecipano in modo diverso alle attività volontarie, sia in termini di quantità che di modalità. Per esempio, gli uomini tendono a dominare il volontariato “ufficiale”, quello svolto attraverso organizzazioni strutturate, mentre le donne spesso operano lontano dai riflettori, nell’aiuto informale e quotidiano. Secondo l’ultimo rapporto delle Nazioni Unite, il 54% dei volontari formali a livello globale sono uomini, mentre il 53% dei volontari informali – quelli che aiutano in comunità senza far parte di enti organizzati – sono donne. In altre parole, le donne contribuiscono enormemente, ma in contesti meno visibili e meno riconosciuti. Complessivamente, se si sommano tutte le forme di volontariato, le donne costituiscono circa il 57% della forza volontaria mondiale, un dato che rovescia lo stereotipo secondo cui sarebbero gli uomini a “fare di più”. La realtà è più sfumata: dipende come e dove si guarda.
Questa tendenza globale trova conferma anche in Italia, dove il volontariato organizzato presenta un divario di genere. Secondo i dati ISTAT del 2021, nel nostro Paese operano circa 4,66 milioni di volontari attivi nelle organizzazioni non profit, un dato che rappresenta una flessione del 15% rispetto al 2015, con un calo più marcato tra gli uomini (-17,6%) rispetto alle donne (-13%). Dal punto di vista della distribuzione di genere, il 57,5% dei volontari italiani sono uomini e il 42,5% sono donne. Questi numeri smentiscono lo stereotipo secondo cui il volontariato sarebbe un mondo prevalentemente femminile e indicano una forte presenza maschile, soprattutto nei settori più strutturati come sport, protezione civile e cultura. Tuttavia, se si includono anche le forme di volontariato informale – come il supporto alle persone anziane, l’aiuto nei quartieri e le attività di cura – il contributo femminile diventa nettamente più elevato, seppur meno riconosciuto.
Ruoli tradizionali anche nell’aiuto: volontariato specchio della società
Perché le donne sono più presenti nel volontariato informale e gli uomini in quello formale? Le risposte affondano nelle dinamiche sociali e culturali. Spesso il volontariato riflette i ruoli di genere tradizionali: come nel mondo del lavoro retribuito, anche qui esistono “mansioni da donne” e “mansioni da uomini”. Studi internazionali mostrano che le donne tendono a impegnarsi come volontarie in ambiti sociali, sanitari e di cura – attività in continuità con i ruoli di caregiver che la società ancora si aspetta da loro – mentre gli uomini compaiono più spesso in settori politici, tecnici o emergenziali, assumendo ruoli operativi o manageriali.
Alcune situazioni estreme mettono in luce questi meccanismi. Un studio nella baraccopoli di Korogocho, in Kenya, ha rilevato che il 90% dei volontari comunitari nella sanità di base erano donne, proprio perché nella comunità si dà per scontato che siano le donne a prendersi cura dei malati. Al contrario, quando scoppia una crisi, come un’alluvione o un terremoto, spesso sono gli uomini a essere chiamati per primi come volontari “in prima linea”, mentre alle donne si riservano ruoli di supporto più defilati. Questo accade non perché manchino capacità o coraggio alle volontarie, ma a causa di stereotipi radicati: l’uomo forte che salva, la donna empatica che accudisce. Tali stereotipi possono limitare le opportunità di ciascuno. Per esempio, un ragazzo sensibile potrebbe sentirsi scoraggiato dal fare volontariato in un asilo o in un centro anziani (attività viste come “femminili”), mentre una donna determinata potrebbe trovare ostacoli impliciti nell’accedere a ruoli di leadership o di intervento tecnico in protezione civile. Non si tratta di una preferenza “naturale”, ma di un riflesso delle aspettative culturali: ciò che è considerato “appropriato” per ciascun genere.
Un altro fattore da non sottovalutare sono gli ostacoli pratici che colpiscono in modo diverso i generi. In molte società, le donne hanno meno tempo libero da dedicare al volontariato perché gravate dal lavoro domestico e di cura familiare non retribuito. Se una donna deve occuparsi dei figli, degli anziani in famiglia e della casa (spesso più di quanto faccia il suo omologo maschile), sarà più difficile per lei partecipare con regolarità alle attività di un’associazione o essere disponibile per turni di emergenza improvvisi. Questo porta molte a scegliere forme di volontariato flessibili e informali, compatibili con i ritagli di tempo, mentre gli uomini – meno vincolati da tali impegni nel privato – riescono più facilmente a ritagliarsi spazio per incarichi formali, corsi di formazione e posizioni organizzative. Colmare questo divario significa anche affrontare le disuguaglianze di genere nella vita quotidiana: più equilibrio nella suddivisione dei compiti familiari significherebbe più opportunità per le donne di partecipare attivamente nella società, volontariato compreso.
Va detto, infine, che il quadro non è uniforme ovunque: in alcune regioni del mondo le donne sono protagoniste assolute del volontariato formale. In America Latina, ad esempio, si stima che quasi due volontari su tre siano donne (67%), un primato mondiale, mentre in Asia e nel Pacifico la quota scende al 49%, cioè leggermente minoritaria. Ciò suggerisce che i fattori culturali contano eccome: dove è socialmente accettato (o incoraggiato) che le donne partecipino pubblicamente ad attività collettive, le vediamo emergere in massa anche come volontarie; altrove, restrizioni sociali o religiose possono frenare la loro presenza. Per esempio, in alcuni Paesi le donne possono essere più attive nel volontariato perché è uno dei pochi spazi consentiti fuori casa, mentre in altri incontrano barriere persino nell’offrire il proprio tempo gratuitamente. Il volontariato diventa così uno specchio fedele delle condizioni della donna nella società: evidenzia i progressi verso la parità dove ci sono, ma mette anche a nudo antiche disparità ancora da superare.
Questo fenomeno ha risvolti anche sulle opportunità di leadership all’interno delle organizzazioni di volontariato. In Italia, le donne rappresentano solo un terzo dei ruoli decisionali nelle organizzazioni non profit, una disparità che rispecchia il mondo del lavoro retribuito. Inoltre, il peso del lavoro di cura non retribuito incide sulle possibilità di partecipazione femminile: spesso le donne devono conciliare il volontariato con la gestione della famiglia, riducendo il tempo che possono dedicare ad attività strutturate e continuative.
Volontarie che cambiano le regole: quando aiutare significa emanciparsi
Detto questo, il volontariato non è solo un riflesso della parità (o disparità) di genere esistente: può diventare esso stesso un motore di cambiamento sociale e di emancipazione. In molti contesti, infatti, fare la volontaria ha permesso a donne di conquistare voce, rispetto e diritti che altrimenti sarebbero rimasti fuori portata. Le storie sul campo lo dimostrano meglio di qualsiasi statistica. Prendiamo il caso di un remoto distretto montano nell’Uttarakhand, nel nord dell’India. Qui un gruppo di donne ha deciso di trasformare il proprio impegno volontario in uno strumento di empowerment personale e collettivo. Organizzandosi in gruppi comunitari denominati “whole village groups” (gruppi di tutto il villaggio), queste volontarie sono riuscite a dialogare da pari a pari con i funzionari locali, a difendere i propri diritti e a farsi partner del cambiamento nella loro comunità. Attraverso semplici progetti – dall’alfabetizzazione delle ragazze alle iniziative contro la violenza domestica – le donne hanno acquisito nuove competenze, fiducia in se stesse e riconoscimento pubblico. In pratica, fare volontariato è diventato per loro un modo di “uscire di casa” in senso ampio: uscire dalla sfera privata e guadagnare uno spazio nella vita pubblica, in società dove spesso alla donna non è concesso occuparne. I risultati sono tangibili: in quei villaggi si è registrato un aumento della partecipazione femminile nelle assemblee locali e una diminuzione di episodi di violenza sulle donne, segno che quando le volontarie si fanno sentire, anche le mentalità attorno a loro iniziano a cambiare.Un altro esempio viene dall’Africa occidentale, dove il volontariato sta aiutando a ridefinire i ruoli maschili in funzione della parità. In Niger, dal 2004, sono nate oltre 137 “husband schools” (scuole per mariti) grazie a un progetto sostenuto dall’UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione). Il nome può far sorridere, ma l’obiettivo è serio: si tratta di gruppi di uomini volontari che si incontrano regolarmente per imparare e discutere di salute riproduttiva, diritti delle donne e uguaglianza all’interno della famiglia. Guidati da educatori, questi mariti-volontari si confrontano su temi come la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili, la pianificazione familiare, la violenza domestica. L’idea di fondo è che anche gli uomini possono – anzi, devono – essere volontari per la parità di genere, diventando alleati del cambiamento. E i risultati iniziano a vedersi: nelle comunità coinvolte, molti partecipanti alle “scuole” hanno cambiato atteggiamento, impegnandosi a sostenere le proprie mogli nell’accesso alle cure mediche e a promuovere comportamenti più equi nel quotidiano. Questo approccio innovativo riconosce che la parità non può avanzare senza il coinvolgimento attivo di tutti, donne e uomini. Gli esempi potrebbero continuare: dalla campagna “Saleema” in Sudan, dove volontarie e volontari hanno contribuito a ridurre significativamente le pratiche di mutilazione genitale femminile, ai progetti in America Latina in cui uomini giovani fanno volontariato come educatori tra i pari per combattere il “machismo” nei loro quartieri.
Ogni storia reale ci mostra come il volontariato può essere un laboratorio di cambiamento sociale. Donne che trovano nel servizio agli altri la forza per rivendicare un ruolo nuovo per sé, uomini che attraverso l’aiuto imparano a mettersi in discussione e a vedere nelle donne delle partner e non delle subordinate – piccoli grandi passi che sommano il bene immediato (il servizio reso alla comunità) a un bene più ampio (una cultura più inclusiva).
Verso un volontariato più inclusivo: che cosa si può fare?
Alla luce di tutto ciò, il volontariato emerge come un terreno di sfida ma anche di opportunità per la parità di genere. Cosa possiamo fare, concretamente, per rendere le attività volontarie più inclusive e paritarie? E come sfruttare il potenziale del volontariato per promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne, a beneficio di tutta la società?
Ecco alcune piste emerse dagli esperti e dalle organizzazioni internazionali.
Abbattere gli stereotipi nei ruoli: le organizzazioni di volontariato dovrebbero incoraggiare attivamente la partecipazione di uomini e donne in settori “non tradizionali”. Per esempio, promuovere più uomini nell’assistenza alla persona (ospedali, case famiglia) e più donne nei ruoli di coordinamento, protezione civile o interventi tecnici. Questo può avvenire attraverso campagne di sensibilizzazione mirate e programmi di mentoring che mostrino modelli alternativi (esempio: un uomo volontario in un asilo nido come figura positiva, una donna capo-squadra in un gruppo di protezione ambientale).
Favorire la conciliazione e l’accesso: per aumentare la partecipazione femminile, è cruciale rimuovere gli ostacoli pratici. Ciò può voler dire offrire orari flessibili, rimborsi spese per la babysitter o prevedere spazi di accudimento durante le attività di volontariato. Allo stesso modo, coinvolgere anche i più giovani e gli uomini nelle attività di cura (magari attraverso iniziative familiari o di team intergenerazionali) può ridistribuire il carico. In sostanza, bisogna costruire un ambiente in cui chiunque, indipendentemente dal genere e dai carichi familiari, possa dedicare tempo agli altri senza penalizzazioni.
Dare valore a tutto il volontariato: spesso solo il volontariato organizzato e visibile ottiene riconoscimenti, lasciando nell’ombra l’aiuto informale (dove, come abbiamo visto, operano molte donne). I decisori pubblici dovrebbero pensare a riconoscere e sostenere anche queste forme “invisibili” di volontariato. Come? Ad esempio creando registri o piattaforme dove anche i gruppi informali possano segnalare le proprie attività, oppure includendo chi fa volontariato informale in programmi di formazione, assicurazione o incentivi simbolici. Riconoscere il lavoro volontario di cura significa attribuirgli dignità e importanza, e può contribuire a bilanciare la percezione sociale di queste attività, oggi spesso date per scontate.
Aprire le porte della leadership: un volontariato paritario richiede non solo che uomini e donne siano presenti, ma che abbiano voce in capitolo alla pari. Le donne dovrebbero poter accedere in numero maggiore a ruoli decisionali all’interno di associazioni, comitati direttivi, coordinamento di progetto. Allo stesso tempo, gli uomini dovrebbero essere incoraggiati a partecipare alle discussioni sulle tematiche di genere e sulle strategie inclusive. Gli enti non profit possono adottare misure “sensibili al genere”, ad esempio prevedendo quote o obiettivi minimi di presenza femminile nei board, o formando tutti i volontari (uomini compresi) sulla prospettiva di genere. Secondo le Nazioni Unite, assicurare che le donne abbiano accesso ai processi decisionali nel volontariato è fondamentale per colmare le disparità esistenti.
Formazione e consapevolezza: infine, non si può migliorare ciò che non si conosce. Serve più ricerca e più dati disaggregati per genere nel mondo del volontariato. Istituti di statistica, università e centri studio dovrebbero raccogliere informazioni dettagliate su chi fa volontariato, dove e come. Avere numeri certi sulle differenze di genere (e magari sulle intersezioni con età, livello d’istruzione, etnia ecc.) aiuta a progettare interventi mirati. In parallelo, diffondere queste conoscenze tra i volontari stessi è importante: ad esempio organizzando workshop nei quali si discute di parità di genere, si condividono testimonianze e si fanno emergere pregiudizi inconsci. Un volontariato più consapevole è un volontariato più inclusivo.
In conclusione, la relazione tra volontariato e parità di genere è fatta di luci e ombre: se da un lato l’impegno volontario può riflettere e talvolta accentuare le disuguaglianze esistenti, dall’altro lato possiede un’enorme forza trasformativa. Immaginiamo una società in cui chi coordina una ONG smette di chiedersi se un compito sia “più adatto” a un uomo o a una donna, e inizia piuttosto a domandarsi come coinvolgere tutti al meglio. Immaginiamo reti di volontariato dove una madre di famiglia possa dare il suo contributo senza dover rinunciare a tutto il resto, o dove un ragazzo possa esprimere il suo lato empatico senza sentirsi “meno uomo”. Rendere il volontariato più inclusivo dal punto di vista del genere non è solo una questione di giustizia per i volontari stessi, ma un investimento sull’efficacia dell’aiuto che diamo alla comunità. Più prospettive diverse collaborano, più energie si liberano. Ma il cambiamento passa anche dalle scelte quotidiane di ognuno di noi: dall’aprire mente e cuore a nuovi modi di aiutare. In fondo, volontariato significa mettere in comune il proprio tempo e le proprie capacità per un bene collettivo. Assicurarsi che in questa comunione ci sia posto e valore per chiunque, senza distinzione di genere, è la strada per un volontariato davvero al servizio di una società migliore ed equa per tutti.
FONTI
United Nations Volunteers (UNV) – State of the World’s Volunteerism Report 2022
UNV Knowledge Portal – Gender and Volunteering
ISTAT – Censimento permanente delle istituzioni non profit, 2021
Toolkit on Gender and Volunteering, UNV 2021
Vdossier – Volontariato, Istat certifica la crisi ma i dati vanno letti con attenzione