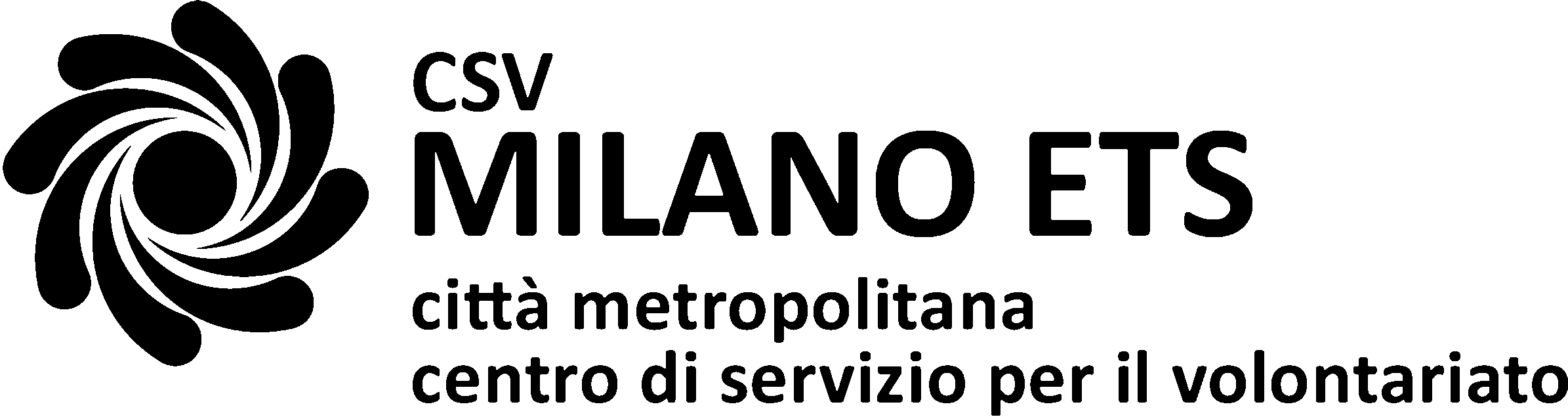Volterrani: le esperienze ci sono, ma serve un network 3.0 per la crescita territoriale
I progetti di sviluppo del territorio non sono esportabili, ma occorrono reti orizzontali per il confronto, l’accesso ai fondi e una crescita culturale
di Paola Springhetti
Ormai sono molti i progetti, sia all’interno della pubblica amministrazione che del non profit, che si autodefiniscono “di sviluppo territoriale”, tanto che a volte nasce il sospetto che si tratti di una etichetta di moda. Quali sono le condizioni perché siano veramente tali? E, soprattutto, in che modo possono fare network per crescere e incidere maggiormente? Ne abbiamo con Andrea Volterrani, docente all’Università di Roma Tor Vergata e presidente della Fondazione Fortes.
Ci sono molte esperienze che si definiscono di “sviluppo territoriale”. È un segnale positivo?
Prima bisogna definire che cosa si intende con “sviluppo territoriale”. Il rischio è che si collochi sotto questa etichetta il classico sviluppo economico, e quindi l’incremento del Pil di un territorio. Oppure c’è chi ci fa rientrare il marketing territoriale, e quindi le strategie di “vendita di un territorio”. Aggiungerei anche lo sviluppo sociale e quello culturale. In realtà i primi due approcci sono andati per la maggiore negli ultimi tempi e ho la sensazione che, nella stagione che stiamo vivendo, continuino ad essere in auge. Soprattutto la seconda prospettiva, negli ultimi tempi, ha fatto sì che moltissimi territori, piccoli o medio piccoli, abbiamo adottato piani di marketing territoriale legati soprattutto al turismo, ma sgancianti da ogni legame con lo sviluppo sociale e soprattutto da qualunque idea condivisa da chi quel territorio lo abita e lo vive. Hanno costruito strategie simulando la trasformazione del territorio in prodotto, ma questa è una stortura, perché il territorio non può essere solo un prodotto da vendere a chi lo vuole frequentare per motivi turistici o economici, di investimento. Un esempio ce lo dà l’Irlanda, che negli anni passati ha adottato una strategia di questo tipo per attrarre investimenti internazionali (penso alla Apple, che l’ha scelto perché c’era una tassazione irrisoria rispetto a quella imposta nel resto dell’Unione europea), che hanno però rischiato di determinare il fallimento sociale e culturale del Paese, che non riusciva più a sostenere questa ingombrante presenza di soggetti internazionali.
L’aspetto economico dello sviluppo, comunque, non va sottovalutato
Vero. Ma fare chiarezza su questo aspetto è importante, perché non è pensabile che si possa costruire un approccio al miglioramento del territorio solo in termini economici. L’economia, è rilevante e non va sottovalutata, però non deve diventare il fine. Se guardiamo alla nostra storia passata, troviamo l’esempio di Melfi. La Fiat ha investito lì anche perché su quel territorio della Basilicata era stata costruita un’idea di sviluppo economico, con cui lo stabilimento di Melfi sembrava coerente, perché avrebbe creato lavoro. Era particolarmente automatizzato e l’organizzazione del lavoro era costruita sui modi e sui tempi di Sesto San Giovanni, Milano, Torino… luoghi dove il fatto di lavorare per turni o di notte era parte di una cultura industriale ben radicata. Ma in Basilicata questa cultura industriale non c’è mai stata, perciò è vero che si sono creati molti posti di lavoro, ma l’impatto sociale è stato pesante. L’idea di sviluppo del territorio deve fare i conti con l’idea di sostenibilità, peraltro anch’essa molto abusata negli ultimi tempi, ma soprattutto deve fare i conti con l’attenzione alle caratteristiche sociali e culturali delle persone, che quel territorio abitano. Questo non significa che non bisogna mettere in campo azioni di sviluppo economico, ma che devono essere coerenti con il contesto.
Ha fatto esempi di esperienze di grandi dimensioni. Le esperienze piccole riescono a incidere sullo sviluppo del territorio?
A volte ci riescono, se sono esperienze diffuse, nel senso che, se riescono a coinvolgere la comunità, acquistano la capacità di sostenere il contesto territoriale specifico. Pensiamo agli alberghi diffusi, in alcuni contesti del Sud e non solo. C’è un’esperienza interessante in Palestina, a Betlemme, dove è stato creato un tipo di albergo diffuso che ha trovato le risorse per dare la possibilità, alle persone che vivono in quel contesto, di ristrutturare adeguatamente le proprie case e renderle accoglienti. Il percorso è stato costruito nel rispetto della cultura di quel territorio. Grandi cifre? No, in confronto alla Fiat di Melfi sono irrisorie. Qualcosa di analogo sta succedendo in alcuni territori che si trovano lungo la Via Francigena: questo percorso, e altri tradizionali dei pellegrinaggi a piedi, si stanno riscoprendo e valorizzando sotto diversi punti di vista. Ci sono territori che stanno lavorando non tanto per fare marketing territoriale, quanto per trovare risorse economiche integrative, che permettano questa valorizzazione nel rispetto del contesto locale.
Queste esperienze sono standardizzabili, esportabili?
Il problema è, che non c’è una ricetta che va bene in tutti i contesti, perché vanno costruite delle strategie ad hoc, pensate per quello specifico contesto. Il termine di riferimento è un concetto costruito dai latini: il genius loci, un concetto che ha a che fare con l’anima profonda del territorio. Che non è quella economica, ma quella culturale e sociale. È una storia di lungo, lunghissimo periodo, che va ricostruita, compresa e valorizzata, e che ogni territorio, piccolo o grande che sia, ha. È su quella che va costruito lo sviluppo territoriale. Naturalmente, bisogna lavorare anche per cambiare alcuni aspetti del genius loci, ma in ogni caso, se non ne tengo conto, se non riesco a comprenderlo, va a finire che mi limito ad appiccicare sui territori idee che vanno bene per altri contesti, dando per scontato che alcune cose vadano bene comunque e dovunque.
Dunque si può portare cambiamento. C’è bisogno di innovazione anche là dove si vogliono rispettare identità e culture?
Oggi sembra che se non c’è innovazione, anche sociale, non c’è sviluppo. Nell’immaginario collettivo c’è l’idea che l’innovazione è sempre positiva Ma che cosa vuol dire innovazione sociale? Ed è sempre vero, che quello che è nuovo è positivo rispetto al contesto? Spesso si fanno passare per nuove cose che non lo sono, ma, anche quando lo sono, non si fanno mai, né da parte della pubblica amministrazione, né da parte del Terzo settore, le valutazioni di impatto. E per valutazione di impatto non intendo quella prevista della legge 106, che è una valutazione ex post, e quindi spesso costringere a prendere atto in un fallimento ormai avvenuto. Parlo di valutazione preventiva: oggi si possono costruire degli strumenti che consentono di fare previsioni.
Ma insomma, ci sono realtà, esperienze che si collocano a pieno titolo nella prospettiva dello sviluppo territoriale?
Ci sono già molte esperienze che vengono raccontate come elemento decisivo dello sviluppo del territorio: quelle che riguardano le imprese ibride, ad esempio (ricordo il libro di Flaviano Zandonai e Paolo Venturi, “Imprese Ibride. Modelli di innovazione sociale per rigenerare valore”, edito da Egea), le cooperative di comunità e alcune forme di mutualità territoriale. In alcuni di questi casi direi che, più che di sviluppo territoriale, è necessario parlare di “sviluppo di comunità”, comunque sono tre strade, che a volte si intrecciano e altre volte sono specifiche di territori diversi. Sono soggetti nuovi, attenti allo sviluppo di comunità prima di tutto, ma anche a quello economico e a quello del welfare generativo. In fondo, anche il welfare generativo resta uno slogan, se poi non trovi le risorse per svilupparlo. Le esperienze citate tentano appunto di rispondere a questa esigenza: dove si possono trovare anche risorse aggiuntive per modificare la comunità? Sono esperienze diffuse in tutta Italia, anche se è evidente che, dove tradizionalmente esisteva una cultura imprenditoriale, sono più sviluppati i soggetti ibridi, dove invece era più rilevante il legame comunitario e sociale sono cresciute maggiormente le cooperative di comunità e la mutualità territoriale. Ancora non so se avranno successo o meno: è presto per fare una valutazione corretta. Ma è interessante seguire queste esperienze, dove le organizzazioni di volontariato e di Terzo settore a volte hanno un ruolo, altre volte invece sono un po’ a traino, perché purtroppo sono troppo attente a quello che hanno fatto fino ad ora, senza riuscire a cogliere quello che sta cambiando nelle comunità. Il cambiamento c’è stato, c’è, probabilmente ci sarà, ma viene colto solo parzialmente.
Questo smentisce un’affermazione comune nel mondo del volontariato: che cioè le associazioni sono le prime ad accorgersi dei nuovi bisogni e dei cambiamenti, proprio perché radicate nei territori.
Non bisogna generalizzare, ma ho visto tante situazioni, in cui le organizzazioni non hanno la minima idea di quello che avviene sul territorio. In genere è perché si pensano solo come erogatrici di servizi e quindi per la loro sopravvivenza devono far sì che questi servizi continuino nel tempo. Che poi abbia senso o non abbia senso per la comunità, non se lo chiedono.
Cosa manca a queste associazioni?
Un vero radicamento, inteso come capacità di cogliere davvero quello che la comunità sta diventando. In altre parole, la capacità di ascolto e analisi. Non hanno tempi e modi per fermarsi a riflettere. Ma quando un’organizzazione non riesce a darsi il tempo della riflessione, entra nella prospettiva economicistica, oppure chiama “sviluppo territoriale” quello che è semplicemente sviluppo di servizi.
Però se un’associazione da vent’anni tiene aperta una mensa o tiene puliti i parchi cittadini, come si può dire che non contribuisce allo sviluppo territoriale? Può esserci questo sviluppo senza i servizi?
Ma se ti limiti ai servizi la tua capacità di far crescere lo sviluppo del territorio resta marginale. Faccio la mensa e tengo pulito il parco, ma non mi pongo il problema di qual è il motivo per cui da vent’anni i poveri che vengono alla mensa sono sempre gli stessi, e il parco è sempre sporco anche se lo ripulisco tutti i giorni. Cosa faccio perché cresca la consapevolezza, si sviluppi una coscienza collettiva, nella comunità, della necessità di prendersi cura di quel parco? Se fai solo servizi pensi di essere centrale (se non ci fossi tu come farebbero? ti danno pure la medaglia!), ma sei marginale, anzi, funzionale al mantenimento dello status quo.
I progetti di sviluppo territoriali sono strettamente legati ai territori. Quindi sono condannati alla frammentazione?
Se devi essere legato a un territorio devi poterti muovere in autonomia, questo è evidente. Ma non sei condannato alla frammentarietà. Rispetto alla progettualità, uno dei problemi è che esistono pochi luoghi – nonostante viviamo nel tempo delle piattaforme, delle app e dei social – che consentano di osservare e analizzare le esperienze degli altri. Non perché si possa copiare l’esperienza di un altro territorio, ma perché le idee, i processi, le difficoltà incontrate dagli altri sono interessanti. La possibilità di comparazione tra esperienze sarebbe già un passo in avanti importante, poi viene la possibilità di fare network. Soprattutto tra le realtà più piccole, fare network sarebbe interessante anche per accedere a finanziamenti più ampi, come quelli europei. Le esperienze spagnole, dall’Andalusia alla Catalogna, insegnano che questo è l’elemento vincente oggi, e lo è stato nel passato, per accedere a finanziamenti europei molto consistenti. Purtroppo, dobbiamo ammettere che, nell’era del web 3.0, non ci sono luoghi di condivisione orizzontale deputati a questo. Si parla di frigoriferi che comunicano con le aziende produttrici, ma non c’è un internet dello sviluppo territoriale.
Perché è così difficile costruire strumenti per fare network?
Un po’ c’è il fatto che ognuno è geloso della propria idea e del proprio progetto, e un po’ i finanziamenti sono verticali, mentre lo scambio è orizzontale. Faccio un esempio su un altro tema: la questione del budget di salute. Riuscire a mettere insieme un budget salute, vuol dire mettere insieme risorse frammentate che vengono da diversi enti pubblici e anche privati: la difficoltà sta nel costruire orizzontalità, quando i finanziamenti sono verticali e questo intralcia la costruzione di una dimensione orizzontale. Lo stesso succede con lo sviluppo territoriale: i finanziamenti sono verticali. Tra l’altro, qualche volta è vero che mancano le risorse, ma altre volte ci sono, ma non sono coordinate tra i territori. Perciò andrebbe costruita orizzontalità anche tra le fonti di finanziamento, almeno quelle nazionali.
Chi dovrebbe assumersi questo impegno?
Ci vuole sempre qualcuno che innesca il processo. In questo caso, tra l’altro, l’impegno è su due piani: consapevolezza e formazione da una parte e supporto all’azione dall’altro. Un soggetto nazionale? A volte è troppo lontano per poter essere realmente di supporto sui territori. I Centri di servizio per il volontariato? Mi sembra che al momento non tutti hanno le caratteristiche per supportare un percorso di questo genere: dovrebbero innanzitutto fare un percorso di formazione interna. Le reti di secondo livello, visto anche il ruolo che attribuisce loro la riforma del Terzo settore? Forse si, ma anche soggetti che si aggregano sul territorio, a volte con grande fatica. Sono tre strade che si potrebbero intrecciare tra loro.
E la pubblica amministrazione?
Indubbiamente c’è un pezzo di questo ragionamento che riguarda la Pubblica Amministrazione e gli enti locali. Anci qualche cosa fa, ma in modo ancora verticale… Gli Enti locali dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale, ma anche qui manca formazione e consapevolezza. Ci sono alcune esperienze, interessanti. Ad esempio a Verona, dove nelle periferie hanno cominciato a sperimentare un percorso di sviluppo di comunità, interessante perché è un lavoro integrato fra Terzo settore ed ente locale, e qualche risultato lo sta dando: segna una una doppia crescita, del Terzo settore e dell’ente locale. Ci vuole tempo, e questo è un problema: queste cose non si possono fare velocemente. Ma soprattutto c’è da cambiare la cultura dell’ente locale: questa è una grande sfida, che nessuno vuole affrontare. Se crescono esperienze come le cooperative di comunità, le imprese ibride e la mutualità territoriale, e non cresce l’ente locale, si crea uno scollamento pericoloso.
(Tratto da numero 1 di Vdossier anno 2017)