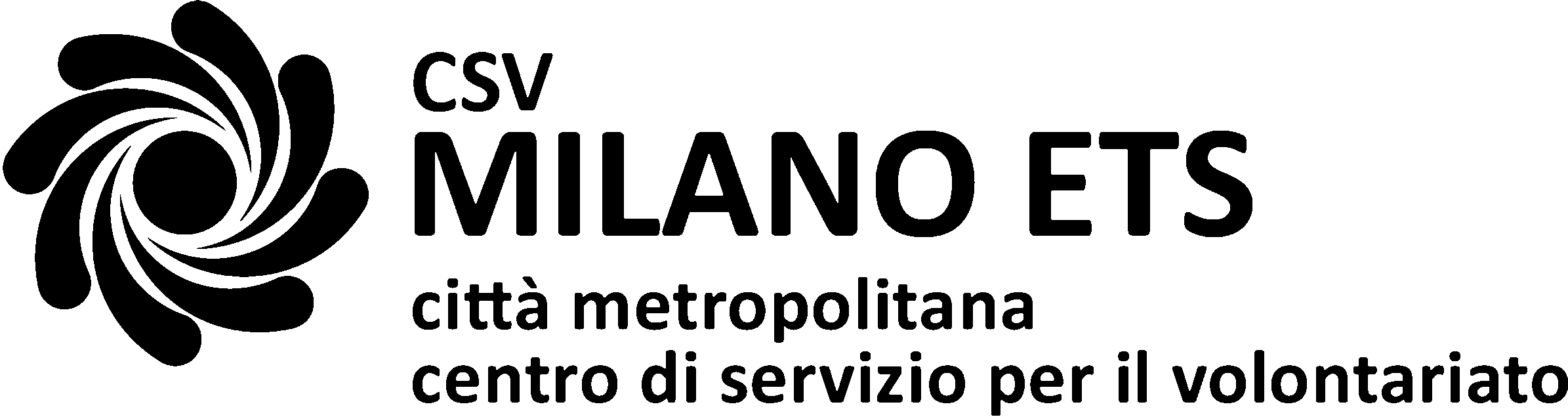Zamagni: I corsi? Non bastano più. Ora servono vere scuole per selezionare i volontari
MIlano, maggio 2010 – Sale in cattedra il professor Stefano Zamagni. E la sua lezione sulla crisi, il volontariato e il suo futuro ha lo stesso effetto di un fiume in piena. Un fiume gonfio non d’acqua ma di idee, tanto che l’economista bolognese, “mente scientifica” di Aiccon (Associazione Italiana per la Cultura Cooperativa e delle Organizzazioni Non Profit), straripa ragionamenti e riflessioni in un giro d’orizzonte a trecentosessanta gradi. Eppure c’è un filo che lega il flusso del suo pensiero e che si può tentare di riassumere in un appello di quattro parole: «Occorre cambiare il volontariato».
Prima però di illustrare la sua “rivoluzione culturale”, prima di invitare le associazioni ad avere il coraggio di guardarsi allo specchio e non risparmiarsi una dose di autocritica, prima di consigliare alle organizzazioni un autentico esame di maturità e una maggiore impegno nella formazione, il professor Zamagni congela momentaneamente la sua ricetta per una nuova primavera del volontariato e si concentra ad analizzare l’inverno della crisi, che continua a mordere non soltanto il mondo dell’economia, della finanza e del lavoro, ma anche l’universo del volontariato italiano, lombardo e milanese. «Anzitutto per parlare della crisi serve fare una distinzione – spiega Zamagni -. Perché ci sono due tipi di crisi che, grosso modo, è possibile identificare nella storia delle nostre società: una dialettica, l’altra entropica». Cominciamo con il circoscrivere e il definire la crisi dialettica. È quella che nasce da un conflitto che prende corpo dentro una determinata società e che contiene, al proprio interno, i germi o le forze per proprio superamento. Va da sé che non necessariamente l’uscita dalla crisi rappresenta un progresso rispetto alla situazione precedente.
Quali esempi si possono citare nella storia di crisi dialettica?
La rivoluzione americana, la rivoluzione francese, la rivoluzione dell’ottobre 1917 in Russia.
Tornando alla crisi entropica invece…
Entropica è invece la crisi che tende a far collassate il sistema per implosione, ma senza modificarlo. E la crisi attuale è di questo secondo tipo, cioè entropica. Questo tipo di crisi si sviluppa ogniqualvolta la società perde il senso – cioè, letteralmente, la direzione – del proprio incedere.
Anche di tale tipo di crisi immaginiamo che la storia ci offra degli esempi?
Sì. Ci offre esempi notevoli: la caduta dell’impero romano, la transizione dal feudalesimo all’età moderna; e con un salto nel Novecento: il crollo del muro di Berlino, il dissolvimento dell’impero sovietico.
Come giudicare, invece, la crisi economico- finanziaria del 1929…
No. La crisi attuale non è assolutamente corretto assimilarla – se per non gli aspetti meramente quantitativi – con quella che scosse il mondo nel 1929. Quella fu piuttosto di natura dialettica e non entropica, in quanto fu causata da errori umani commessi, soprattutto dalle autorità di controllo delle transazioni economiche e finanziarie, conseguenti a un preciso deficit di conoscenza circa i modi di funzionamento del mercato capitalistico.
Scusi, ma perché è importante ri-marcare questa distinzione fra crisi dialettica e crisi entropica?
Perché sono diverse le strategie di uscita dai due tipi di crisi. Non si esce da una crisi entropica con aggiustamenti di natura tecnica e con provvedimenti legislativi o regolamentari anche se necessari. La crisi entropica, come dicevo, è la conseguenza della perdita di senso, quando cioè la società perde il senso del proprio esistere, del proprio operare, allora entra appunto in crisi.
Dunque sembrerebbe di capire che la crisi entropica sia più difficile da risolvere della crisi dialettica.
Certamente. Perché nella crisi dialettica una volta composto il conflitto, per esempio il conflitto di classe – prendiamo quello lavoratori- industriali -, allora si riparte. Invece dalla crisi entropica, come quella attuale, l’uscita sarà molto più lunga, perché bisogna cambiare il modo di pensare, cioè le mappe cognitive delle persone, della gente comune, delle famiglie. Questo è il vero problema. Mentre da una crisi dialettica se ne esce mettendo attorno a un tavolo i rappresentanti dell’una e dell’altra parte per trovare un accordo, per la crisi entropica non è così facile. Per esempio, quando in Italia ci fu l’accordo sul punto unico della contingenza, oppure sulla scala mobile che successe? Accadde che i sindacati e Confindustria, dopo un’estenuante trattativa, alla fine raggiunsero un’intesa e il resto poi seguì.
Il suo ragionamento lascia intuire che con una crisi entropica questo modus operandi non è possibile.
No. Perché investe l’intera cultura popolare, compreso anche il volontariato. Quindi quella che viviamo oggi è una crisi che non riguarda solo l’alta finanza, ma semmai è partita dall’alta finanza e ci è cascata addosso. E questo evidentemente ci fa capire perché servirà parecchio tempo perché si possa dire che la crisi sia superata.
Che cosa fare allora? Come superare questa sorta di Scilla e Cariddi?
Bisogna che la gente torni a calzare nuovi occhiali con cui guardare la realtà. Anche nella galassia del volontariato: questa crisi ha fatto credere
al volontariato che il suo ruolo è quello di essere stampella della società. Siccome c’è la crisi, siccome c’è la gente che soffre, c’è della gente che è in difficoltà, allora il volontariato deve intervenire e fare la croce rossa sociale. Ma questo è uno snaturamento del volontariato, perché per la croce rossa sociale c’è già la Protezione civile. Per cui non è compito del volontariato fare questo. Eppure, ormai, questo messaggio si è diffuso nell’opinione pubblica; nei mass media è passata questa idea. C’è l’emergenza terremoto, c’è lo tzunami, la risposta arriva dal volontariato, come se il volontariato fosse una Protezione civile a basso costo per risolvere questi problemi.
Ma la natura del volontariato non è questa?
Certo che no! La natura del volontariato è quella di diffondere nella società l’idea del legame sociale e, soprattutto, di diffondere il principio di reciprocità, cioè educare alla reciprocità. Il volontariato non deve essere la manovalanza delle situazioni emergenziali. Attenzione però: non voglio dire che non lo debba fare. Ma un conto è dire che lo si fa, appunto, nelle emergenze, di tanto in tanto; un conto è ridurre la funzione a questo.
La crisi, però, ha fatto scoppiare tutta una serie di nuovi problemi sociali. È evidente che il volontariato si è mobilitato su questo fronte. Le nostre organizzazioni sono state risucchiate da questi problemi e il rischio è che così facendo perdano la propria bussola. Perché c’è il grosso pericolo che, quando fra uno, due, tre anni la crisi sarà definitivamente superata, la gente comune non saprà più che farsene del volontariato. E allora lo scaricherà. Ecco perché personalmente sono preoccupato, perché il rischio che si corre è esattamente quello della irrilevanza. Infatti alla Protezione civile succede così: quando finisce l’emergenza chi si ricorda più della Protezione civile? Nessuno, fino alla prossima emergenza, al prossimo terremoto nessuno più si ricorda. Ora ridurre il volontariato a una sorta di Protezione civile sociale è un errore gravissimo.
Quali strategie mettere a punto e adottare, come far sì che le nostre associazioni di volontariato non scivolino in queste sabbie mobili e riescano a dribblare questo rischio che lei adombra all’orizzonte?
Il problema è quello di non ridurre l’agire del volontariato soltanto agli sms che adesso vanno di moda; e di far credere ai volontari che quella è la loro mera funzione.
Ma questa è un’eccezione che durerà quel tanto che deve durare. Non è questo il nostro compito?
No, assolutamente no. Per essere più chiari: è ovvio che se c’è un’emergenza bisogna spegnere il fuoco. Facciamo anche un esempio per evitare fraintendimenti: io faccio il professore, ma quando a casa c’è da far da mangiare, lo faccio io. Ma se uno mi dovesse dire “tu fai da mangiare sempre”, rispondo no, perché tradirei la mia vocazione, che è quella di fare lo studioso e non il cuoco. Certo questo non esclude che cucini, quando ci sia da cucinare, non mi vergogno e anzi sono ben lieto di farlo. Ma non è la mia attività, non è la mia inclinazione. La stessa cosa vale per il volontariato: è ovvio che di fronte all’emergenza si deve intervenire, però un conto è dire questo e un conto è che quella sia la funzione del volontariato. Se così fosse il volontariato tradirebbe quello che è il suo mandato. La missione del volontariato non è quella di sostituire oppure di scalzare la Protezione civile. Non per nulla, se andiamo in tutti i Paesi del mondo, notiamo che c’è la Protezione civile e dipende dal Governo, non è una iniziativa spontanea della società civile, come invece lo è il volontariato tout court.
Cosa deve fare allora in concreto il mondo del volontariato milanese per non tradire la sua attitudine?
È semplice. Non dovete stancarvi di ripetere questi concetti. Di più: dovete scriverli, avete il dovere di sottolinearli nelle vostre dichiarazioni. Perché, a volte, vi dimenticate. Date per scontate queste riflessioni che ovvie non lo sono. Dovete ogni volta che intervenite nelle emergenze dire che questa è una situazione emergenziale: noi interveniamo perché siamo persone responsabili, però non è questa la nostra vocazione. Perché la nostra vocazione è quella di diffondere il principio di reciprocità e creare legami sociali. Questa è la missione specifica del volontariato. Non è quella di sostituire né l’ente pubblico né l’ente privato.
In sostanza, il suo invito è quello che le nostre associazioni non si stanchino di annunciare la loro missione.
Basta dire che l’emergenza è l’eccezione che non è la vostra missione. Perché il vostro mandato è quello di lavorare giorno per giorno negli ambienti di vita dove operate perché si diffondano i legami sociali. Come farlo, dipende poi dalle capacità dei singoli e dalle specificità delle singole associazioni. Per esempio, un’organizzazione opera in un quartiere di Milano, oppure in una grande comune dell’hinterland, oppure ancora in un piccolo paese di provincia, ecco che allora cambiano le forme di operare, ma il principio non muta. Piuttosto cambiano i modi per realizzare il legame sociale e per realizzare la cultura della reciprocità, ma l’obiettivo resta lo stesso.
Alla luce di questa riflessione, secondo lei, di che cosa ha bisogno soprattutto il volontariato oggi?
Di una cosa semplicissima, ma allo stesso tempo molto impegnativa. I volontari bisogna mandarli a scuola di reciprocità. Che vuol dire? Significa che non si può pensare che un’associazione di volontariato sia basata soltanto su uno spontaneismo di tipo emozionale. Ecco perché ai volontari bisogna fare lezione. Io faccio sempre questo esempio: a chi vuol diventare prete lo si fa studiare sei o sette anni in seminario; gli insegnano teologia, filosofia, psicologia, esegesi ecc. Con ciò intendo rimarcare che non basta che una persona affermi “io ho la vocazione di fare il prete e mi fate diventare prete”. Così come non può essere sufficiente che una persona dica “io ho la vocazione di fare e lo faccio”. Questa è una strada di corto respiro. Se vuoi fare davvero il volontariato devi metterti a studiare. Cosa vuol dire studiare? Non vuol certo dire studiare per superare l’esame, ma significa acculturarsi. Purtroppo ci sono dei volontari che ancora confondono il principio di reciprocità con il principio dello scambio; che non sanno distinguere tra dono come regalo e dono come gratuità, eccetera.
Lei dipinge un quadro nero. La situazione sembrerebbe grave. In altri Paesi non è cosi?
Oggi c’è troppa informazione e c’è una carenza gravissima di educazione. L’informazione è utile, ma non basta. Se una persona vuole far parte di un’associazione, bene, sappia che deve accettare di tornare a “scuola”; una scuola ovviamente “sui generis”. Sono fermamente convinto che occorre che i volontari si mettano a “studiare”, a pensare, che frequentino certi ambienti. Dopotutto è quello che si è sempre fatto in ambito partitico, associazionistico, politico. Si è sempre fatto così, perché non si è parte di un qualsiasi ente se non si ha la conoscenza dei fondamenti ad ampio raggio. La stessa cosa deve valere per il volontariato.
Chi è allora il vero volontario: è anzitutto una persona che si sottopone a un massiccio programma di studio?
Sì. Perché se non si studia non ci può essere capacità di educare alla reciprocità. Solo attraverso lo studio le persone diventano libere. Libere dall’ignoranza, dal condizionamento, dalle manipolazioni. Io ho iniziato a fare volontariato all’età di 14 anni. La mia fortuna è stata quella di avere avuto maestri che mi hanno insegnato a studiare. Oggi occorre avere il coraggio di porre le seguenti condizioni: sei libero di entrare in questa associazione, però sappi che devi studiare. Invece, purtroppo, stà passando l’idea secondo cui le associazioni debbano prendere chiunque. Questa è la distruzione del volontariato.
Eppure a Milano è ormai attivo da anni un ventaglio di corsi di formazione per i volontari.
Vanno bene. Ma non bastano. I corsi di formazione insegnano le cose base, come quando si va a prendere la patente. Sono soltanto l’abc. Non sto dicendo che non ci vogliono, sostengo che non sono sufficienti. Io parlo di scuola vera e propria. Una volta i partiti, fino a circa 20 anni fa, avevano le scuole di partito. Quando le hanno chiuse si è vista la degenerazione che ha assunto la politica. Allora il volontariato deve fare le sue scuole, perché solo così viene fuori la nuova leadership.
Le persone oggi sono disposte a investire le proprie energie in questo tipo di percorso?
Sicuramente. E lo posso dire con certezza, perché per ragioni professionali giro parecchio l’Italia. Sostengo da tempo che se si facessero scuole vere e proprie di volontariato arriverebbero in tanti. Tenete conto che sono molte le persone dotate e generose che purtroppo rimangono deluse dalle esperienze che hanno vissuto nelle associazioni. Bisogna evitare che nel volontariato si inneschi un processo di selezione avversa, un processo che tende ad attrarre solamente i meno dotati sotto il profilo intellettivo. Basta pensare al volontariato come una sorta di “dopolavoro ferroviario” dove la gente va, parlotta, fa qualcosa pure di buono ma senza una strategia precisa. Oggi più che mai, in un mondo sempre più complesso, dobbiamo ritornare a un concetto forte e alto di azione gratuita.
Queste sue tesi nascono dalla sua esperienza a capo di un’ONG a livello mondiale con sede a Ginevra la ICMC (International Catholic Migration Commission)?
A Ginevra chiamavamo i maggiori esperti a livello mondiale e le persone venivano e si “divertivano” e, soprattutto, venivano considerate e apprezzate per le loro caratteristiche. I volontari hanno sete di conoscenza, la chiedono. E non si può non offrirgli nulla. Anche la gente comune ha fame di conoscenza. Prendiamo in considerazione le università della terza età, sono piene di persone. Questo vuol dire che c’è domanda di conoscenza e quindi occorre soddsfare questa richiesta. Bisogna ricordarsi che la forma più alta di carità – come ricordava Antonio Rosmini – è la carità intellettuale: far arrivare all’altro – soprattutto al povero, all’indifeso, all’umile – un pensiero che sappia indicargli una via. Nel nostro Paese, la fame più preoccupante, oggi, non è quella di pane, ma di pensiero.
Ma ci sarebbero docenti disposti a impegnarsi in queste scuole, disposti a fare un percorso con i volontari?
Se ci fosse questo tipo di richiesta sono convito che sarebbero molti quelli disposti a mettersi in gioco. Ma se non c’è la domanda mai ci sarà l’offerta. I Centri di servizio potrebbero essere i primi e più importanti aggregatori di una tale domanda. Nella Caritas in veritate, Benedetto XVI ha scritto: “Il mondo oggi soffre della mancanza di pensiero”. Mica ha scritto “mancanza di risorse!”. Come sappiamo c’è il pensiero calcolante e il pensiero pensante. Noi difettiamo, oggi, del secondo; è del pensiero che dà la direzione, cioè del pensiero pensante, che c’è oggi grande bisogno. E questo vale anche per il volontariato: la expertise, la professionalizzazione, e l’acquisizione di tecniche organizzative raffinate vanno certamente bene , ma quando tutto ciò avviene a spese del pensiero pensante, le degenerazioni sono dietro l’angolo. E infine, ma non da ultimo, nell’universo del volontariato c’è da affrontare il problema delle pari opportunità…
Cioè anche nelle associazioni, come in politica, bisogna aprire alle quote rosa?
Rispondo anzitutto con un quesito: perché nel volontariato i dirigenti sono in prevalenza uomini? In Norvegia nel 2006 è stata approvata una legge che obbliga le imprese private quotate in borsa a destinare almeno il 40% dei posti del Consiglio di Amministrazione alle donne. Sarebbe una bella rivoluzione se una norma sociale del genere fosse inserita negli statuti delle organizzazioni di volontariato.